Estetica, percezione sensoriale e rappresentazione nell'arte, Università
Documento dall'Università su "Primo libro di estetica-Pinotti". Il Pdf esplora l'estetica, la percezione sensoriale e la rappresentazione nell'arte, analizzando concetti filosofici da Shusterman a Kant. Il Pdf di Filosofia discute la riproducibilità delle opere d'arte e la loro autenticità, con riferimenti a NFT e all'aura di Benjamin.
See more26 Pages
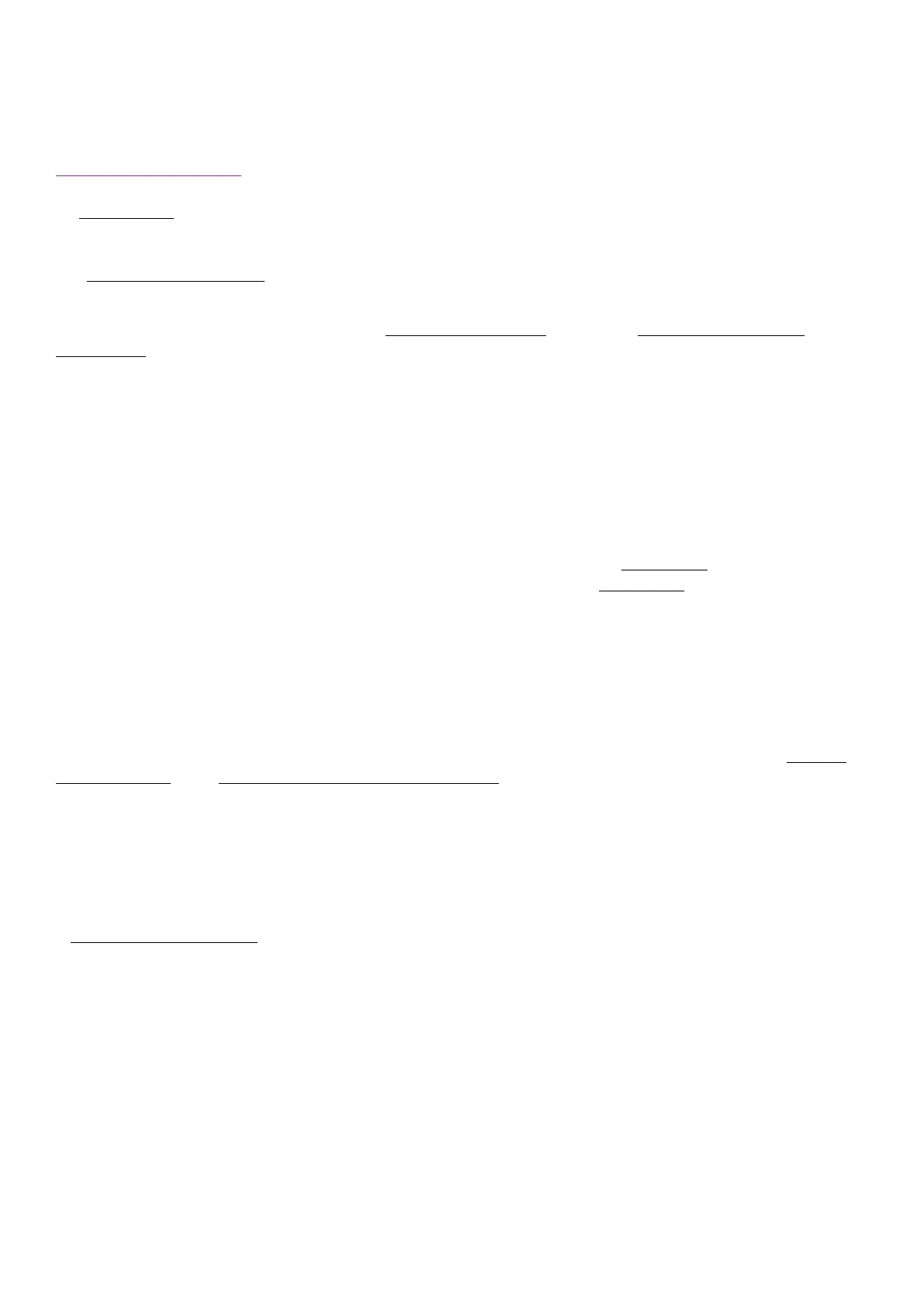
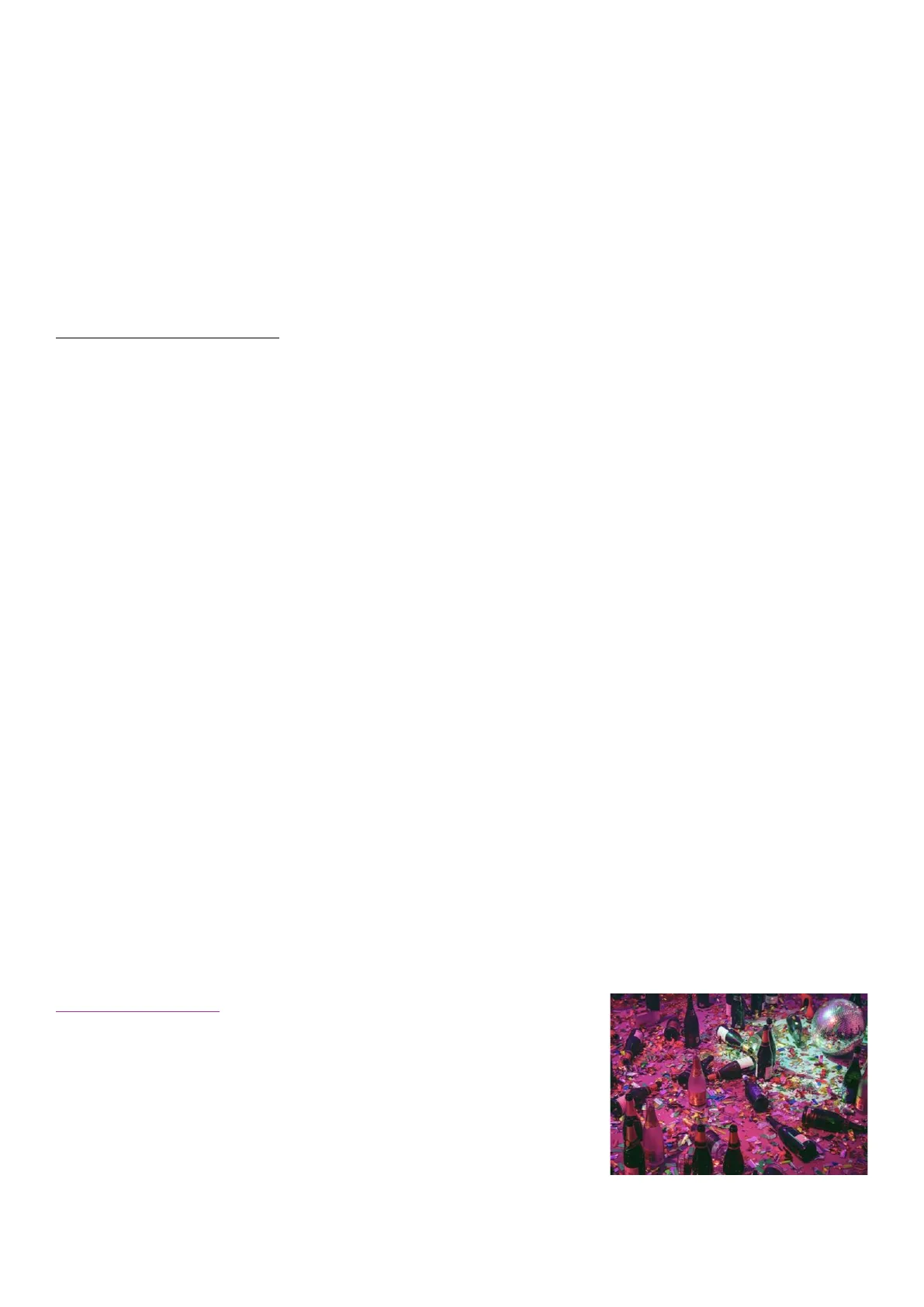
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Aisthesis - Pietro Conte
La somestesica corrente filosofica fondata da Shusterman, esamina il corpo inteso non solo come fisico con determinate qualità sensibili, ma anche come soggettività che percepisce queste qualità e affina le proprie capacità percettive. La somestesica ha dunque a che fare con il corpo e con la sfera sensibile dell'esperienza. È una teoria della percezione (percettologia) radicata nel pensiero di Baumgartner che segnerà la nascita dell'estetica come disciplina filosofica autonoma.
Baumgartner prospettava la possibilità di una scienza del sensibile analoga alla scienza dei contenuti intellettuali, ossia la logica. Questa scienza del sensibile fondata da Baumgartner è un campo che molti pensatori passati ritenevano troppo caotico per essere definito in concetti e leggi. Il passo successivo fu la distinzione tra rappresentazioni estetiche (sensazioni) e rappresentazioni noetiche (intellettuali), con una visione che valorizzava la percezione come atto cognitivo.
Plotino pensa che le idee pure, perfette, esistano in un regno ideale, ma quando queste idee entrano in contatto con il mondo materiale (cioè il corpo e i sensi), si "contaminano" e diventano solo opinioni, quindi meno pure e perfette. La metafora dell'anima (sema) prigioniera del corpo (soma) esprime l'idea che il corpo e i sensi siano qualcosa di "peccaminoso", che impedisce all'anima di accedere completamente alla verità e alla perfezione delle idee pure.
Baumgarten fa una distinzione fondamentale tra sensazione e percezione: la sensazione si collega con la passività, la singolarità e la soggettività, anche fisiologica ("sento caldo"); la percezione al contrario fa riferimento a un ruolo attivo del soggetto, che elabora le sensazioni attribuendole all'azione esercitata sul corpo da un oggetto esterno ("percepisco il calore del fuoco").
Nel voler dare un valore cognitivo alla percezione Baumgarten ha in mente la tradizione filosofica di Leibniz. Leibniz sostiene che l'anima è costantemente attiva e affollata da percezioni non sempre distinte tra loro, ma al contempo assolutamente chiare: si può capire che un fiore sia una rosa senza conoscerne le caratteristiche essenziali.
Kant ampliò l'idea di una scienza sensibile nella "Critica Della Ragion Pura" intitolando la prima parte "estetica trascendentale", una scienza dei principi della sensibilità. Questi principi, quali spazio e tempo, rappresentano la condizione di possibilità dell'esperienza, perché è solo in spazio e tempo che può darsi, per noi esseri umani, un'intuizione sensibile. L'estetica di cui parla Kant, dunque, fa riferimento solamente alla conoscenza umana, dopo di lui scienziati e filosofi cercheranno di ampliare il campo d'indagine agli animali e persino al regno delle piante e a quello dei funghi. Da questi studi si capì che la percezione a priori di spazio e tempo cambia a seconda dell'organismo preso in esame. Quindi la percezione non è universale, ma varia da corpo a corpo.
Estetica evoluzionistica
L'estetica evoluzionistica studia come l'attitudine estetica si è sviluppata negli animali e nell'uomo, attraverso origini e cambiamenti storici, dividendo 2 modelli:
- Il modello preferenziale vede l'estetico come scelte di tratti ambientali e sessuali stabilizzate dalla selezione naturale.
- Il modello espressivo si concentra su attività come il gioco, che non hanno adattività diretta, ma sono importanti per lo sviluppo cognitivo e le relazioni sociali.
Significato e natura della sensibilità
Se l'estetica deve occuparsi della conoscenza sensibile è lecito interrogarsi sul significato e sulla natura della sensibilità. Tradizionalmente si individuano cinque sensi, ma oggi si riconoscono anche i sensi della temperatura, dell'equilibrio, del dolore, del riconoscimento della posizione del corpo e degli arti nello spazio (propriocezione) e quello che ci informa su ciò che accade nel nostro corpo (enterocezione).
Gli stimoli che raggiungono i recettori poi sono solo tre: la luce (variazioni di energia elettromagnetica), le vibrazioni e le pressioni che avvertiamo rispettivamente come suoni e sulla pelle (variazioni nella stimolazione meccanica) e le variazioni nella stimolazione chimica. Un fisiologo in base a ciò potrebbe dire che i sensi sono solo questi tre.Un altro problema riguarda la gerarchia delle percezioni sensoriali, che varia in base al criterio scelto e ha suscitato riflessioni nell'estetica fin dall'antichità.
Filosofi come Aristotele, Agostino, Cartesio e Kant propongono una gerarchia in cui i sensi distali come vista e udito vengono considerati più nobili in quanto condivisibili da più persone, al contrario dei gusti prossimali come gusto e olfatto che si definiscono maggiormente carnali. Al contrario i filosofi sensisti e materialisti del 700 assegnano il primato al tatto. Queste distinzioni si ritrovano anche nel piano della teoria dell'arte: Hegel, per esempio, sostiene che solo vista e udito contribuiscono alla contemplazione di un'opera d'arte. Ma i sensi influenzano anche le relazioni fra individui, esaminando i pregiudizi che creano sin dal primo istante. Questi dubbi sulla gerarchia dei sensi hanno significato solo dal presupposto che ogni senso agisca come un canale di input indipendente. Tale presupposto è associato al pensiero che nel cervello esistano aree primarie specializzate per elaborare le informazioni provenienti da un determinato senso. Studi recenti dimostrano che è possibile dimostrare che aree che prima venivano considerate unisensoriali sono in realtà sedi di processi di integrazione multisensoriale che avvengono in maniera automatica e inconsapevole (illusione del ventriloquo).
Il fenomeno dell'integrazione di informazioni da diversi canali sensoriali ha portato all'idea che l'uomo funzioni come un "sensorio comune". Autori come Merleau-Ponty sostengono che la sinestesia non sia un'eccezione patologica, ma una parte normale della percezione. Questo implica che la percezione umana è influenzata da più sensi e dal contesto storico-culturale.
La percezione è influenzata dall'ambiente, che cambia continuamente grazie a tecniche e dispositivi in evoluzione. Fotografia, cinema e video sono esempi di come la tecnologia modifichi il modo in cui percepiamo e riveli aspetti sconosciuti della realtà.
La psicologia della forma spiega che non percepiamo i singoli stimoli separatamente (come un insieme di punti, suoni o colori), ma li colleghiamo in un insieme coerente. Questi processi di interpretazione si basano su un "orizzonte di senso", cioè un quadro preesistente di conoscenze, esperienze e aspettative che guida come percepiamo gli stimoli.
Merleau-Ponty dice che quando vediamo un'illusione come quella delle linee di Müller-Lyer, dove due linee uguali sembrano di lunghezze diverse, anche se in realtà sono identiche, noi percepiamo come se fossero diverse. Questo non è vero dal punto di vista matematico, ma lo è dal punto di vista della nostra percezione, cioè di come vediamo il mondo. La nostra mente tende a interpretare ciò che vediamo basandosi su esperienze passate, e cerca di mettere insieme gli elementi in modo che abbiano un senso. Quindi, anche se le linee sono uguali, la mente le percepisce come diverse, perché associa automaticamente certe forme e situazioni in modo naturale, in base a come siamo abituati a vedere il mondo. La percezione, perciò, prende il posto della realtà in carne ed ossa.
Noi possiamo vedere un'immagine come se fosse reale e includerla nell'immagine che abbiamo di noi stessi. La percezione di queste immagini può influenzare come vediamo il mondo reale, facendo sfumare la linea tra le due percezioni.
Il movimento è fondamentale per percepire davvero le cose, come dice Husserl. Non vediamo mai un oggetto tutto in una volta, ma sempre in parte, e per capire meglio dobbiamo muoverci attorno ad esso (cinestesi). Questo vale anche per l'arte: per apprezzarla davvero, dobbiamo essere empatici, cioè coinvolgerci emotivamente e percepirla non solo con gli occhi, ma anche con il cuore.
Arte - Andrea Pinotti
Pinotti esplora il concetto di arte attraverso esempi di oggetti quotidiani e scarti trasformati in opere d'arte. L'arte contemporanea ha iniziato a incorporare frammenti della vita quotidiana.
Adorno parlava di "disartizzazione", un concetto che descriveva come l'arte stesse perdendo la sua separazione dal resto della vita quotidiana. L'arte stava iniziando a mescolarsi con la vita di tutti i giorni. Simmel aveva scritto un saggio in cui faceva una netta distinzione tra arte e non arte, sostenendo che la cornice del quadro doveva segnare una separazione chiara. Però, questa visione risultava ormai obsoleta, perché le avanguardie artistiche avevano già iniziato a superare questa separazione tra arte e vita.Marcel Duchamp coniò il termine ready-made per disegnare oggetti comuni come opere d'arte. Duchamp prelevava un oggetto di uso comune e lo trasformava magicamente in arte.
Possiamo distinguere tre modi fondamentali di distinguere l'ente estetico: come mera cosa, come mezzo/strumento, e come opera d'arte. Ad esempio un vaso facile da impugnare si collocherà dalla parte della strumentalità, invece più il manico è complesso da impugnare più tenderá ad un'opera d'arte.
La mera cosa sembra un mezzo privo di scopo pratico, proprio come l'opera d'arte, che nonostante sia creata dall'uomo, non può essere compresa solo come strumento. È l'arte stessa che rivela la sua vera natura. L'arte ci offre una conoscenza del reale che non potremmo ottenere in altri modi, permettendoci di capire meglio la realtà. Pur essendo legata alle esperienze umane, l'arte non si riduce a esse.
L'opera d'arte è un oggetto che esiste nel mondo, ma affinché venga riconosciuto come tale, deve essere inserito in un contesto che ne permetta il riconoscimento. Questo riconoscimento non dipende solo dall'oggetto fisico, ma anche da un "incorniciamento concettuale", cioè un insieme di regole e convenzioni che definiscono cosa è arte. Un filosofo ha coniato il termine artworld per descrivere questo contesto che decide cosa è considerato arte, distinguendo l'arte da altre cose. Un altro pensatore ha sviluppato un'idea chiamata Do women have to be naked to get into the Met. Museum? Less than 5% of the artists in the Modern Art Sections are women, but 85% of the nudes are female. GUERRILLA GIRLS & CONVENTION "teoria istituzionale dell'arte", secondo cui un'opera d'arte è tale solo se destinata a essere presentata a una comunità di esperti del mondo dell'arte (critici, musei, ecc.). L'arte, quindi, è una pratica sociale riconosciuta da una specifica subcultura che non include necessariamente altre. Negli anni '60, un movimento chiamato "critica istituzionale" ha messo in discussione come le istituzioni artistiche decidono quali oggetti vengono considerati arte. Un esempio noto di questa critica è un poster di un collettivo femminista che si chiedeva se le donne dovessero essere nude per entrare nel Metropolitan Museum di New York, sottolineando come le istituzioni artistiche influenzano il valore dell'arte anche dal punto di vista sociale e di genere.
La questione sulla nascita dell'arte ha ispirato uno studio chiamato «naturalizzazione» dell'estetica. Gli studiosi si chiedono perché l'uomo abbia avuto bisogno di creare arte. Ellen Dissanayake interpreta questo come un processo di ritualizzazione, che trasforma l'ordinario in straordinario, avvicinando estetico, artistico e bello fino a fonderli.
Se l'arte non esistesse sempre ad un certo punto potrebbe smettere nuovamente di esistere. La questione pare venga affrontata come il problema della morte dell'arte nell'estetica hegeliana. In realtà però Hegel preferisce parlare di arte come di un passato, non perché non riconoscesse più arte intorno a sé o nel futuro, ma perché con l'avvento del cristianesimo ci si distacca dall'esigenza di assoluto delle apparenze sensibili, considerate non più adeguate ad esprimere verità. L'arte potrà evolversi ma ha smesso di essere il bisogno supremo dello spirito.
La fine dell'arte, secondo Hegel, non significa che l'arte scomparirà, ma che non è più in grado di esprimere verità spirituali come un tempo.
Categorie estetiche - Giancarlo Grossi
L'esperienza estetica non è descrivibile solo grazie alla categoria del bello e ciò rende necessario ricorrere a termini specifici che descrivano un determinato aspetto. La qualità individuata è un valore che noi stessi attribuiamo a seconda della singolarità del nostro vissuto. Con Kant si è arrivati ad individuare proprio in questo valore soggettivo la fonte dei propri giudizi.
Ogni volta che cerchiamo di definire qualitativamente l'esperienza vissuta nell'incontro con un oggetto, non facciamo altro che produrre categorie estetiche o applicare quelle già esistenti. Le categorie estetiche sono i predicati di cui si serve il giudizio di gusto. Il bello domina le qualificazioni dell'estetica e vi sono due accezioni della bellezza: Il "bello in senso lato" abbraccia tutte le cose che possono essere considerate piacevoli o gradevoli, mentre il "bello in senso stretto" riguarda quella forma di bellezza che è particolarmente raffinata e armoniosa. Quest'ultima può essere ulteriormente suddivisa in due aspetti: il sublime, che è una bellezza che evoca emozioni forti e magnifiche, e l'attraente, che è una bellezza che affascina e cattura l'attenzione.
Possiamo distinguere il bello dal grazioso in quanto quest'ultimo si caratterizza in virtù del dinamismo, della spontaneità e dell'agilità. La grazia è la bellezza in movimento: l'estetica scientifica francese identifica la grazia con la fluidità della danza.