Biocompatibilità nell'ingegneria biomedica: interazioni tra materiali e tessuti
Documento da Università su Biocompatibilità. Il Pdf esplora i fondamenti della biocompatibilità, la caratterizzazione superficiale dei biomateriali e la risposta da corpo estraneo, argomenti chiave per la Biologia a livello universitario.
See more44 Pages
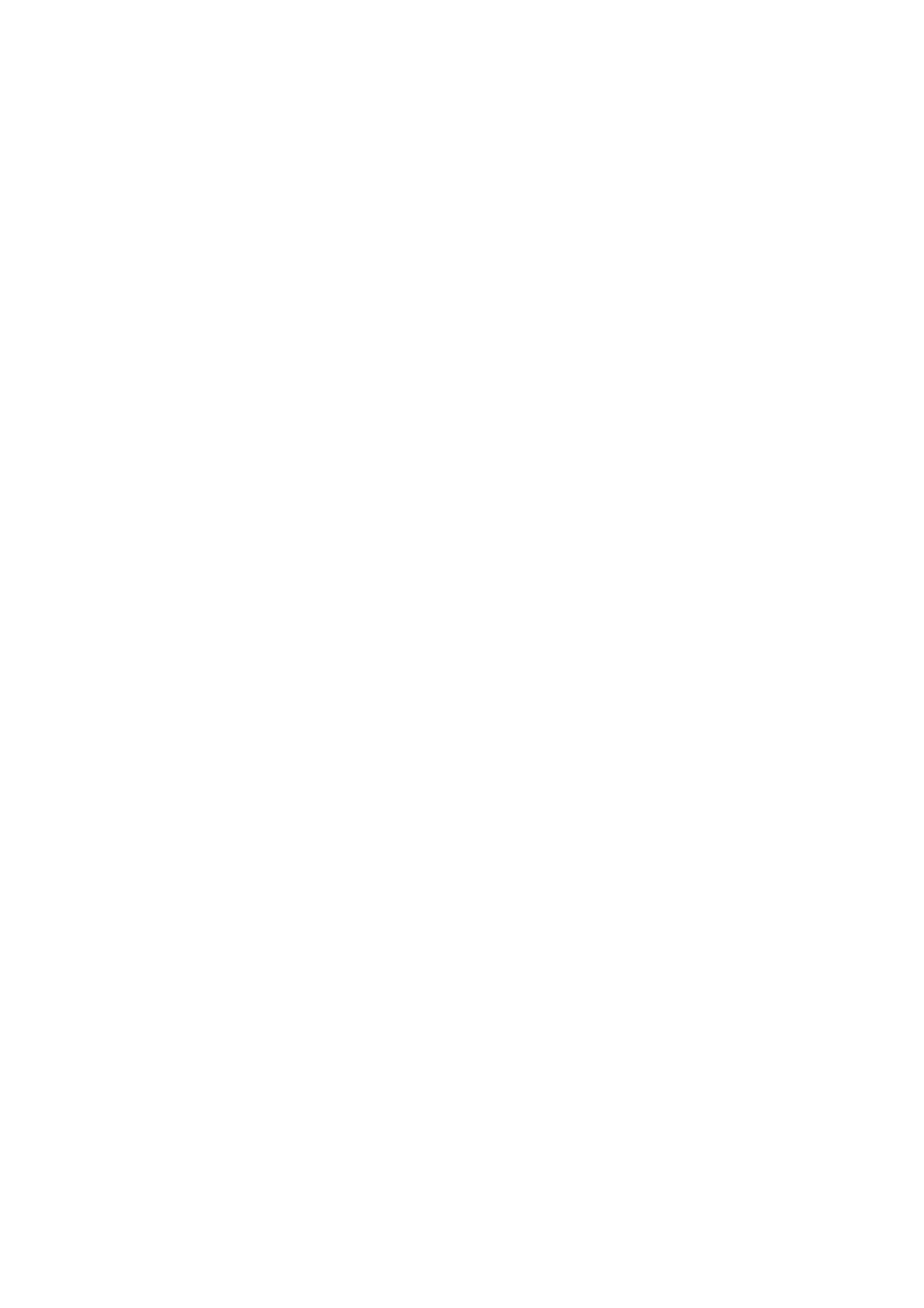

Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Fondamenti di Biocompatibilità e Interazioni Materiale-Tessuto
La biocompatibilità rappresenta un concetto fondamentale, ma non assoluto, nel campo dell'ingegneria biomedica. Non esistono, infatti, materiali intrinsecamente e completamente biocompatibili; piuttosto, è essenziale comprendere in che modo un materiale possa essere reso più compatibile con l'ambiente biologico. È altrettanto importante valutare quali problemi possono derivare dall'impiego di materiali poco compatibili.
Una strategia frequentemente adottata per limitare le problematiche legate alla biocompatibilità consiste nell'utilizzo di materiali per periodi di tempo limitati. In questi casi, anche materiali con un ridotto grado di compatibilità possono essere impiegati, a condizione che il tempo di esposizione sia contenuto. Tuttavia, esistono dispositivi che richiedono un impianto permanente o cronico. Un esempio emblematico è rappresentato dalle protesi mammarie, per le quali l'uso temporaneo non è contemplabile. In tali casi, la biocompatibilità deve essere quanto più possibile garantita, poiché un'inadeguata compatibilità può condurre a effetti avversi nel medio-lungo termine.
Nel momento in cui un materiale viene introdotto nell'organismo, si instaura inevitabilmente un'interfaccia con i compartimenti biologici circostanti, comprendenti cellule, fluidi biologici e le componenti molecolari disciolte nei liquidi corporei. Anche quando non si osservano alterazioni gravi, persiste quasi sempre una reazione, seppur lieve, dovuta a questa interazione. Una delle problematiche principali associate a tali interazioni riguarda il sangue, in quanto l'attivazione della cascata coagulativa può condurre alla formazione di trombi.
Per comprendere questi fenomeni, sarà fondamentale riesaminare la cascata della coagulazione, in particolare per quanto concerne la sua attivazione in seguito al contatto tra gli elementi corpuscolati del sangue e la superficie del materiale impiantato. Solo comprendendo i meccanismi molecolari e cellulari alla base di tale attivazione sarà possibile identificare punti di intervento precoce, con l'obiettivo di inibire o modulare l'innesco della risposta coagulativa.
Questo approccio risulta particolarmente rilevante nello studio di dispositivi quali le valvole cardiache meccaniche, le quali richiedono un trattamento farmacologico cronico con anticoagulanti per prevenire la trombosi.
Un significativo avanzamento tecnologico consisterebbe nello sviluppo di materiali o geometrie capaci di ridurre significativamente il rischio trombotico, portando a soluzioni cliniche innovative e più sicure.
La vera sfida dell'ingegneria biomedica consiste dunque nel progettare materiali in grado di coesistere armonicamente con l'ambiente biologico, il quale non è costituito solo da fluidi contenenti molecole, ma anche da elementi cellulari attivi. Questi ultimi, infatti, esplicano la loro funzione attraverso la produzione di segnali molecolari e l'attivazione di reazioni biochimiche specifiche.
Lo studio della biocompatibilità implica quindi l'integrazione di competenze chimiche, biologiche e ingegneristiche. È necessario analizzare sia le reazioni chimiche tra il materiale e l'ambiente biologico, sia le risposte cellulari che ne derivano.
Il miglioramento della biocompatibilità richiede pertanto un'interazione ("cross-talk") multidisciplinare, che unisce conoscenze di chimica dei materiali, ematologia, immunologia e ingegneria dei biomateriali.
1Figure 1. Prosthetic carbon-based mechanical heart valve, (left) before implantation, (right) after implantation rejected by the body. Courtesy of T. Horbert (University of Washington)
Caratterizzazione Superficiale dei Biomateriali e Interazioni Biologiche
Nel contesto della progettazione e selezione dei biomateriali, risulta essenziale effettuare una caratterizzazione approfondita dei materiali utilizzati, considerando diversi aspetti, tra cui la morfologia superficiale e le proprietà fisico-chimiche della superficie, gli aspetti biologici e il contenuto dei fluidi attorno al materiale che creano un'interazione e gli aspetti biologici. In tutto ciò poi si valuterà la risposta biologica del materiale e la sua idoneità o la sua compatibilità
Un primo parametro da valutare è la struttura superficiale, che può variare da superfici lisce a superfici rugose, influenzando in modo significativo l'interazione con l'ambiente biologico. L'osservazione a scala micro- e nanometrica, tramite tecniche di microscopia avanzata (ad esempio SEM o AFM), consente di determinare se, in una determinata applicazione, sia preferibile una superficie più liscia o una morfologia più complessa. Questa scelta dipende sia dalla risposta cellulare attesa, sia dalla necessità di limitare o favorire l'adesione di proteine o cellule.
Altro elemento critico è la composizione molecolare della superficie. Sebbene il materiale di base possa non essere biocompatibile, è possibile modificarne la superficie attraverso rivestimenti con molecole o polimeri bioattivi. Un esempio pratico è rappresentato dalle lenti a contatto: le prime versioni, pur risultando relativamente biocompatibili sul piano cellulare, erano poco permeabili all'ossigeno. L'introduzione di materiali come il silicone ha aumentato significativamente la permeabilità, consentendo l'utilizzo prolungato delle lenti. Tuttavia, poiché il silicone non è intrinsecamente biocompatibile, esso viene rivestito con strati superficiali funzionalizzati per ridurre l'interazione con le componenti dei fluidi oculari.
Un principio analogo si applica agli stent vascolari, dispositivi metallici che vengono frequentemente rivestiti con polimeri per modulare l'interazione con il sangue e ridurre fenomeni di restenosi o trombosi. In questi casi, è la combinazione di composizione chimica e morfologia della superficie a determinare le proprietà finali del materiale, tra cui l'idrofilicità o l'idrofobicità, valutabili mediante la misura dell'angolo di contatto.
Un ulteriore fattore rilevante è la distribuzione delle cariche elettriche sulla superficie. Poiché le molecole biologiche, tra cui le proteine plasmatiche, possiedono cariche elettriche (positive o negative), la presenza di gruppi funzionali carichi sul materiale può favorire o inibire determinate interazioni. Ad esempio, la molecola dell'acqua, essendo un dipolo, reagisce diversamente a seconda della polarità della superficie, influenzando l'organizzazione molecolare e la successiva adesione cellulare.
Lo studio della biocompatibilità deve quindi estendersi anche all'analisi delle interazioni molecolari, ovvero alle reazioni che coinvolgono le molecole presenti nei fluidi biologici (molecole circolanti) e quelle secrete o espresse dalle cellule. È fondamentale comprendere in che modo queste molecole riconoscono la superficie del materiale, si adsorbono o ne modificano le proprietà.
2A questi studi va affiancata l'analisi della risposta biologica cellulare, che coinvolge numerosi attori: piastrine, cellule immunitarie, batteri, trombina e altri elementi del sangue. Non bisogna tuttavia trascurare la partecipazione delle cellule dei tessuti circostanti, non direttamente ematiche, che svolgono un ruolo chiave nella risposta infiammatoria e fibrotica. Un esempio esplicativo è quello delle protesi mammarie, la cui permanenza a lungo termine può indurre la formazione di una capsula fibrotica dovuta all'attivazione dei fibroblasti. Se la risposta è eccessiva, la protesi può staccarsi e richiedere la sostituzione chirurgica, evento che statisticamente si presenta in una percentuale significativa di casi dopo 10-15 anni.
Per poter affrontare in maniera sistematica questi fenomeni, è utile riprendere l'analisi dettagliata dei principali componenti del sangue, poiché essi saranno spesso richiamati nel corso delle successive trattazioni. Tali elementi, infatti, rappresentano i primi mediatori dell'interazione tra biomateriale e sistema biologico.
Surface property Proteins Fibrinogen, Fibronectin, von Willebrand factor Coagulation factors, etc Chemistry, Topography, Wettability, Charge, etc. Biological responses Platelet adhesion Coagulation, Thrombosis, lofection, etc Biology Platelet, Thrombin, Bacteria, etc
Composizione del Sangue
Il sangue umano può essere suddiviso in due componenti principali: la frazione cellulare e la componente liquida, denominata plasma. Quest'ultima rappresenta il mezzo di sospensione per le cellule ematiche e contiene una varietà di sostanze disciolte di fondamentale importanza dal punto di vista fisiologico e clinico, in particolare nell'ambito dell'interazione con dispositivi biomedici.
Composizione del Plasma e Rilevanza per i Dispositivi Biomedici
La componente principale del plasma è costituita dall'acqua, che funge da solvente per una molteplicità di molecole, incluse:
- Gas disciolti, come l'anidride carbonica (CO2), presente in quantità rilevanti in forma solubile, e l'ossigeno (O2), la cui concentrazione nel plasma è modesta poiché la maggior parte si trova legata all'emoglobina all'interno dei globuli rossi.
- Ioni inorganici (elettroliti), quali sodio (Na+), cloro (CI-), potassio (K+) e altri sali, che svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dell'equilibrio osmotico, del pH e della trasmissione elettrica. Nella progettazione di organi artificiali e dispositivi extracorporei, è fondamentale preservare la composizione ionica del plasma per evitare squilibri sistemici.
Il plasma contiene inoltre molecole organiche di varia natura:
- Glucosio, principale substrato energetico per le cellule, che entra nel ciclo di Krebs per la produzione di ATP.
- Proteine plasmatiche, tra cui: 3o Albumina, la più abbondante, con funzione di trasporto e regolazione della pressione oncotica; il suo comportamento in condizioni fisiologiche e patologiche sarà oggetto di approfondimento. o Globuline, comprendenti gli anticorpi, coinvolti nelle risposte immunitarie; sarà necessario valutare se e come questi interagiscano con i materiali artificiali. o Proteine della coagulazione, tra cui il fibrinogeno, che rappresentano un punto centrale nell'attivazione delle risposte emostatiche in presenza di superfici estranee.
Altre componenti organiche includono:
- Amminoacidi, unità strutturali delle proteine, la cui presenza è essenziale per la sintesi proteica e per specifiche funzioni metaboliche che analizzeremo nel contesto biomedico.
- Lipidi, molecole scarsamente solubili in acqua, che si organizzano in strutture aggregate (micelle, lipoproteine) e la cui interazione con le superfici artificiali va studiata con attenzione per comprenderne il comportamento nei dispositivi impiantabili.
- Metaboliti di scarto, come l'urea e la creatinina, che devono essere efficacemente rimossi in pazienti con insufficienza renale o altre disfunzioni metaboliche; la loro presenza nel plasma è quindi un indicatore fondamentale dello stato funzionale dell'organismo e un target primario nei trattamenti sostitutivi come l'emodialisi.
La conoscenza dettagliata della composizione del plasma e delle sue interazioni con i materiali risulta indispensabile per lo sviluppo e la gestione dei dispositivi biomedici, con l'obiettivo di minimizzare le risposte avverse e ottimizzare l'efficacia terapeutica.
Differenze tra Plasma e Siero: Composizione e Metodi di Separazione
In ambito biomedico e clinico, è frequente il riferimento alla concentrazione di albumina sia nel plasma sia nel siero. È pertanto fondamentale chiarire la distinzione tra questi due termini, spesso usati in modo intercambiabile, ma che si riferiscono a componenti diversi del sangue.
Il plasma rappresenta la componente liquida del sangue non coagulato. Esso include acqua, elettroliti, nutrienti, prodotti di scarto, proteine plasmatiche (tra cui albumina, globuline e fibrinogeno), e altri elementi disciolti. In condizioni standard, il plasma può essere ottenuto da un campione di sangue prelevato in provette contenenti anticoagulanti, che impediscono la formazione del coagulo. Successivamente, la separazione tra la parte cellulare e quella liquida avviene per centrifugazione, o più semplicemente per sedimentazione spontanea, sebbene in modo meno efficiente.
Nel caso dei prelievi venosi, il sangue viene oggi raccolto tramite un sistema a vuoto: una provetta prelevatrice collegata al catetere si riempie automaticamente per aspirazione, senza l'utilizzo di siringhe manuali. Il sangue così raccolto viene poi processato per la separazione delle sue componenti.
Il siero, invece, si ottiene a partire da sangue coagulato, ovvero raccolto in provette prive di anticoagulanti. In questo caso, avviene naturalmente la cascata della coagulazione, in cui le proteine coagulanti come il fibrinogeno vengono consumate nella formazione del trombo (coagulo solido). Il liquido che resta, una volta rimossi il coagulo e le cellule precipitate, è definito siero. Esso è quindi plasma privo delle proteine della coagulazione, risultando visivamente più limpido e chiaro rispetto al plasma, che ha una colorazione giallastra dovuta alla presenza di tali proteine.
La distinzione tra plasma e siero ha implicazioni significative nell'interpretazione degli esami ematochimici. Ad esempio, le concentrazioni di albumina, glucosio e altri analiti possono essere misurate sia nel plasma che nel siero, ma è necessario specificare il tipo di matrice biologica utilizzata, in quanto la presenza o assenza delle proteine coagulanti può influenzare alcuni risultati.
4