Minimalismo, Arte processuale, Arte concettuale e Arte povera: una Presentazione
Slide dall'Università su Minimalismo, Arte processuale, Arte concettuale, Arte povera. Il Pdf esplora queste correnti artistiche, fornendo definizioni, periodi e luoghi di sviluppo, con esempi visivi di opere significative. È un materiale utile per lo studio dell'Arte.
See more61 Pages

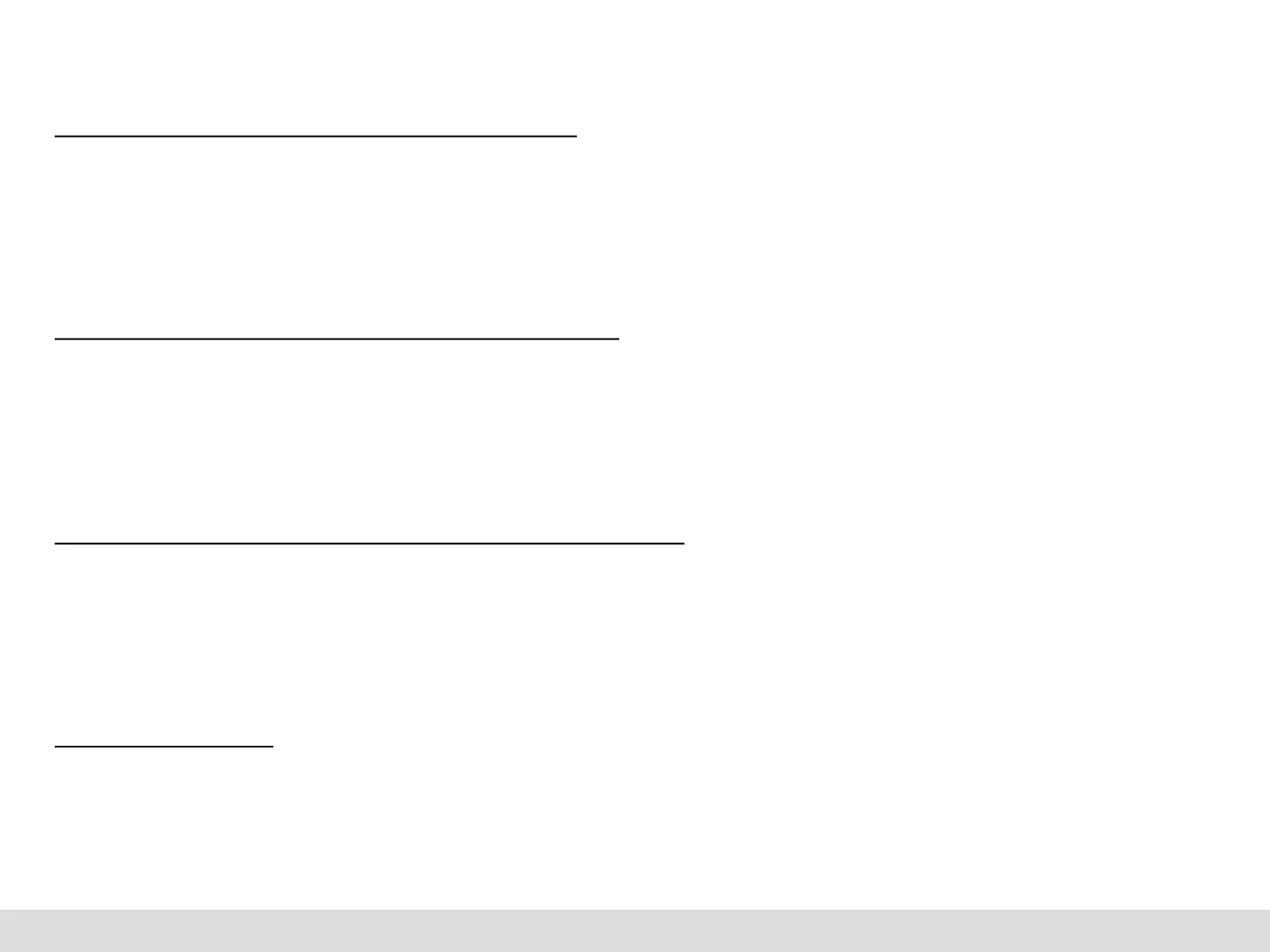
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Minimalismo e Correnti Artistiche
Minimalismo, Arte processuale, Arte concettuale, Arte poveraMinimalismo (Minimal Art) Periodo: Anni Sessanta Luoghi: Stati Uniti, Europa
Arte processuale (Process Art) Periodo: Fine anni Sessanta, Anni Settanta Luoghi: Stati Uniti
Arte concettuale (Conceptual Art) Periodo: Anni Settanta Luoghi: Stati Uniti, Europa
Arte povera Periodo: Fine anni Sessanta Luoghi: ItaliaMinimal Art Termine coniato nel 1965 dal filosofo inglese Richard Wollheim nell'articolo omonimo pubblicato sulla rivista «Arts Magazine»Frank Stella, Empresses of India, 1965 Nella foto: l'artista al lavoro Robert Rayman, Untitled, 1965
Minimal Art: Caratteristiche e Opere
minimal art Corrente artistica sviluppatasi tra il 1960 e il 1970 negli Stati Uniti d'America. [ ... ] è caratterizzata da forme semplici (minimal), derivate generalmente dalla geometria elementare, da strutture modulari e seriali e dall'uso di materiali della moderna tecnologia industriale. Con un intento programmatico di denuncia dei limiti raggiunti dalla pop art, rifiutando un atteggiamento emozionale, gli esponenti della minimal art hanno teso alla realizzazione di opere che si presentano come sintesi tra architettura (scala ambientale, possibilità di scorci), pittura (stesura di colori puri sulle superfici) ed environment (coinvolgimento dello spazio in cui sono poste opere che possono essere spostate, attraversate ecc.). www.treccani.it
Kazimir Malevič, Quadrato bianco su fondo bianco, 1918 Yves Klein, RE 16, DO - DO - DO, 1960 Enrico Castellani, Superficie bianca, 1959 Piero Manzoni, Achrome, 1961
Environment e Installazione nell'Arte
Environment: Definizione e Impatto
environment / ambiente Dagli anni Sessanta il termine designa un'ampia varietà interventi artistici che si relazionano in maniera diretta e dialettica con lo spazio reale. Spesso di natura effimera e realizzati in occasione di eventi espositivi, gli ambienti riconfigurano temporaneamente lo spazio, superando i limiti dati dalla cornice e dal piedistallo e offrendo al pubblico un rapporto inedito e immersivo con l'opera d'arte.
Installazione: Tipologia e Caratteristiche
installazione Tipologia di espressione artistica più rappresentativa della contemporaneità. Alla fine degli anni Settanta del Novecento è entrato in uso nella lingua inglese come termine più ampio e generico di quello di "environment". Caratteristiche:
- relazione articolata con lo spazio fisico (sia interno che esterno)
- ibridazione della scultura tradizionale con altre arti (architettura, teatro, performance, cinema, ecc.)
- mutevolezza e carattere effimero
- modalità di fruizione molteplici
Artisti e Opere del Minimalismo
Robert Morris, Untitled (L-Beams), 1965-1967
Robert Morris, mostra personale alla Green Gallery di New York, 1964
Robert Morris, Philadelphia Labirinth, 1974
Carl Andre, Steel Zinc Plain, 1969
Donald Judd, Untitled, 1966- 1968
Donald Judd, Untitled, 1969
La Visione di Donald Judd sull'Opera d'Arte
«Non è necessario per un lavoro avere molte cose da guardare, comparare, analizzare una a una, contemplare. La cosa come un intero, le sue qualità come un intero, è questo ciò che è interessante. Le cose importanti sono sole e sono le più intense, chiare, potenti». Donald Judd, 1965
Sol LeWitt, Structures, 1977
Dan Flavin, mostra personale alla Green Gallery di New York, 1964
A Dan Flavin, Varese Corridor, 1987
Daniel Buren, intervento in situ in occasione della sesta International Exhibition al Guggenheim di New York, 1971
Arte Processuale: Concetti e Artisti
Definizione di Arte Processuale
Arte processuale (Process Art) Nella critica d'arte, sono indicate come arte processuale (process art) esperienze artistiche che si basano su un processo comportamentale [ ... ] o pongono l'accento sul processo intellettuale o progettuale dell'opera, rientrando nel più ampio campo dell'arte concettuale. www.treccani.it
Robert Morris e il Processo Creativo
«Il focalizzarsi sulla materia e sulla gravità si esplica in forme che non sono progettate in anticipo. Mucchi disordinati, cataste casuali e sospensioni creano forme accidentali per il materiale. Il caso è accettato e l'indeterminatezza è sottintesa.» Robert Morris, 1968 Robert Morris, Untitled, 1967-1968
Robert Morris, Continuous Project Altered Daily, Leo Castelli Gallery, 1969
Richard Serra, Belts, 1966-1967
Richard Serra, Titled Arc, 1981
Richard Serra, Splash Series, 1968
Eva Hesse, Untitled, 1969-1970
Lynda Benglis, Bundi, 1971
Guggenheim: Minimalismo e Process Art
Minimalism al Guggenheim
GUGGENHEIM VISIT EXHIBITIONS EVENTS ART & ARTISTS LEARN JOIN & SUPPORT SHOP Tickets Membership Search Minimalism Though never a self-proclaimed movement, Minimalism refers to painting or sculpture made with an extreme economy of means and reduced to the essentials of geometric abstraction. Show More v Carl Andre 5 x 20 Altstadt Rectangle Carl Andre 10 x 10 Altstadt Copper Square Carl Andre Trabum (Element Series) https://www.guggenheim.org/artwork/movement/minimalism
Process Art al Guggenheim
GUGGENHEIM Tickets Membership Search VISIT EXHIBITIONS EVENTS ART & ARTISTS LEARN JOIN & SUPPORT SHOP Artists Dates Mediums Movements Special Collections Venues Process Art Process art emphasizes the "process" of making art (rather than any predetermined composition or plan) and the concepts of change and transience, as elaborated in the work of such artists as Lynda Benglis, Eva Hesse, Robert Morris, Bruce Nauman, Alan Saret, Richard Serra, Robert Smithson, and Keith Sonnier. Show More v Eva Hesse Robert Morris Robert Morris https://www.guggenheim.org/artwork/movement/process-art
Arte Concettuale: Idea e Realizzazione
Definizione di Arte Concettuale
Arte concettuale (Conceptual Art) Forma dell'arte d'avanguardia contemporanea, nata negli anni Sessanta, il cui fine è di giungere a una realizzazione intellettuale e teoretica, rifiutando l'oggetto e valorizzando il processo, lo schema concettuale per mezzo del quale vi si arriva. [L'arte concettuale] si libera dalla sottomissione al materiale e si volge prevalentemente alla progettazione e all'ideazione di un'opera. La ricerca non è rivolta alla creazione di qualcosa di tangibile, ma alla concettualizzazione di un'immagine. [ ... ] Il termine è stato usato per la prima volta da Sol Lewitt nel 1967 nel suo Paragraphs on conceptual art, in Artforum (New York). www.treccani.it
Sol LeWitt e l'Importanza dell'Idea
«nell'arte concettuale, l'idea o concetto è l'aspetto più importante del lavoro» Sol LeWitt Sol LeWitt, Paragraphs on Conceputal Art, in «Artforum», 1967 PARAGRAPHS ON CONCEPTUAL ART Jo Baer, untitled paintings, 1966. Steps (Photograph by Dan Graham.] Ruth Vollmer, 2/2 Spheres, bronze, 16%" dia .. 1956-67. (Betty Parsons Gallery.) SOL LeWITT The editor has written me that he is in favor of avoiding "the notion that the artist is a kind of ape that has to be explained by the civilized critic." This should be good news to both artists and apes. With this assurance I hope to justify his confidence. To continue a baseball metaphor (one artist wanted to hit the ball out of the park, an- other to stay loose at the plate and hit the ball where it was pitched), I am grateful for the op- portunity to strike out for myself. 79.. R. MUTT
Marcel Duchamp e il Ready-Made
Marcel Duchamp e il ready-made
CORPO D'ARIA CORPO D'ARIA Piero Manzoni, Corpo d'aria, 1959- 1960 Piero Manzoni Merda d'artista, 1961-1962 PRODUCED BY Piero Tantain N.º e Merd 30 TEN C MAI 19 61
René Magritte e la Rappresentazione
Ceci n'est pas une pipe. René Magritte, Ce ci n'est pas une pipe, 1933 «un oggetto non ha la stessa funzione del suo nome o della sua immagine» «tutto tende a far pensare che ci sia una debolissima relazione tra un oggetto e la sua rappresentazione» René Magritte
Joseph Kosuth e l'Indagine Concettuale
1 chair (chãr), n. [OF. chaiere (F. chaire), < L. cathedra: see cathedra.] A seat with a back, and often arms, usually for one person; a seat of office or authority, or the office itself; the person occupying the seat or office, esp. the chair- man of a meeting; a sedan-chair; a chaiset; a metal block or clutch to support and secure a rail in a railroad. - L Joseph Kosuth, One and three chairs, 1965
Joseph Kosuth, The Eight Investigation, Proposition 2, 1970
Art & Language, Index 001, 1972
I will not make any more boring art. of will not make any more boring I will not make any more boring I will not make any more boring art. A will not make any more boring out . I will not make any more boring art. A will not make any more boring art . I will not make any more boring It will not make any more boring I will not make any more boring I will not makes any more born , I will not make any more boring I will not makes any more boring I will not make any more boring art. art . IL 1 a. H S S = 4 1 4 g art. art. OUT. out. ort. 05 /9 art. art. will not make any more boring art. I will not make any mone boring out . 1.101 John Baldessari, I Will Not Make Any More Boring Art, 1971
Number 13: "A work of art John Baldessarri, Baldessarri Sings LeWitt, 1972 Link al video: https://www.youtube.com/watch?v =- LleBVS5 ho=
Bernd & Hilla Becher, Water Towers, 1972-2009- bbb A 30
Franco Vaccari, Esposizione in tempo reale n. 4. Lascia una traccia fotografica del tuo passaggio, 1972
FLOR € I Franco Vaccari, Esposizione in tempo reale n. 4. Lascia una traccia fotografica del tuo passaggio, 1972
I 1970 "Libro dimenticato a memoria ." LAgenda Vincenzo Agnetti, Libro dimenticato a memoria, 1969-1970
Lorenzo Lotto, Giovanetto, 1505 Giulio Paolini, Giovane che guarda Lorenzo Lotto, 1967
Arte Povera: Materiali e Filosofia
Definizione e Origini dell'Arte Povera
arte povera Tendenza artistica che, rifiutando i valori culturali legati a una società organizzata e tecnologicamente avanzata, mira al recupero dell'azione, del contingente, dell'archetipo come sola possibilità d'arte. La locuzione fu coniata dal critico Germano Celant in occasione della mostra Arte povera - Im Spazio tenuta alla galleria La Bertesca di Genova (1967). Nel ricorso a materiali poveri, 'antiartistici' (stracci, cartapesta ecc.), l'arte povera si pone come presa di coscienza delle possibilità espressive insite nella materia vegetale, animale, minerale o persino in un processo mentale elementare. Un tale orientamento, che rientra nell'ambito più generico dell'arte concettuale, ha dato luogo a manifestazioni diversissime e tra loro autonome. [www.treccani.it] Tra gli esponenti dell'arte povera: Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Piero Gilardi, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe Penone, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio.
Germano Celant: Appunti per una Guerriglia
ARTE POVERA APPUNTI PER UNA GUERRIGLIA Prima viene l'uomo poi il siste- ma, anticamente era così. Oggi è la società a produrre e l'uomo a con- sumare. Ognuno può criticare, violen- tare, demistificare e proporre rifor- me, deve rimanere però nel sistema, non gli è permesso di essere libero. Creato un oggetto vi si accompagna. Il sistema ordina così. L'aspettativa non può essere frustrata, acquisita una parte, l'uomo, sino alla morte, de- ve continuare a recitare. Ogni suo gesto deve essere assolutamente coe- rente col suo atteggiamento passato e deve anticipare il futuro. Uscire dal sistema vuol dire rivoluzione. Così l'artista, novello giullare, soddisfa i consumi raffinati, produce oggetti per i palati colti. Avuta un'idea vive per e su essa. La produzione in serie lo costringe a produrre un unico ogget- to che soddisfi, sino all'assuefazione, I mercato. Non gli è permesso crea- re ed abbandonare l'oggetto al suo cammino, deve seguirlo, giustificar- lo, immetterlo nei canali, l'artista si sostituisce così alla catena di mon- taggio. Da stimolo propulsore, da tec- nico e specialista della scoperta di- venta ingranaggio del meccanismo. suo atteggiamento è condizionato ad offrire solo una "correptio" del mon- do, a perfezionare la struttura socia- le. mai a modificarla e a rivoluzionar la. Pur rifiutando il mondo dei consu- mi, si trova ad essere un produttore. La libertà è una vuota parola. L'arti- sta si lega alla storia, o meglio al programma, ed esce dal presente. Non si progetta mai, ma si integra. 'er "inventare" è costretto ad agire da cleptomane e ad attingere agli al- tri sistemi linguistici. Ma cosa face- va Duchamp? Certamente non era te- so a soddisfare il sistema. Per lui es- serci e vivere, significava, e significa, giocare a scacchi (la mossa del ca- vallo non è mai rettilinea) e sceglie- re, mai lasciarsi scegliere. Più volte cercato il sistema, non si è mai fat- to trovare dove si pensava di reperir- 10. 1966 Mario Merz: Bottiglia con neon, 1967. Così in un contesto dominato dal- le invenzioni e dalle imitazioni tecno- logiche due sono le scelte o l'assun- zione (la cleptomania) del sistema dei linguaggi codificati ed artificiali, nel comodo dialogo con le strutture esistenti, siano esse sociali o priva- te, l'accettazione e la pseudoanalisi ideologica, l'osmosi con ogni "rivolu zione", apparente e subito integrata, a sistematizzazione della propria pro- duzione o nel microcosmo astratto (op) o nel macrocosmo socio-culturale (pop) e formale (strutture primarie) oppure, all'opposto, il libero proget- tarsi dell'uomo. Là un'arte complessa, qui un'ar- te povera, impegnata con la contin- genza, con l'evento, con l'astorico, col presente. ["non siamo mai com- pletamente contemporanei nel nostro presente" - Debray) con la concezione antropologica, con l'uomo "reale" (Marx), la speranza, diventata sicurez- za, di gettare alle ortiche ogni discorso visulmente univoco e coerente (la coe- renza è un dogma che bisogna infrange- rel), la univocità appartiene all'indi- viduo e non alla "sua" immagine ai suoi prodotti. Un nuovo atteggiamen to per ripossedere un "reale" domi- nio del nostro esserci, che conduce l'artista a continui spostamenti dal suo luogo deputato, dal clichè che la so- cietà gli ha stampato sul polso. L'ar- tista da sfruttato diventa guerrigliero. vuole scegliere il luogo del combatti- mento, possedere i vantaggi della mo- bilità, sorprendere e colpire, non l'op- posto. Gianni Piacentino: Oggetto, 1967. Giulio Paolini: Decima musa, 1966. struttura primaria) per una focaliz- zazione di gesti che non aggiungono nulla alla nostra colta percezione, che non si contrappongono come arte ri- spetto alla vita, che non portano alla frattura e alla creazione del doppio plano lo e mondo, ma che vivono co- me gesti sociali a se stanti, quali li- berazioni formative e compositive, an- tisistematiche, tese all'identificazione uomo-mondo. L'avvicendamento da compiersi dunque quello del ritorno alla proget- tazione limitata ed ancillare, in cul l'uomo e il fulcro e il fuoco della ri- cerca, non più il mezzo e lo strumento L'uomo è li messaggio, per parafrasa re Mac Luhan. Nelle arti visuali la II- bertà è un germe che contamina ogni produzione. L'artista rifiuta ogni eti- chetta e si identifica solo con se stes- so. Così Pistoletto (come Warhol, Ma- ri e Grotowsky) si è posto sin dal 1964, il problema della libertà del lin- luaggio non più legato al sistema, al- la coerenza visiva, ma alla coerenza "interiore", ed ha realizzato nel 1966 opere estremamente "povere", un pre sepe, un pozzo di cartone con tele spaccate al centro, una bacheca per ve stiti, una struttura per parlare in piedi o una struttura per parlare seduti, un tavolo fatto di cornici e di quadri, una foto gigante di Jasper Johns, una lam- pada a luce di mercurio. Un lavoro te- so alla registrazione "dell'irripetibile- tà di ogni istante" (Pistoletto), che presuppone il rifiuto di ogni sistema di ogni aspettativa codificata, Un li- bero agire, invincolato ed imprevedi- bile (nel 1967 una sarcofago, una ca- sa dipinta con estrema libertà croma- tica, una sfera di carta di giornali pres- sata, un corpo ricoperto di mica), un · frustrare l'aspettativa, che permette a Pistoletto di rimanere sempre al confine tra arte e vita. Un esistere rivoluzionario che si fa Terrore con Boetti, Zorio, Fabro, Anselmo, Piacentino, Gilardi, Prini, Merz, Kounellis, Paolini e Pascali, ar- tisti che già nel loro agire si sono posti questo recupero del libero pro gettarsi. Così Paolini esalta il carattere em- pirico e non speculativo del suo la voro, sottolinea il dato di fatto, la presenza fisica dell'oggetto e il com. portamento del soggetto In rapporto al sistema "pittura . La sua sovrappo- sizione tra idea e immagine, lo por- ta alla "prise de pouvoir" degli ele- menti strumentali, non ancora dire- zionati e sistematicizzati, quali la te a. il colore, lo spazio (diventato ora o spazio del mondo). Le componen- ti linguistiche ritornano così in cam- po quali paradigmi, primigeni, anico- nici, liberi da ogni sistema di colloca- zione iconologica. Elementi di un far- si, che non si vincolano all'immagine da realizzare, ma si presentano per fingere" se stessi. Il sensismo comportamentistico sa- le sull'altare con Pascali e Kounellis. La realizzazione immediata di una sen- sazione conduce in pochi anni Pa- scali a passare dal busti di donna, ai muri, ai cannoni, agli animali mitici. alla barca, al mare, alle pozzanghere, al cubi di terra, al campo arato. Il suo libero atteggiamento si evidenzia, perché vincolarsi ad un solo prodot- to? Ogni elemento è infatti sineddoche naturale del suo vivere e del suo esi- stere percettivo e plastico, perché di- ventare paradigma? Cosi Kounellis, col- pito dalla ricchezza del suo esserci, recupera il suo gesto artistico col dare il becchime agli uccelli, con lo staccare le rose dal quadro, ama cir- condarsi di elementi banali, ma natu- rali quali il carbone, il cotone, un pap- pagallo. Tutto si riduce ad un cono- scere concreto che lotta con ogni ri- duzione concettuale, l'importanza è focalizzare, per Kounellis, che Kounel- lis vive. il mondo vada in malora. Un'urgenza all'esserci che ha con- dotto Gilardi, soffocato dai suoi tap peti-natura e dal poliuterano, a rea izzare nel 1966 (mostra "arte abita- bile". Sperone) degli oggetti che so- no la concretizzazione, non più media- ta e mimetica, del suo agire strumen- tale e funzionale, ed ecco il basto, la carriola, la sega, la scala. Per chi conosce "l'operoso" Gilardi, questi so- no i suoi "simboli". La tautologia è il primo strumento di possesso sul reale, eliminando le so- vrastrutture, si riinizia a conoscere il presente e il mondo. Così Fabro concretizza in un anno, due o tre atti di possesso sul reale. La difficoltà di conoscere, come possesso, è enor me. i condizionamenti non permet- tono di vedere un pavimento, un ango- lo, uno spazio quotidiano e Fabro ri- propone la scoperta del pavimento, dell'angolo, dell'asse che unisce sof- fitto e pavimento di una stanza, non si preoccupa di soddisfare il siste- ma, vuole sviscerarlo. Parimenti Boetti "reinventa le in- venzioni" dell'uomo. I suoi gesti non sono più un accumulo, un Incastro di segni, ma i segni dell'accumulo e Michelangelo Pistoletto: Oggetti In meno, 1967. (da sinistra a destra: foto gigante di Jasper Johns; Corpo; Palline decorative; Vetrina di Indumenti; Colonne di cemento: Tavolino con piramide verde in legno. Germano Celant, «Arte Povera. Appunti per una guerriglia», in Flash Art, n. 5 Novembre-Dicembre 1967 conceptual art arte povera land art Copertina del catalogo della mostra Coceptual Art, Arte Povera, Land Art, a cura di Germano Celant, Galleria Civica d'Arte Moderna, Torino 1970 Gilberto Zorio: Untitled (Tubi dalmine. tela, acqua salata), 1967. Da un lato, quindi, un atteggia- mento ricco, perché legato osmoti- camente alle altissime possibilità stru- mentali ed informazionali che il siste- ma offre. un atteggiamento che imi- ta e media il reale, che crea la dico- tomia tra arte e vita, comporta- mento pubblico e vita privata, dal- l'altro una ricerca "povera", tesa al- l'identificazione azione-uomo, compon tamento-uomo, che elimina così i due piani di esistenza. Un esserci, quest'ul- timo, che predilige l'essenzialità infor- mazionale, che non dialoga ne col si- stema sociale, ne con quello cultu- rale, che aspira a presentarsi improv- viso, inatteso rispetto le aspettative convenzionali, un vivere asistemati- co, in un mondo In cui il sistema tutto. Un atteggiamento (che eviden- temente non vuol contrapporsi ad al- cuna ricerca particolare, risultando non una corrente, ma un modo di compor- tarsi, che evita persino la concorren- za, proprio per non cadere nuovamen te nell'integrazione alle leggi del si- stema e nel dialogo con lo stesso) teso al reperimento del significato fattuale del senso emergente del vi- vere dell'uomo. Un'identificazione uo- mo-natura, che non ha più il fine teo- logico del narrator-narratum medioe- vale, ma un Intento pragmatico, di li- berazione e di non aggiunzione di og- getti e idee al mondo, quale oggi si presenta. Di qui l'abolizione di ogni posizione categoriale (o pop od op o dell'incastro. Si pongono come appren- dimento immediato di ogni archetipo gestico, di ogni Invenzione primitiva. Sono gesti univoci che portano con se "tutti i possibili processi forma- tivi ed organizzativi", liberati da ogni contingenza storica e mondana. Dalle annotazioni gestiche di Boetti alle an- notazioni perimetrali e spaziali di Pri- ni, il passo è breve. Una stanza è e risuona di quattro angoli, un uomo s blocca in un passo da un metro, pavimento diventa scalino, la sedia è un'immagine platta sorretta da una sedia, ogni gesto di Prini si conclude nel presentarsi. Il dominio passa al- l'uomo dagli n sensi. L'autonomia domina incontrastata In Piacentino. Le sue "monumentali composizioni si Impongono, sono un'a- perta sfida alle convenzioni di spazio, di ambiente, Impossibile organizzarle, collocarle, plegarle al codice spazia- le abituale, seppur cromaticamente possedibili, al punto da lusingare la percezione colta dello spettatore, es- se sfuggono. Come la luce fugge, co- sì Il mondo. Per possederli bisogna bloccarli nell'attimo In cui si incontra- no. Così Merz violenta gli oggetti il reale con il neon. Il suo è un in- chiodare drammatico, che atterrisce. E' un continuo sacrificio dell'oggetto banale e quotidiano quasi novello cri- sto (il culto dell'oggetto è una nuova "religio"). Trovato Il chiodo, Merz da buon filisteo del sistema, crocifig- ge il mondo. Più sottilmente "povera" l'azione Incontro, il 23 novembre, Icaro e Ceroli che mi confermano che questo atteggiamento è ormai di molti ar- tisti. Alviani, Scheggi, Bonalumi, Co- lombo, Simonetti, Castellani, Bignardi, Marotta, De Vecchi, Tacchi, Boriani, Mondino, Nespolo. Questo testo nel suo farsi è già lacunoso. Siamo Infatti già alla guerriglia. Germano Celant 23-11-1967
Anselmo: Struttura, 1967. Prini: Perimetro, 1967. Boetti: Oggetto, 1967. di Anselmo. Qui la precarietà si esal- ta. Gli oggetti vivono nel momento di essere composti e montati, non esi- stono come oggetti immutabili, si ri- compongono di volta in volta, la loro esistenza dipende dal nostro inter- vento e dal nostro comportamento. Non sono prodotti autonomi, ma insta- bili, vivi in rapporto al nostro vivere. Infine le "entità espressive" di Zo- rio, enfantizzazioni visuali di un avve- nimento instabile. Così la violenza del tubi dalmine, dei colori, dei cementi, dialoga con la precarietà del tempo, con la sottile instabilità del maglio, che sta per cadere sulla "sedia", con il graduale cristallizzarsi dell'acqua sa- lata, con la incredibile resistenza del- l'elemento elastico rispetto alla strut- tura d'acciaio. Un'imprevedibile coe- sistenza tra forza e precarietà esi- stenziale che sconcerta, pone in cri- si ogni affermazione, per ricordarci che ogni "cosa" è precaria, basta in- frangere il punto di rottura ed essa salterà. Perché non proviamo col mondo? Piero Gilardi: Carrello. Mixted media,