La forza gravitazionale: legge di gravitazione universale di Newton
Slide sulla forza gravitazionale. Il Pdf, adatto per la scuola superiore e la materia di Fisica, introduce la legge di gravitazione universale di Isaac Newton, la costante di gravitazione universale e la formula della forza gravitazionale.
See more14 Pages

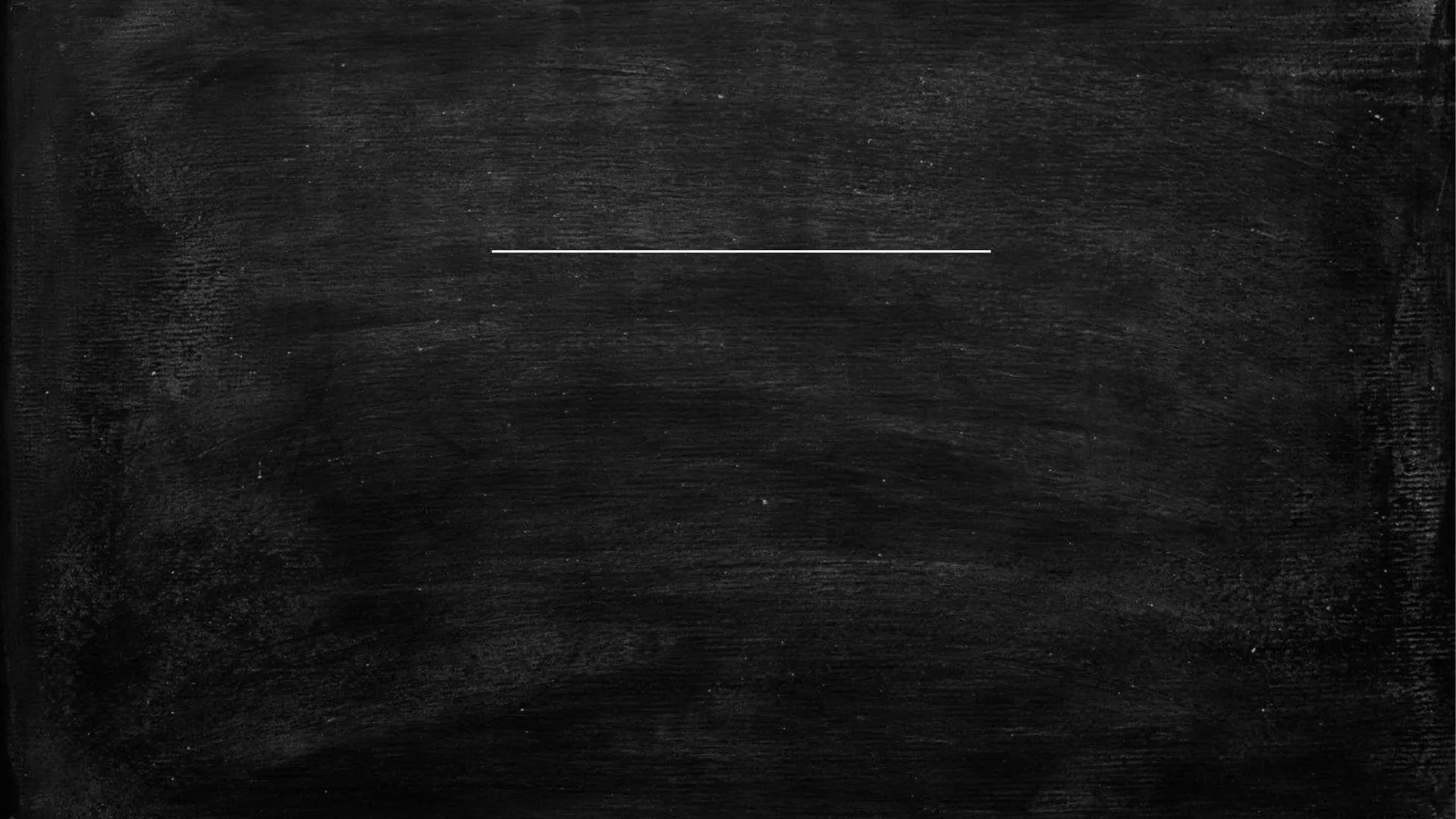
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
La forza gravitazionale
Isaac Newton, scienziato cui si devono le tre leggi della dinamica, enunciò la legge di gravitazione universale nella sua opera Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687), in termini coerenti con le osservazioni disponibili a quei tempi, e in accordo con i principi della dinamica da lui stesso enunciati. L'enunciato è sufficiente a spiegare gran parte dei fenomeni che ci circondano ancora oggi.Due corpi dotati di massa si attraggono con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa.
Legge di gravitazione universale
legge di gravitazione universale: due corpi puntiformi di massa m1 e m2 e distan- ti r si attraggono l'un l'altro con una forza che
- agisce lungo la retta congiungente i due corpi;
- ha modulo F = G mim2 r2 (1)
La costante G vale: G = 6,674 . 10-11 N·m2/kg2La costante di gravitazione universale Questa costante è estremamente importante ed è nota come costante di gravitazione universale. Si chiama "universale" in quanto il suo valore non cambia al cambiare dell'osservatore e del sistema di riferimento.m2 r F2 F1 mı F1 = F2 = G m1 m2 p2
DENTRO LA FORMULA
- L'attrazione gravitazionale tra due corpi diminuisce all'aumentare della di- stanza.
- L'attrazione gravitazionale tra due corpi è una forza con raggio d'azione infinito: è diversa da zero per ogni valore di r.
- G è detta costante di gravitazione universale perché ha lo stesso valore per qualunque coppia di masse, ovunque esse si trovino nell'Universo.
- Il valore di G è molto piccolo: per questa ragione non sentiamo l'attrazione gravitazionale degli oggetti attorno a noi ma sentiamo solo quella della Ter- ra, che ha una massa enorme (6- 1024 kg).
PER ESEMPIO
Le attrazioni di un pallone da calcio
Un pallone da calcio ha massa 0,45 kg.
- Con quale intensità si attraggono due palloni a distanza di 1 m?
- Con quale intensità si attraggono un pallone e la Terra?
Due palloni da calcio distanti 1 m si attraggono con una forza di intensità F = (6,7 . 10-11 N·m2/kg2) (0,45 kg)(0,45 kg) (1 m)2 ~ 1.10-11 N Il pallone da calcio e la Terra (m = 6,0 · 1024 kg), invece, hanno una distanza che possiamo considerare pari al raggio della Terra stessa (r = 6,4· 10° m). Perciò si attraggono con una forza di intensità F = (6,7 - 10-11 N·m2/kg2) (0,45 kg)(6,0- 1024 kg) (6,4 · 106 m) 2 ≥ 4 N L'attrazione gravitazionale fra i due palloni è del tutto trascurabile rispetto a quella fra un pallone e la Terra. In generale, l'attrazione gravitazionale fra due corpi diventa significativa solo quando almeno uno di essi ha una massa molto grande.
Esempio: Calcolo della forza di gravità tra alunni
Calcolare l'intensità della forza di gravità che agisce tra due alunni di massa m1= 70 kg e m2= 65 kg distanti 2,5 m l'uno dall'altro. Sostituiamo direttamente nella formula e otteniamo: F = 6,67 . 10^(-11) . 70 . 65/ 2,5 = 4,8 . 10^(-8) N Invece il peso dei due alunni, supponendo che siano sulla superficie terrestre, è pari a: P1 = 65 kg · 9,8 m/s^2 = 637 N = 6,37 .10^{2} N P2 = 70 kg · 9,8 m/s^2 = 686 N = 6,86 .10^{2} N
Differenza tra peso e forza gravitazionale
Osservando la differenza tra l'ordine di grandezza del peso e quello della forza gravitazionale (ben dieci ordini!), non ci si stupisce che i due alunni rimangano dove sono e non volino l'uno contro l'altro. Tutt'altro discorso invece sarebbe trattare il medesimo problema nel vuoto: in assenza di un'accelerazione g, i due alunni inizierebbero a muoversi lungo la retta che li congiunge, seppur molto lentamente.!
Attrazione gravitazionale e peso dei corpi
La massa m di un corpo è una misura della sua inerzia. Invece il peso P di un corpo è la forza gravitazionale che la Terra esercita su di esso. Per semplicità, con il termine «peso» spesso si indica il modulo di P. Al livello del mare, il peso di un corpo di massa m è una forza che è diretta verso il centro della Terra e ha modulo P = G mMT rã (2) dove MT e rT sono la massa e il raggio della Terra. Il peso di un corpo dipende dall'altezza a cui si trova: se un corpo è a un'altezza h dal suolo, il suo peso è (rT + h)2 mMT P = G ed è minore del suo peso al livello del mare, perché il denominatore nella formula aumenta da ri a (rT + h)2.
L'accelerazione di gravità
Consideriamo un corpo di massa m al livello del mare.
- Peso e massa del corpo sono legati dal secondo principio della dinamica: P = mg m 10 II peso è la forza con cui la Terra at- trae il corpo: mMT P=GTM rt m 10 MT Se uguagliamo i secondi membri delle equazioni precedenti, otteniamo mg = G mMT rt e quindi l'accelerazione di gravità è g = G MT
DENTRO LA FORMULA
La relazione spiega le proprietà già note dell'accelerazione di gravità g:
- non dipende dalla massa m del corpo;
- al livello del mare è costante perché G, MT e rT sono costanti. La relazione (3) fornisce il valore di g sulla superficie terrestre: g = (6,7· 10-11 N·m2/kg2) 6,0 - 1024 kg (6,4 . 10° m) 2 & 9,8 m/s2 (3)
Principio di azione-reazione e leggi di Keplero
Per sua stessa definizione, la forza di gravità sussiste come interazione tra due corpi: in base al principio di azione-reazione, il modulo della forza esercitata da un corpo sull'altro deve essere uguale. Mediante l'applicazione rigorosa dei principi della dinamica e presupponendo che tra due corpi sussistesse solo l'interazione gravitazionale, da lui stesso enunciata, Newton riuscì a dimostrare le tre leggi di Keplero.
Osservazione della volta celeste e modelli cosmologici
L'uomo fin dall'antichità ha osservato la volta celeste, notando una certa regolarità nel moto dei corpi celesti. Queste regolarità hanno consentito di misurare lo scorrere del tempo associandolo al presentarsi di particolari eventi, come l'alternanza del buio e della luce causata dal moto apparente del Solo rispetto alla Terra. Per spiegare questi moti:
- V sec. a.C. modello GEOCENTRICO
- III sec. a.C. Aristarco da Samo modello ELIOCENTRICO
- 1543 N. Copernico Modello ELIOCENTRICO più preciso in grado di descrivere i moti dei pianeti fino allora conosciuti moto circolare uniforme
DISTINZIONE NETTA TRA LA FISICA DEL CIELO E QUELLA DELLA TERRA
Proprietà dell'ellisse
L'ellisse è una figura piana caratterizzata dalla seguente proprietà: la somma delle distanze di ogni suo punto da due punti fissi F1 e F2, detti fuochi, è co- stante: AF1+ AF2 = BF1+ BF2
- L'ellisse ha due assi di simmetria: quello che passa per i fuochi si chiama asse maggiore; l'altro, perpen- dicolare al primo, si chiama asse minore. Per caratte- rizzare l'ellisse si usa la lunghezza dei semiassi, indi- cati in genere con a e b. A b semiasse minore F. a F2 semiasse maggiore B Quanto più la distanza tra i due fuochi è piccola rispetto al semiasse, tanto più l'el- lisse è simile a una circonferenza. Quando poi i due fuochi coincidono, l'ellisse di- venta una circonferenza: i due semiassi sono uguali e coincidono con il raggio. a piccola rispetto ad a
Le leggi di Keplero
La prima legge di Keplero
Prima legge di Keplero: le orbite dei pianeti attorno al Sole sono ellissi di cui il Sole occupa uno dei fuochi. Il punto dell'orbita più vicino al Sole è detto perielio, mentre quello più lontano è detto afelio. pianeta F, F2 perielio O afelio Sole Per tutti i pianeti del Sistema Solare la di- stanza tra i fuochi è molto minore della lunghezza dei rispettivi semiassi, quindi le orbite planetarie sono molto simili a cir- conferenze. Se disegnassimo l'orbita terrestre come un'ellisse con semiasse maggiore di 1 km, la differenza con una circonferenza di rag- gio 1 km sarebbe contenuta in poco più di 10 cm.
- Primi anni del 600 Keplero
La seconda legge di Keplero
Dopo aver stabilito che le orbite dei pianeti non sono circolari, Keplero scopre che non vengono percorse a velocità costante. Egli formula tale proprietà in termini di raggi vettori di un pianeta. Il raggio vettore è l'ipotetico segmento che congiunge un pianeta con il Sole. Men- tre il pianeta orbita attorno al Sole, il raggio vettore si muove nel tempo. Seconda legge di Keplero: il raggio vettore di un pianeta spazza aree uguali in tempi uguali. La figura mostra le aree spazzate nello stesso in- tervallo di tempo dal raggio vettore di un pianeta in due punti dell'orbita. La seconda legge stabi- lisce che le due aree sono uguali. Poiché i raggi vettori del pianeta quando percorre l'arco AA' sono minori di quelli relativi all'arco BB', il pia- neta si muove con velocità maggiore lungo l'ar- co AA' Dunque, dalla seconda legge di Keplero si dedu- ce che A Sole A' B B aree uguali un pianeta si sposta con velocità maggiore quando è più vicino al Sole: lungo la sua orbita, un pianeta ha la velocità massima al perielio e la velocità minima all'afelio. La Terra transita al perielio nei primi giorni di gennaio: questo spiega per- ché nel nostro emisfero il periodo autunno-inverno è più corto di circa sei giorni rispetto al periodo prima- vera-estate. perielio autunno- inverno primavera-estate afelio P P raggio vettore Sole
La terza legge di Keplero
Il moto di un pianeta attorno al Sole è caratterizzato da due parametri fondamentali: la lunghezza del semiasse maggiore a dell'orbita e il periodo di rivoluzione T necessario per completare un giro attorno al Sole. Keplero scopre che i due parame- tri non sono indipendenti: la relazione che li lega è espressa dalla terza legge. Terza legge di Keplero: il rapporto fra il cubo del semiasse maggiore a dell'or- bita e il quadrato del periodo di rivoluzione T attorno al Sole è lo stesso per tutti i pianeti: a3 T2 = costante Per esempio, la Terra e Marte hanno periodi di rivoluzione diversi e si muovono su orbite con semiassi diversi, ma aT Tỉ = aM TM 3