Fisiologia umana: diffusione, omeostasi e trasporto di membrana
Documento di Università sulla fisiologia umana, diffusione, omeostasi e trasporto di membrana. Il Pdf, utile per studenti universitari di Biologia, approfondisce concetti chiave come il potenziale di equilibrio elettrochimico degli ioni e la fisiologia renale.
Mostra di più36 pagine

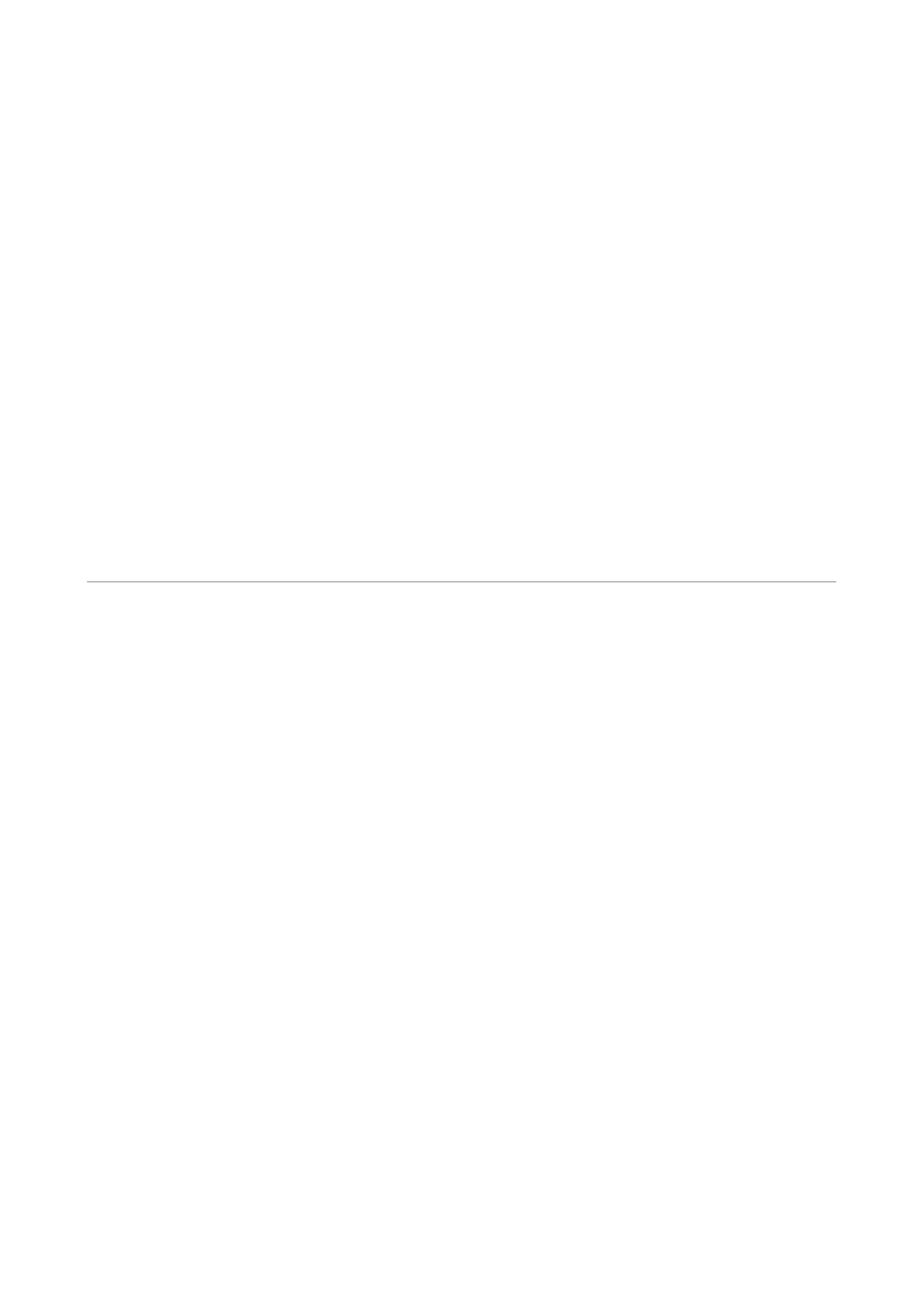
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Diffusione attraverso Membrane Biologiche
1) Spiegare il concetto di diffusione attraverso membrane biologiche: a) quale forza spinge la diffusione? b) quali parametri sono importanti nel determinare la velocità di diffusione?
- Diffusione: È il movimento netto di molecole o ioni da un'area di maggiore concentrazione a un'area di minore concentrazione.
- a) Forza che spinge la diffusione: La forza che spinge la diffusione è il gradiente di concentrazione (o gradiente elettrochimico, se ci sono anche cariche elettriche). Le molecole si muovono "secondo gradiente", cioè dove sono più concentrate verso dove sono meno concentrate.
- b) Parametri importanti per la velocità di diffusione:
- Gradiente di concentrazione: Maggiore è la differenza di concentrazione, più veloce è la diffusione.
- Superficie della membrana: Maggiore è l'area disponibile per la diffusione, più veloce è.
- Spessore della membrana: Maggiore è lo spessore, più lenta è la diffusione.
- Distanza da percorrere: Maggiore è la distanza, più lenta è la diffusione.
- Permeabilità della membrana: Le molecole che passano più facilmente attraverso la membrana diffondono più velocemente.
- Dimensione delle molecole: Molecole più piccole diffondono più velocemente.
- Temperatura: Temperature più alte aumentano l'energia cinetica delle molecole e la velocità di diffusione.
Omeostasi e Meccanismi di Controllo
2) Spiegare il concetto di omeostasi e il principale meccanismo di controllo attraverso il quale i sistemi fisiologici mantengono l'equilibrio omeostatico dell'organismo.
- Omeostasi: È la capacità del corpo di mantenere un ambiente interno relativamente stabile, nonostante i cambiamenti nell'ambiente esterno o interno. È un equilibrio dinamico, non statico.
. Meccanismo di Controllo Principale (Feedback Negativo): Questo è il meccanismo più comune e importante. Funziona così:
- Stimolo: Una variabile interna (es. temperatura corporea, glicemia) si allontana dal suo valore normale (set point).
- Sensore/Recettore: Rileva il cambiamento.
- Centro di Controllo: Riceve l'informazione dal sensore, la elabora e decide la risposta.
- Effettore: Mette in atto la risposta che inverte il cambiamento iniziale, riportando la variabile al suo set point.
- Esempio: Se la temperatura corporea aumenta, i sensori nella pelle e nell'ipotalamo lo rilevano. L'ipotalamo (centro di controllo) attiva le ghiandole sudoripare (effettori) per raffreddare il corpo, riportando la temperatura alla normalità.
Trasporto Attivo e Passivo
3) Spiegare la differenza tra trasporto attivo e trasporto passivo di sostanze attraverso una membrana cellulare e fare un esempio per ciascun tipo di trasporto.
- Trasporto Passivo:
- Definizione: Non richiede energia metabolica diretta (ATP). Le sostanze si muovono secondo il loro gradiente di concentrazione o elettrochimico.
- Esempi:
- Diffusione semplice: Molecole piccole e liposolubili (es. 02, CO2) passano direttamente attraverso il doppio strato lipidico.
- Diffusione facilitata: Molecole più grandi o cariche (es. glucosio, ioni) passano attraverso canali o proteine trasportatrici, ma sempre secondo gradiente.
- Osmosi: Movimento dell'acqua attraverso una membrana semipermeabile.
- Trasporto Attivo:
- Definizione: Richiede energia metabolica diretta (ATP). Le sostanze si muovono contro il loro gradiente di concentrazione o elettrochimico, da un'area di bassa a un'area di alta concentrazione.
- Esempi:
- Pompa Sodio-Potassio (Na+/K+ ATPasi): Pompa 3Na+ fuori dalla cellula e 2K+ dentro la cellula, contro i rispettivi gradienti. È fondamentale per mantenere il potenziale di membrana e per molte funzioni cellulari.
- Pompe a ioni idrogeno: Coinvolte nella secrezione di acido nello stomaco o nel rene.
SISTEMA NERVOSO
Potenziale di Equilibrio Elettrochimico
4) Spiegare cos'è il potenziale di equilibrio elettrochimico per uno ione, includendo: a) Qual è il potenziale d'equilibrio per gli ioni sodio e potassio? b) Perché il potenziale di membrana a riposo di una cellula nervosa è molto vicino al potenziale di equilibrio del K+?
- Potenziale di Equilibrio Elettrochimico: È il potenziale di membrana teorico a cui la forza elettrica che agisce su uno ione (dovuta alla carica dello ione e al potenziale di membrana) è esattamente uguale e opposta alla forza chimica (dovuta al gradiente di concentrazione dello ione). A questo potenziale, non c'è un movimento netto di quello specifico ione attraverso la membrana. Si calcola con l'equazione di Nernst.
- a) Potenziali di equilibrio approssimati:
- Sodio (Na+): Circa +60 mV (il sodio tende a entrare nella cellula per gradiente di concentrazione, quindi per fermarlo ci vuole un interno molto positivo).
- Potassio (K+): Circa -90 mV (il potassio tende a uscire dalla cellula per gradiente di concentrazione, quindi per fermarlo ci vuole un interno molto negativo).
- b) Perché il potenziale di membrana a riposo è vicino a quello del K+:
- A riposo, la membrana cellulare di un neurone è molto più permeabile agli ioni potassio (K+) rispetto agli ioni sodio (Na+) o ad altri ioni.
- Questo è dovuto alla presenza di molti canali del potassio "a riposo" (o di "leakage") che sono aperti, permettendo al K+ di fuoriuscire dalla cellula (secondo il suo gradiente di concentrazione).
- Anche se la pompa Na+/K+ ATPasi mantiene i gradienti, la predominante permeabilità al K+ fa sì che il potenziale di riposo (circa -70mV) si avvicini molto al potenziale di equilibrio del K+ (-90mV), anche se non è identico per il piccolo ingresso di Na+.
Potenziale d'Azione e Canali Voltaggio-Dipendenti
5) Spiegare come i canali voltaggio-dipendenti producono il potenziale d'azione e perché si tratta di un fenomeno tutto-o-nulla. Includere il grafico del potenziale d'azione con indicazione di apertura e chiusura di canali voltaggio-dipendenti e dei periodi refrattari.
- Potenziale d'Azione: È un rapido e transitorio cambiamento del potenziale di membrana di una cellula eccitabile (neurone, cellula muscolare) che si propaga lungo la membrana.
- Canali Voltaggio-Dipendenti: Sono proteine che attraversano la membrana e
formano dei canali. Si aprono o si chiudono in risposta a cambiamenti nel potenziale
elettrico della membrana.
- Canali del Sodio Voltaggio-Dipendenti (Na+): Sono responsabili della fase di depolarizzazione (aumento) del potenziale d'azione.
- Canali del Potassio Voltaggio-Dipendenti (K+): Sono responsabili della fase di ripolarizzazione (diminuzione) e iperpolarizzazione.
- Fasi del Potenziale d'Azione (con grafico immaginario):
- Potenziale di Riposo: La cellula è a circa -70mV, canali Na+ e K+ voltaggio- dipendenti sono chiusi.
- Stimolo e Depolarizzazione a Soglia: Uno stimolo (es. da un altro neurone) causa una depolarizzazione locale. Se questa depolarizzazione raggiunge una "soglia" (es. - 55mV), si aprono rapidamente i canali del sodio voltaggio- dipendenti.
- Fase di Depolarizzazione (Rapida): Molti ioni Na+ entrano velocemente nella cellula, rendendo l'interno positivo (fino a circa +30mV). I canali K+ voltaggio- dipendenti iniziano ad aprirsi lentamente.
- Fase di Ripolarizzazione: I canali del sodio voltaggio-dipendenti si inattivano (si chiudono), e i canali del potassio voltaggio-dipendenti (che si sono aperti più lentamente) sono ora completamente aperti. Ioni K+ escono dalla cellula, rendendo l'interno di nuovo negativo.
- Iperpolarizzazione (o sottosoglia): I canali del potassio si chiudono lentamente, causando un'eccessiva fuoriuscita di K+ e un potenziale che diventa più negativo del potenziale di riposo per un breve periodo.
- Ritorno al Potenziale di Riposo: La pompa Na+/K+ ATPasi ripristina i gradienti ionici.
- Fenomeno "Tutto-o-Nulla": Un potenziale d'azione si verifica completamente o non si verifica affatto. Se lo stimolo raggiunge la soglia, il potenziale d'azione si genererà con la sua massima ampiezza, indipendentemente dalla forza dello stimolo. Stimoli più forti non producono potenziali d'azione più grandi, ma possono generare più potenziali d'azione in un dato tempo (maggiore frequenza).
- Periodi Refrattari:
- Assoluto: Durante la fase di depolarizzazione e parte della ripolarizzazione, la cellula non può generare un nuovo potenziale d'azione, indipendentemente dalla forza dello stimolo, perché i canali del sodio sono inattivati.
- Relativo: Durante la fase di iperpolarizzazione, è possibile generare un nuovo potenziale d'azione, ma solo con uno stimolo più forte del normale, perché i canali del potassio sono ancora parzialmente aperti e si richiede una depolarizzazione maggiore per raggiungere la soglia.
Propagazione del Potenziale d'Azione e Mielina
6) Spiegare come il potenziale d'azione si propaga attivamente lungo l'assone di una cellula nervosa e in che modo la mielina migliora tale propagazione.
- Propagazione del Potenziale d'Azione:
- Una volta generato, il potenziale d'azione si propaga lungo l'assone senza diminuire di ampiezza.
- Il rapido ingresso di Na+ che depolarizza una sezione della membrana crea correnti locali che depolarizzano la sezione adiacente, portandola a soglia e generando un nuovo potenziale d'azione.
- Poiché la sezione di membrana appena depolarizzata entra in periodo refrattario, l'impulso può propagarsi solo in una direzione, lontano dal punto di origine.
- Ruolo della Mielina: La mielina è una guaina lipidica isolante che avvolge gli assoni di
molti neuroni (formata da cellule di Schwann nel SNP e oligodendrociti nel SNC).
- Saltatoria (Conduzione Saltatoria): La mielina non copre l'intero assone, ma lascia delle interruzioni chiamate nodi di Ranvier.
- Nei tratti mielinizzati, la mielina impedisce la dispersione di ioni attraverso la membrana, agendo come un isolante. La corrente si propaga passivamente e molto rapidamente tra un nodo e l'altro.
- I potenziali d'azione vengono generati solo ai nodi di Ranvier, dove i canali voltaggio-dipendenti sono concentrati. L'impulso "salta" da un nodo all'altro, aumentando drasticamente la velocità di conduzione (fino a 150 m/s) rispetto agli assoni non mielinizzati, e risparmiando energia (meno pompe Na+/K+ ATPasi necessarie).
Sinapsi Chimica e Potenziale Post-Sinaptico
7) Spiegare i passaggi intermedi tra l'arrivo di un potenziale d'azione in un terminale presinaptico e la generazione di un potenziale eccitatorio o inibitorio (EPSP o IPSP) nella membrana post-sinaptica.
- Sinapsi Chimica: La comunicazione tra neuroni avviene tramite una sinapsi chimica.
- Arrivo del Potenziale d'Azione: Un potenziale d'azione arriva al terminale presinaptico (la fine dell'assone del neurone che invia il segnale).
- Apertura Canali Ca++: La depolarizzazione del terminale presinaptico apre i canali del calcio (Ca++) voltaggio-dipendenti.
- Ingresso di Ca++: Gli ioni Ca++ entrano nel terminale presinaptico.
- Rilascio Neurotrasmettitore: L'ingresso di Ca++ innesca la fusione delle vescicole contenenti neurotrasmettitori (sostanze chimiche di segnalazione) con la membrana presinaptica, rilasciando il neurotrasmettitore nello spazio sinaptico.
- Legame Neurotrasmettitore: Il neurotrasmettitore si diffonde attraverso lo spazio sinaptico e si lega a recettori specifici sulla membrana post-sinaptica (del neurone che riceve il segnale).
- Apertura Canali Ionici: Il legame del neurotrasmettitore ai recettori provoca l'apertura di canali ionici sulla membrana post-sinaptica.
- Generazione di EPSP o IPSP:
- EPSP (Potenziale Post-Sinaptico Eccitatorio): Se l'apertura dei canali permette l'ingresso di ioni positivi (es. Na+), la membrana post-sinaptica si depolarizza (diventa meno negativa). Questo rende più probabile la generazione di un potenziale d'azione nel neurone post-sinaptico.
- IPSP (Potenziale Post-Sinaptico Inibitorio): Se l'apertura dei canali permette l'uscita di ioni positivi (es. K+) o l'ingresso di ioni negativi (es.