La poetica di Giacomo Leopardi e Umberto Saba: analisi e opere principali
Documento su Giacomo Leopardi e Umberto Saba, esplorando la loro poetica e opere principali. Il Pdf, utile per la scuola superiore, analizza i Canti e gli Idilli di Leopardi e i temi di Saba, fornendo esempi testuali e commenti per la materia Letteratura.
Mostra di più40 pagine
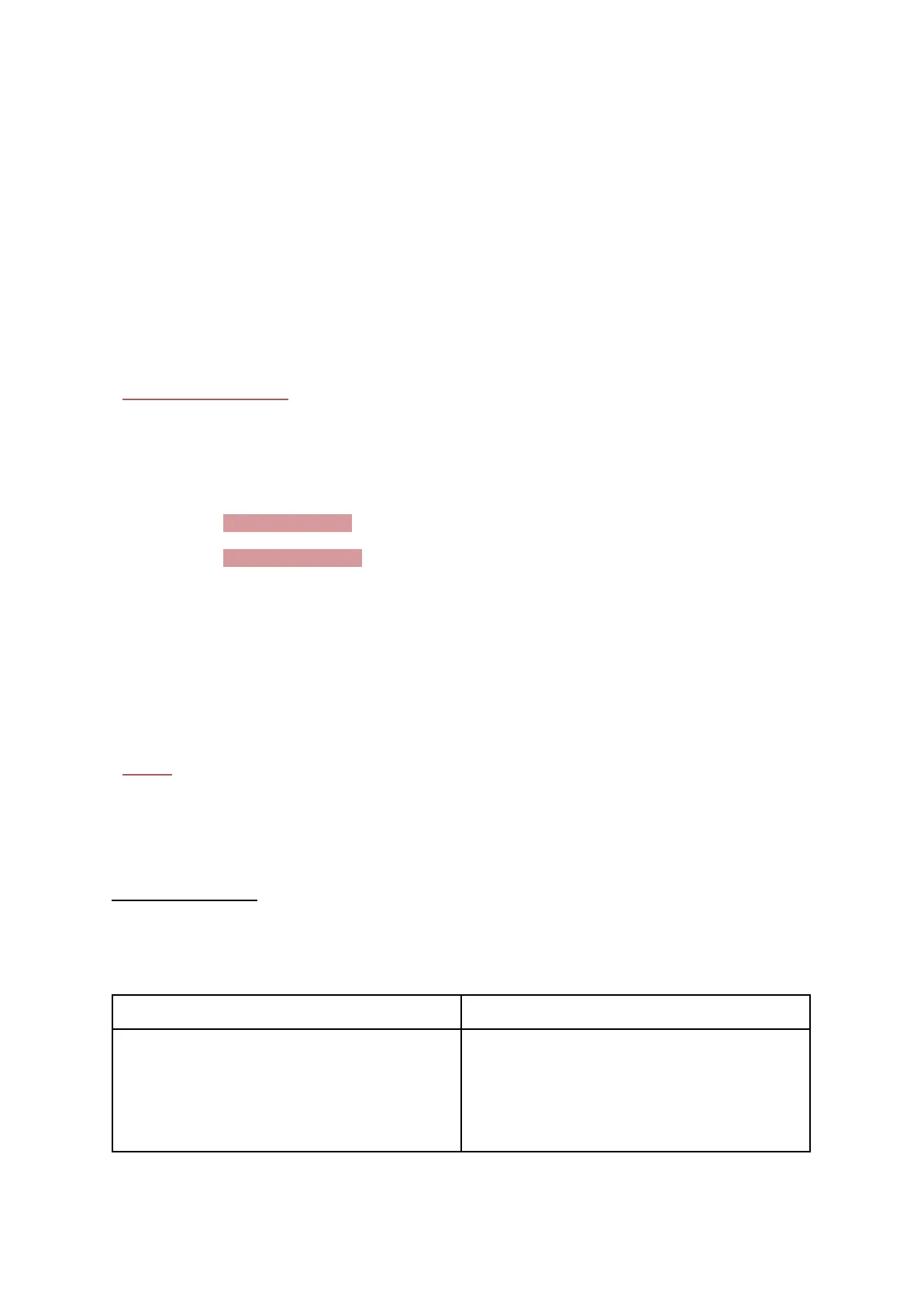
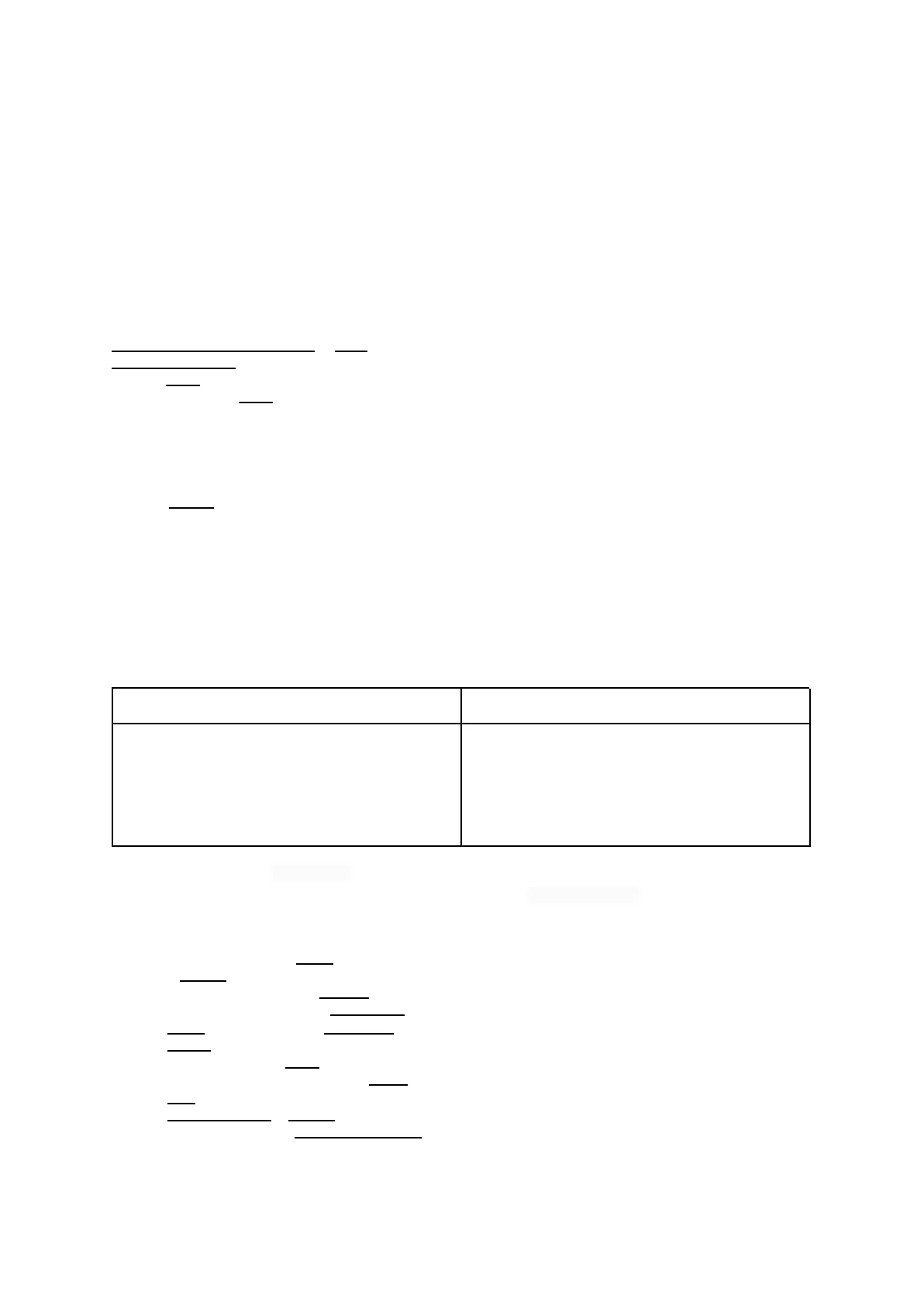
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
GIACOMO LEOPARDI
Nella sua breve vita Leopardi rivoluzionò la poesia italiana, e portò contributi nel campo della filologia e della cultura classica. Tuttavia trascorse una vita caratterizzata da solitudine e infelicità, emozioni che si evincono nelle sue opere. Nacque il 29 giugno 1798 a Recanati in una famiglia nobile. Studio intensamente nella biblioteca del padre, ma lo studio eccessivo gli causò problemi fisici e lo portò a riflettere sulla condizione umana. Passò dalla poesia alla filosofia, sviluppando il suo pessimismo storico, secondo cui il male nasce dalla società moderna. Tentò di fuggire da Recanati, ma senza successo. Si trasferì poi a Firenze, dove conobbe Antonio Ranieri e si innamoro, non ricambiato, di Fanny Targioni Tozzetti. Morì il 14 giugno 1837 a Napoli, dopo aver profondamente rinnovato la poesia italiana.
La poetica leopardiana
Quando parliamo di poetica leopardiana, facciamo riferimento non solo alle opere dell'autore, ma anche alle sue idee:
- Produzione:
- Poesia (Canti)
- Prosa (Operette morali; Zibaldone)
- Riflessione:
- Pessimismo storico = uomo infelice a causa del progresso, dell'affidamento sulla ragione e dell'allontanamento dalla natura (ripresa del mito dell'età dell'oro)
- Pessimismo cosmico = uomo sempre stato infelice poiché la natura ci è avversa (siamo circondati dal male). L'autore parla di pessimismo metafisico (in particolare nelle operette morali).
- Temi:
- Con il progresso, l'uomo ha perso la capacità di immaginare, dando vita a una poesia più sentimentale. Leopardi sostiene che l'uomo desidera un piacere infinito, ma soffre quando ne scopre i limiti.
- Anche il ricordo è centrale, legato soprattutto alla fanciullezza, fase vista con nostalgia e idealizzazione.
I Canti (1816-1837)
- È un libro organico, con poesie disposte secondo un ordine preciso.
- È un'opera lirica, in cui l'autore parla sempre di sé.
- Dopo le prime nove canzoni, adotta strutture metriche più libere, creando la "canzone libera".
- Tratta temi classici come natura, amore e morte, ma con una profondità originale.
Le edizioni principali: 1831: prima stampa fiorentina. 1835: stampa napoletana. 1845: edizione postuma curata da Antonio Ranieri, considerata la definitiva. Ha un ordine quasi cronologico ed è suddivisa in blocchi tematici.
Canzoni
TEMI FORMA
- Temi civili Virtù e valori dei Greci e dei Romani + Infelicità umana (legata proprio alla regressione della civiltà -> pessimismo storico)
- Superamento della tradizione metrica, il cui modello era fino a questo momento rimasto Petrarca Sintassi ampia, complessa, ricca di subordinate + Lessico è aulico e arcaizzante
Leopardi vive nell'epoca romantica ma era legato ai classici.Il Romanticismo è un fenomeno europeo, in Italia, invece, fatica ad affermarsi perché appunto legata ancora ai classici. I romantici volevano eliminare la mitologia classica dalla poesia, ormai considerata vecchia e inutile; mentre i classicisti la difendevano.
Ultimo canto di Saffo (1822; Canti, IX)
Leopardi immagina l'ultima poesia che Saffo ha recitato prima di suicidarsi nell'isola di Lesbo (a causa del rifiuto da parte dell'amato/a). La tradizione racconta che Saffo fosse una grande poetessa, ma una donna non particolarmente avvenente (si immedesima) -> si chiede come possa esserci questa dicotomia tra una grande sensibilità e un aspetto così poco armonico. Qual è la colpa di Saffo - si chiede l'autore: il destino viene deciso dagli dei. Dal punto di vista metrico, è ancora in parte legato alla tradizione. Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella -> Metafora per indicare il cielo, che avvolge la terra come un mantello; la natura viene descritta bella e accogliente -> Utilizzo di petrarchismi (lessico raffinato e complesso) Sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta Infinita beltà parte nessuna Alla misera Saffo i numi e l'empia Sorte non fenno. A' tuoi superbi regni Vile, o natura, e grave ospite addetta, E dispregiata amante, alle vezzose Tue forme il core e le pupille invano Supplichevole intendo. A me non ride L'aprico margo, e dall'eterea porta Il mattutino albor; me non il canto De' colorati augelli, e non de' faggi Il murmure saluta: e dove all'ombra Degl'inchinati salici dispiega Candido rivo il puro seno, al mio Lubrico piè le flessuose linfe Disdegnando sottragge, E preme in fuga l'odorate spiagge. -> Nonostante la natura sia bella, a Saffo la bellezza non è arrivata -> Latinismo Come Saffo è sfortunata, anche Leopardi lo è; si domanda se la natura sia veramente accogliente: se sono infelice, può la natura essere buona? è come se si domandasse Leopardi, che non si riconosce nella natura bella
Idilli (XII-XVI)
TEMI FORMA
- Poetica del vago e dell'indefinito Poetica del ricordo
- Due protagonisti: l'io e la natura benigna
- Interpreta Il genere in modo diverso dalla tradizione: il mondo naturale fa da sfondo all'io del poeta Sintassi più semplice rispetto alle canzoni Linguaggio piano e comprensibile
L'infinito (1819; Canti, XII)
Metro: endecasillabi sciolti = non ci sono rime (si avvicina alla poesia moderna). La natura viene vista come accogliente, perché rimanda all'infinito. Esso viene colto dall'uomo non distaccandosi dalla realtà, ma stando a contatto con la natura (è ancora nella sua fase giovanile). Sempre caro mi fu quest'ermo colle, E questa siepe, che da tanta parte Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati Spazi di là da quella, e sovrumani Silenzi, e profondissima quiete Io nel pensier mi fingo; ove per poco Il cor non si spaura. E come il vento Odo stormir tra queste piante, io quello Infinito silenzio a questa voce Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, E le morte stagioni, e la presente -> Lessico semplice -> Si trova in mezzo alla natura, la contempla (pessimismo storico -> la natura e accogliente) Esalta due elementi naturali: colle e siepe -> Enjambement = creano un ritmo lento, per cogliere la bellezza della natura -> Riflette -> Sensi coinvolti = vista e udito -> Associa il vento all'infinito (elemento dell'assoluto, dell'eternità) -> Parole bisillabiche e polisillabiche che conferiscono un ritmo lento (comparando) e veloce (profondissima) in base all'accento E viva, e il suon di lei. Così tra questa Immensità s'annega il pensier mio: -> All'interno dell'assoluto, si sta bene -> Anticipa alcune riflessioni ("teoria del piacere" sono poetiche tutte le parole che danno un senso di indefinito; parole come intensità danno sensazioni fittizie). L'indefinito contribuisce all'immaginazione E il naufragar m'è dolce in questo mare. - > Deittici = pronomi dimostrativi che indicano la posizione del poeta nello spazio e nel tempo (indicano che la bellezza è vicina a noi, ci circonda)
Canti pisano-recanatesi (XX-XXV)
Canti pisano-recanatesi (XX-XXV) = detti anche "grandi idilli" da De Sanctis (messo in discussione perché indica una continuità con gli idilli). . Il nome deriva dal fatto che sono poesie scritte tra Pisa e Recanati TEMI FORMA
- "Io" come voce universale L'io è più complesso = sente e pensa, utilizzando la poesia per esprimere la propria visione del mondo
- Infelicità umana e indifferenza della natura (ora vista come responsabile dei suoi mali)
- Poetica del ricordo: il ricordo ora è a sua volta motivo di dolore Tema del piacere visto in modo negativo, generato da un'assenza (il dolore) Poetica del "vago e indefinito"
- Canzone libera leopardiana
- Lessico "vago e indefinito"
- Uso di apostrofi, esclamazioni e domande dirette; proliferare di interlocutori «O natura, o natura -> Si lamenta contro la natura -> Illusione di una vita serena Perché non rendi poi quel che prometti allor? perché di tanto inganni i figli tuoi?» (A Silvia; Canti, XXI)
Ciclo di Aspasia
Ciclo di Aspasia = Leopardi paragana Fanny ad Aspasia, una donna colta che, secondo quanto racconta Plutarco, riesce a far innamorare Pericle e viene accusata di empietà contro gli dei e di induzione alla prostituzione. . Qui Leopardi esprime la sua delusione e la sua illusione d'amore, accentuando per l'appunto l'aspetto della prostituzione. · Fanny Targioni Tozzetti fu l'ultima donna di cui l'autore si innamorò, non ricambiato. · Quelle per Aspasia sono dunque poesie d'amore (non corrisposto): inizio apparentemente fiducioso, finale amaro e disperato (in una delle prime poesie viene espressa la possibilità di una gioia reale, in un altra è invece presente un'invocazione alla morte, affinché arrivi in fretta)
Canzoni sepolcrali
TEMI FORMA
- Natura caduca della bellezza e suo annientamento nella morte (canzoni sepolcrali) Vanità dei progressi sociali e scientifici
- Sofferenza comune e solidarietà fra gli uomini
- Satira (Leopardi finge di rinunciare alle sue idee e celebra ironicamente il progresso del suo tempo, ma in realtà ne mette in luce il lato ridicolo. Critica l'entusiasmo cieco verso il progresso, ricordando che l'uomo resta infelice per natura, indipendentemente dai miglioramenti scientifici o politici.)
Testimonianze spirituali di Leopardi
Testimonianze spirituali di Leopardi = racconta la sua idea di mondo
La ginestra o il fiore del deserto (1836; Canti, XXXIV)
Integrata come ultimo testo nell'edizione postuma dei Canti, a cura di Antonio Ranieri (1845). L'autore torna ad una poesia complessa (lessico aulico, sintassi elaborata), ma il metro resta libero. Si tratta di una poesia filosofica: rappresenta il suo testamento spirituale. Qui Leopardi, infatti, medita sull'universo e sulla condizione umana (pessimismo cosmico) -> cadono tutte le illusioni. Inizia con una citazione del Vangelo: critica verso il genere umano che non riconosce la verità, ovvero che siamo infelici "E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce" (Giovanni, III, 19).La prima strofa introduce subito al pessimismo cosmico e al tema dell'infelicità umana. Qui su l'arida schiena Del formidabil monte -> Osserva la ginestra che si trova lungo le pareti del spaventoso Vesuvio (definito anche sterminatore) Sterminator Vesevo, -> "Formidabil" e "contenta" sono latinismi La qual null'altro allegra arbor ne fiore, -> "Questa parete che non è rallegrata da alberi o da fiori Tuoi cespi solitari intorno spargi, tranne che dalla ginestra" (crea una specie di cespuglio). Odorata ginestra, Contenta dei deserti. Anco ti vidi De' tuoi steli abbellir l'erme contrade Che cingon la cittade - Vesuvio = personificazione della natura distruttiva -> "Ti ho visto abbellire con i tuoi steli che circondano la città che un tempo fu dominatrice (donna) degli uomini" -> Perifrasi per descrivere Roma. La qual fu donna de' mortali un tempo, -> L'ha già vista nelle campagne di Roma E del perduto impero Par che col grave e taciturno aspetto Faccian fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol, di tristi Lochi e dal mondo abbandonati amante, E d'afflitte fortune ognor compagna. -> Ora (torna al presente) ti rivedo in questo luogo abbandonato da tutti. Ancora compagna della triste sorte degli uomini -> Nonostante l'uomo abbia creato un grande impero, sono rimaste rovine: distruzione e desolazione. Sia la natura che le capacità dell'uomo non hanno quel valore che un tempo si pensava
- Seconda strofa = è tutta filosofica: critica gli intellettuali ottocenteschi che credevano nel progresso e quindi nel miglioramento della vita.
- Terza strofa = l'uomo deve essere consapevole della sua infelicità. C'è una via d'uscita: se noi siamo consapevoli, siamo solidali gli uni con gli altri. Utilizza qui delle similitudini: un esercito circondato da nemici, si aiuta.
- Quarta strofa = l'uomo non è al centro dell'universo -> critica la religione cristiana (è fittizia e consolatoria)
- Quinta strofa = utilizza un nuovo paragone: un frutto cade da un albero su un formicaio (natura indifferente).
- Sesta strofa = questa indifferenza della natura è eterna: l'uomo è sempre stato infelice, è infelice e sarà infelice. E tu, lenta ginestra, Che di selve odorate Queste campagne dispogliate adorni, Anche tu presto alla crudel possanza Soccomberai del sotterraneo foco, Che ritornando al loco Già noto, stenderà l'avaro lembo Su tue molli foreste. E piegherai Sotto il fascio mortal non renitente Il tuo capo innocente: Ma non piegato insino allora indarno Codardamente supplicando innanzi Al futuro oppressor; ma non eretto Con forsennato orgoglio inver le stelle, Né sul deserto, dove E la sede e i natali Non per voler ma per fortuna avesti; Ma più saggia, ma tanto - Andamento circolare: torna la ginestra. "E tu riposata ginestra che colori queste campagne desolate di cespugli profumati anche tu verrai distrutta dall'eruzione che ritornerà" -> Tu sarai distrutta ma non ti sarai mai piegata chiedendo pietà a questa natura distruttiva (religione) -> Non avrai nemmeno pensato di gestire la natura (ragione = critica agli intellettuali ottocenteschi) -> Ma tu sei stata saggia perché hai accettato questa