La svolta pragmatica di Grice e le teorie Neo-Griceane e Post-Griceane
Documento sulla svolta pragmatica di Grice, le teorie Neo-Griceane e Post-Griceane. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Psicologia, esplora la teoria della mente, il suo sviluppo nei bambini e le implicazioni nell'autismo, analizzando la comprensione di metafore e ironia.
Mostra di più45 pagine

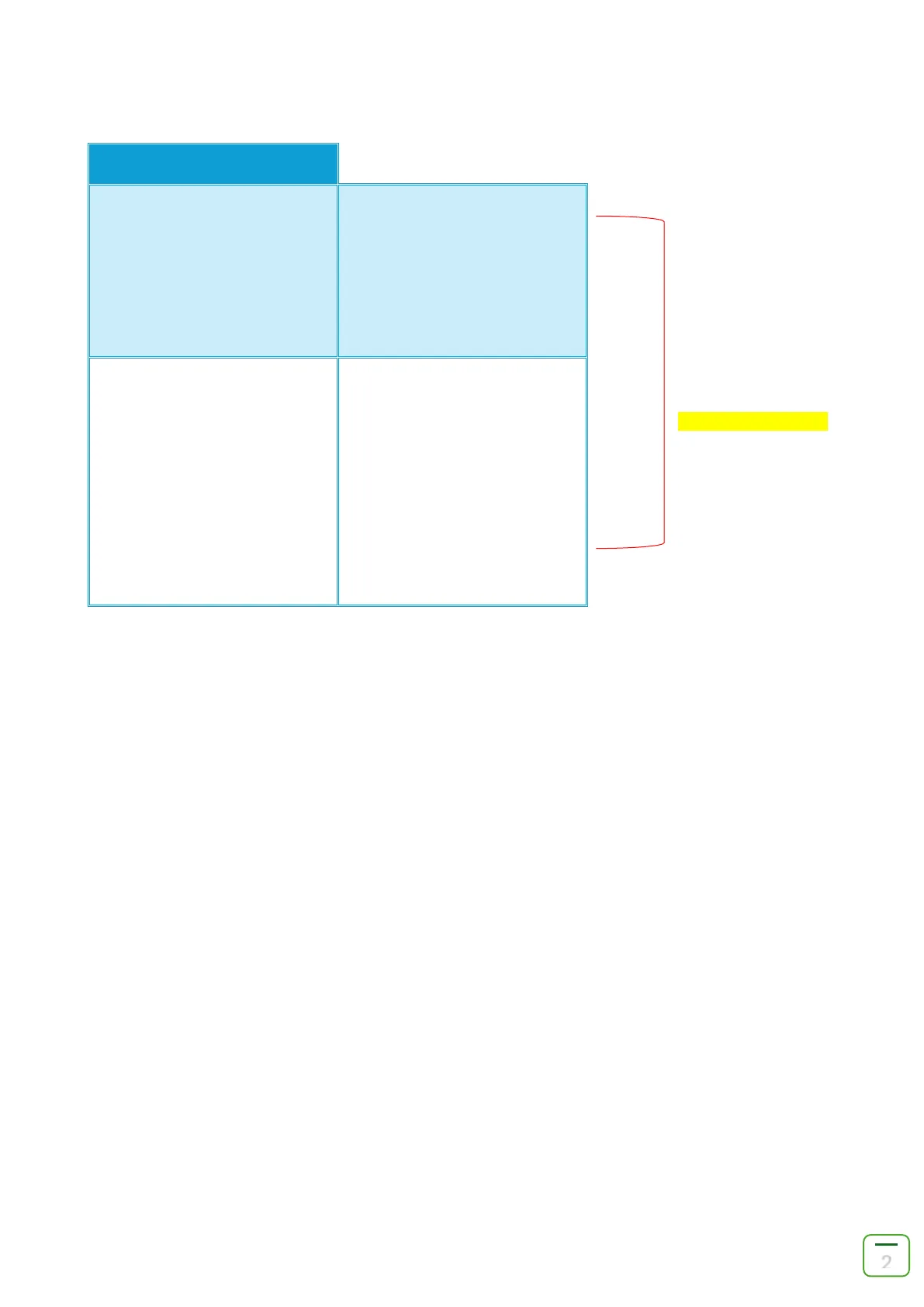
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Svolta Pragmatica di Grice
19/11/2023 (VII lezione) SVOLTA PRAGAMATICA DI GRICE La svolta pragmatica di Grice ci offre una visione diversa della comunicazione, che non riguarda solo ciò che viene detto esplicitamente ma si concentra per il 90% su ciò che non viene detto, cioè sulla parte implicita. La comunicazione, secondo Grice, consiste nel riconoscimento delle intenzioni dell'altro, che spesso non vengono espresse direttamente ma implicano un significato nascosto. Grice sostiene che, durante una conversazione, esiste un comportamento cooperativo tra i partecipanti. Inoltre, se pensiamo che l'altro parlante stia violando questo comportamento cooperativo, significa che ha delle ragioni specifiche per comunicare un significato diverso da quello apparente. La comunicazione non si interrompe ma ci sono molte informazion i nascoste che dobbiamo comprendere e che il parlante sta cercando di trasmetterci. È molto importante distinguere tra ciò che viene detto e ciò che viene implicato dall'uso di certe parole in un determinato contesto, quando si esprime un preciso enunciato.
Correnti di Pensiero Post-Grice
Dopo Grice, sono emerse due nuove correnti di pensiero:
- Il progetto Neo-Griceano, che sviluppa ulteriormente le idee di Grice, modificandole e concentrandosi sulle massime conversazionali o sul tipo di implicazione.
- Il progetto Post-Griceano, che critica Grice e la sua teoria, cercando di andare oltre e proponendo delle alternative alle sue idee.
Ciò che viene criticato di Grice è l'idea che esista un significato esplicito, da cui, attraverso un processo inferenziale, si arriva a comprendere il significato implicito inteso dal parlante. In altre parole, secondo Grice, si parte dal significato detto e si cerca di capire ciò che il parlante vuole veramente comunicare. Alcuni iniziano a mettere in discussione il modello del codice e si chiedono se Grice sia stato un difensore o un critico di questo modello. Robyn Carston sostiene che Grice era un teorico del codice. Infatti, Grice ha difeso il modello del codice e ha sempre affermato che serve un altro modello per spiegare il significato implicito, ma non ha mai abbandonato il modello del codice. Grice mantiene entrambi i modelli: il modello del codice è utile per capire il significato letterale e non possiamo eliminarlo perché è il punto di partenza per usare l'altro modello, quello inferenziale. Con il modello inferenziale, riusciamo a risalire al significato inteso dal parlante. Per Grice, ciò che viene detto è in qualche modo determinato dal significato convenzionale dell'enunciato e non si può fare a meno di questo, perché i processi inferenziali intervengono solo in alcuni aspetti della comunicazione. ESEMPIO -> Se ho una credenza in Dio, si capisce che la credenza non è un mobile. Per Grice, ci sono tre livelli di significato. Il livello linguisticamente modificato, ovvero il livello letterale, e poi ci sono degli aspetti del contesto che intervengono a determinare un altro livello, quello che ciò che è detto. Quello che è detto comprende due aspetti: determinare il riferimento ed eliminare le ambiguità. Per operare in questo livello devo fare dei processi di saturazione, cioè di determinazione del riferimento e di disambiguazione. I due processi danno forma al livello del ciò che è detto. Ciò che è implicato rimane nell'implicito. Quando Grice si riferisce a ciò che è comunicato, si riferisce a tutti i processi contestuali.
I Tre Livelli di Significato
1I tre livelli di significato sono:
- Ciò che è linguisticamente codificato.
- Ciò che è detto Si divide in: - Esplicito: ciò che viene detto chiaramente o dire ttamente. - Esplicatura: l'espansione o chiarificazione di quanto detto, che rende più comprensibile il significato esplicito.
- Ciò che è implicato Si divide in: - - Implicito: ciò che non viene detto direttamente ma è comunque suggerito o sottinteso. Implicatura: il processo attraverso cui si comprende il significato implicito, ossia ciò che il parlante intende comunicare, oltre a quanto è stato detto esplicitamente.
- Ciò che è comunicato.
Esiste una corrente Neo-Griceana che oggi chiamiamo letteralismo, che continua a difendere il modello del codice. Secondo questa corrente, esiste un significato letterale, ossia un significato convenzionale delle parole, che si trova nel vocabolario e si costruisce attraverso il principio di composizionalità. Dall'altra parte, il contestualismo è la corrente Post-Griceana che rifiuta il modello del codice. I contestualisti sostengono che non esiste un significato letterale fisso, poiché anche ciò che viene detto dipende dai meccanismi contestuali necessari per comprendere il linguaggio codificato linguisticamente. In questo caso, la pragmatica si intreccia con la semantica. L'unico punto su cui letteralismo e contestualismo non si scontrano sono le implicature conversazionali. Entrambe le correnti si incontrano nel punto in cui si distingue tra ciò che viene detto e ciò che non viene detto. Grice aveva l'intenzione di scardinare il modello del codice, ma allo stesso tempo ha fornito le basi per difenderlo. La posizione di Grice è compatibile con quella dei letteralisti.
Teoria della Pertinenza
2TEORIA DELLA PERTINENZA RTL J np dicti Bordas K TRAV LOSTLAWYER LE PARADOXE DU MUSICIEN Dan Sperber Deidre Wilson Sperber e Wilson hanno proposto la teoria della pertinenza, che spiega non solo gli aspetti cognitivi ma anche quelli del linguaggio, basandosi su un principio di pertinenza. Secondo loro, non possiamo pensare che la nostra mente decodifichi tutto in modo preciso e lento, poiché lavora rapidamente. Entrambi suggeriscono di mettere alla prova la teoria di Grice. Tuttavia, Grice non era un linguista, ma un filosofo e quindi si concentrava più sugli aspetti normativi che su quelli psicologici dell'implicatura. Grice aveva un concezione argomentativa della razionalità, chiedendosi quale fosse lo scopo del nostro comportamento linguistico. Invece, i teorici della pertinenza adottano una visione strumentale, cercando di capire come il nostro cervello elabora gli enunciati. Il principio di pertinenza richiama la massima di relazione di Grice, che afferma "sii pertinente". Grice stesso suggeriva che questa massima meritava un approfondimento. I teorici della pertinenza riprendono l'intuizione di Grice e sostengono che non siano necessarie tutte le massime e l'intero apparato della filosofia classica. Propongono invece un unico grande principio, chiamato principio di pertinenza. Per spiegare il concetto di pertinenza, mettono in equilibrio due concetti: l'effetto cognitivo e lo sforzo di elaborazione. Sono queste due nozioni che definiscono il principio di pertinenza. In ogni contesto, i mezzi utilizzati dipendono dal fine e dall'effetto che si vuole raggiungere. Ci sono azioni che richiedono un certo sforzo, ma questo sforzo è bilanciato dagli effetti che si ottengono. Quindi, affinché ciò che diciamo sia pertinente, queste due nozioni devono essere in equilibrio tra loro rispetto al contesto. Quando si calcolano gli effetti cognitivi, si cerca di minimizzare lo sforzo. Si controllano le conclusioni, ovvero l'ipotesi interpretativa migliore. Si può andare avanti con le interpretazioni, però fino ad un certo punto.
Aspetti del Principio di Pertinenza
Il principio di pertinenza ha due aspetti:
- Un cognitivo che riguarda la mente, dove i processi cognitivi tengono a massimizzare la pertinenza.
- Il principio comunicativo che è linguistico e dice che ogni proferimento comunica la presunzione della propria pertinenza ottimale.
3Non è facile misurare la pertinenza e sembra improbabile che ci sia un solo modo per ottenerla. Alcuni ritengono che ci siano molti modi per raggiungere la pertinenza. La teoria della pertinenza si concentra principalmente sugli effetti informativi e cognitivi, senza considerare gli aspetti sociali o le norme di cortesia. Una novità importante della teoria della pertinenza è che, mentre per Grice la cooperazione comunicativa riguardava principalmente le implicature conversazionali, con significato implicito che emergeva quando le massime venivano violate, per Sperber e Wilson questo principio si applica anche al significato esplicito. Per loro, la pertinenza è un aspetto fondamentale sia per il significato esplicito che per quello implicito. Le esplicature sono situazioni in cui la pragmatica interviene anche in senso letterale. In questi casi, il significato letterale viene modificato in base al contesto. A differenza delle implicature e delle presupposizioni, le esplicature non introducono informazioni completamente nuove. La verità delle esplicature può variare a seconda del contesto. Esistono due tipologie di esplicature:
- Omonimia Quando un termine ha due o più significati letterali diversi. Ad esempio, "riccio" che può essere riferito all'animale o ai capelli.
- Polisemia Quando un termine ha due o più significati letterali correlati, i cui sensi si sovrappongono parzialmente. Ad esempio, il "piumino" che può essere riferito sia alla coperta che al giubbotto, entrambi usati per riscaldarsi.
Nel caso dell'omonimia, la selezione del significato avviene automaticamente in base al contesto, e spesso bastano poche parole per individuare il significato corretto. Nel caso della polisemia, la situazione è più complessa, poiché i significati possono sovrapporsi e richiedere un contesto più ampio per essere chiariti. Questo processo è chiamato modulazione, perché bisogna identificare le proprietà uniche che distinguono i diversi significati. Altri casi di modulazione richiedono un completamento, poiché nella polisemia non esiste una lista chiara di significati. Spesso, i significati sono numerosi e dipendono dal contesto in cui vengono utilizzati. La modulazione può avvenire in due modi principali:
- o Restringimento del senso: Ad esempio, "Non bevo quando guido" > "Non bevo alcolici quando guido."
- o Ampliamento del senso: Ad esempio, "Quel ragazzo è matto" > "Quel ragazzo è stravagante, esuberante".
Le Metafore e Figure Retoriche
4LE METAFORE Lo stesso discorso viene fatto anche per le metafore. Una metafora come "un caffè è un balsamo", ci fornisce un concetto più specifico. Non prendiamo solo il concetto di balsamo, ma quella proprietà del balsamo che ci servono peer spiegare che cos'è il caffè. Da sollievo, ristoro e questa è la proprietà implicita che viene selezionata e attribuita al concetto di caffè. La metafora è una figura retorica in cui si parte dal dominio per spiegare un altro dominio, quello di arrivo, ovvero dominio target. Di solito è astratto ma può anche essere concreto. Ci sono tante altre figure retoriche che necessitano di processi di modulazione:
- Metonimia Figura retorica che consiste nell'usare il nome della causa per quello dell'effetto, del contenente per il contenuto, della materia per l'oggetto, del simbolo per la cosa designata, del luogo di produzione o di origine per la cosa prodotta e dell'astratto per il concreto. Ascoltavo spesso le Fifth Harmony.
- Sineddoche Figura retorica per la quale si usa figuratamente una parola di significato più ampio o meno ampio di quella propria. Il panino al prosciutto ha pagato.
- Iperbole Riferimento metaforico volutamente alterato sul piano della quantità sia per eccesso e sia per difetto. Non ti vedo da un secolo.
- Litote Formulazione attenuata, ottenuta attraverso la negazione del contrario: risultano non cattivo (buono), notizie non buone (cattive) e danno non indifferente (piuttosto grave). Diciamo che non è molto intelligente.
Le metafore morte sono così integrate nel linguaggio comune che vengono usate come se fossero espressioni letterali. Esempi sono "collo di bottiglia" o "mamma chioccia". Queste metafore sono diverse dalle metafore vive, che sono nuove e creative e non sono ancora consolidate nel vocabolario. Le metafore vive sono spesso utilizzate in contesti poetici e sono specifiche per un momento o un contesto particolare. Poiché non sono ancora parte del linguaggio consolidato, richiedono uno sforzo maggiore di elaborazione per essere comprese. I filosofi linguistici George Lakoff e Mark Johnson sostengono che la metafora non riguarda solo il linguaggio, ma è profondamente radicata nel pensiero. Ad esempio, espressioni come "La nostra relazione è arrivata a un bivio" o "La strada che abbiamo intrapreso mano nella mano" indicano che l'amore può essere visto come un viaggio. Quando parliamo, usiamo metafore ricorrenti che rimandano a metafore più profonde, chiamate metafore concettuali. Queste metafore sono culturali, poiché riflettono modi di pensare e parlare radicati nella nostra comunità. A volte, possono avere effetti negativi, come promuovere comportamenti competitivi. Av Mark Johnson George Lakoff