Meccanismi molecolari delle malattie metaboliche, Università
Documento da Università su Meccanismi Molecolari delle Malattie Metaboliche. Il Pdf esplora i disordini del metabolismo di amminoacidi, carboidrati, acidi grassi e il ruolo mitocondriale, utile per lo studio della Biologia a livello universitario.
Mostra di più60 pagine
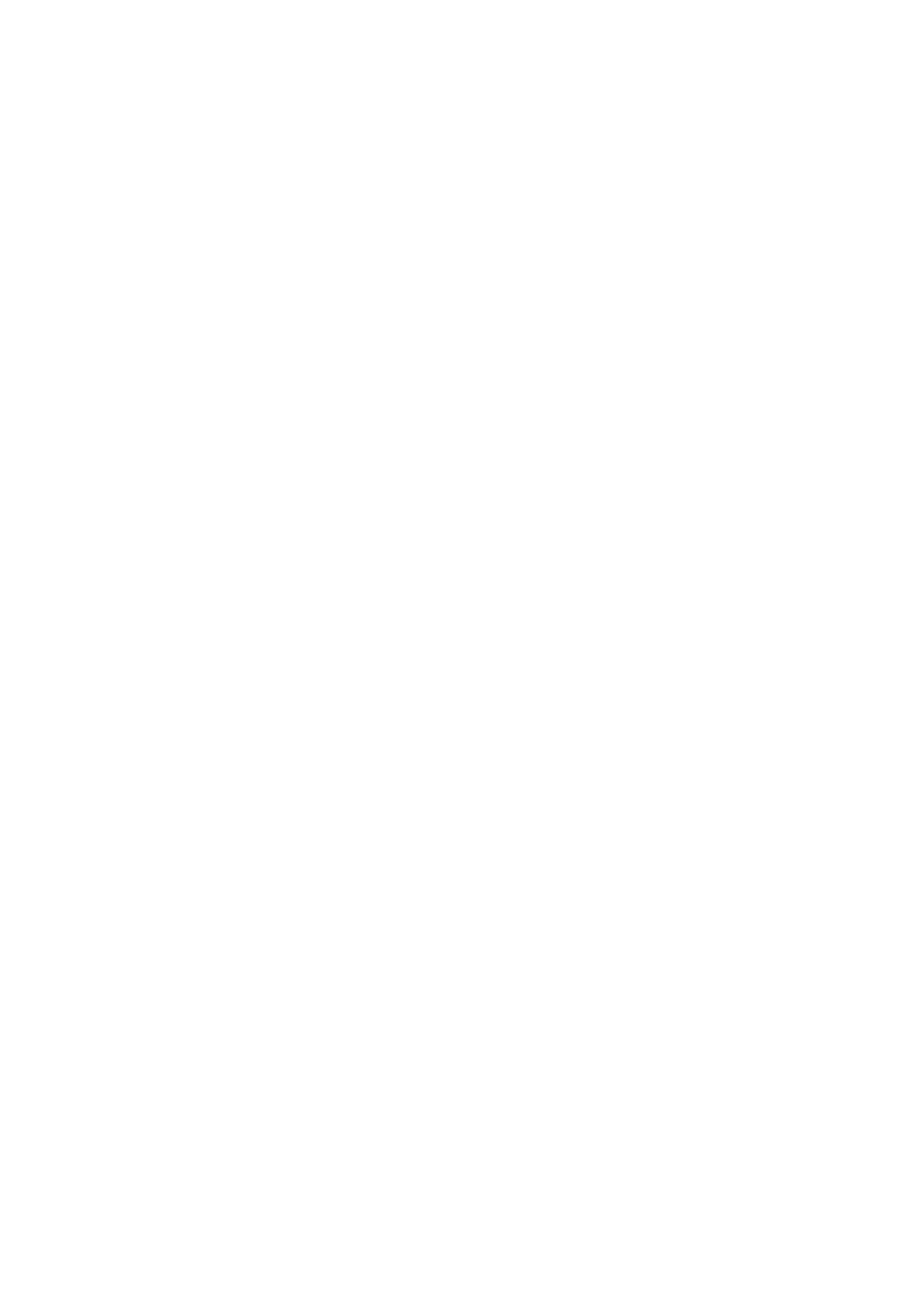

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Concetto di Malattia
Definizione di Salute e Malattia OMS: Stato di completo benessere fisico, psichico e sociale (prima si diceva che la salute fosse l'assenza di malattia, mentre oggi si dà il giusto peso anche all'aspetto psicologico e sociale, nonché l'ambiente in cui l'individuo vive). Esiste una "soglia" di integrità fisica, psichica e di adattamento sociale ed ambientale, variabile da individuo a individuo, superata la quale l'individuo cessa di essere sano e subentra la malattia come la rottura dell'equilibrio fisiologico. Non tutti gli individui hanno la stessa soglia di salute, è fondamentale considerare l'importanza delle differenze individuali, messe in luce anche dai più recenti studi di polimorfismo del genoma umano. La International Classification Diseases (ICD), promossa ed aggiornata dall'OMS, comprende circa 15.000 entità nosologiche o "categorie diagnosticate" distinte, che raggruppano individui con indicatori diagnostici e manifestazioni cliniche simili, per i quali si prevede uno schema terapeutico. Questa modalità di diagnosi e terapia, però, non tiene conto delle caratteristiche individuali di ciascun paziente, solitamente si basa su manifestazioni tardive che non consentono di identificarla precocemente e non considera le basi molecolari responsabili dalla patologia che potrebbero essere diversi, anche portando ad un fenotipo clinico simile. In questo senso, le nuove classificazioni delle malattie devono tenere conto della variabilità individuale e dei fattori ambientali. Per questo, bisogna raccogliere, per ogni individuo sin dalla nascita, i dati anamnestici e clinici (inclusi quelli sugli stili di vita e le condizioni ambientali) in formato elettronico (Electronic Health Records EHR o cartella clinica elettronica), creando grandi banche dati globali, consultabili dagli scienziati biomedici e dagli epidemiologi che conducono sperimentazioni e analisi cliniche su vasta scala. Vista la complessità di elaborazione di questa enorme quantità di dati, queste banche dati richiederanno enormi capacità computazionali e di archiviazione, ed interviene l'intelligenza artificiale.
L'IA è una branca delle scienze informatiche che dai dati EHR, genomici e wearable (derivanti da dispositivi indossabili), sviluppa algoritmi che sarebbero difficili per la mente umana. Un sottosettore dell'IA è la machine learning, che sviluppa algoritmi e modelli che permettono ai computer di apprendere dai dati e migliorare le loro prestazioni nel tempo senza essere esplicitamente programmati per ogni singola attività. In pratica, noi introduciamo delle informazioni, dei dati (gli input) e la macchina li analizza, identifica schemi e fa previsioni o prende decisioni, basate su queste informazioni, genera esiti, per esempio una diagnosi (output). La deep learning è una forma particolare di machine learning che usa algoritmi complessi che simulano una rete neuronale chiamati convolutional neural networks (CNN), e può essere: supervised learning (che ha supervisione da parte di un operatore. Lo stesso risultato lo potrebbe ottenere anche l'uomo, ma impiegando più tempo); o unsupervised learning (ancora in fase sperimentale). L'IA, però, non riesce facilmente a stabilire nessi di casualità che meglio consentono l'identificazione di una opportuna terapia, e nasce la necessità di semplificare l'oggetto in studio (approccio riduzionistico) e ricorrere alla costruzione di modelli di studio.
Modello sperimentale ideale
Il modello sperimentale/di studio ideale dovrebbe possedere caratteristiche di:
- Rappresentatività, il modello deve essere quanto più possibile vicino all'uomo;
- Riducibilità, deve esserci un livello alto di semplificazione che permetta di isolare e studiare le variabili;
- Sostenibilità, sia etica che economica;
- Predittività, i risultati ottenuti devono essere riproducibile e possibilmente capaci di fornire una terapia.
In realtà il modello ideale non esiste e solitamente si sono stabiliti modelli animali che negli ultimi tempi si stanno integrando con nuovi sistemi che talvolta li stanno sostituendo.
Sperimentazione animale
Per poter trovare la terapia di una malattia occorre trovare la sua eziologia ossia le cause genetiche, infettive, ambientali che dovrebbero condurre all'identificazioni dei meccanismi responsabili. Il farmaco non può essere sperimentato direttamente sull'uomo e per questo occorrono sistemi sperimentali per l'analisi delle condizioni patologiche. Il primo sostenitore dei modelli animali risale agli inizi dell'800 con ClaudeBernard, secondo il quale qualsiasi animale andava bene e per qualsiasi sperimentazione. Oggi sappiamo che sono pochi gli animali che si addicono alla sperimentazione, cioè che rispettano i suddetti criteri. Nella maggior parte dei paesi è proibita la sperimentazione su primati superiori (scimpanzè, orango, etc), anche se sono i più simili all'uomo, ed è ristrettissima quella su mammiferi non roditori (cani e gatti). In pratica l'80% della sperimentazione animale attuale avviene sui roditori e il 20% quasi esclusivamente su pesci e in maniera minore su uccelli. In tutti i casi bisogna attenersi a rispettare i principi delle 3R:
- Replacement, occorre adoperarsi quanto prima per trovare sostituzione a questi modelli;
- Reduction, usare il minimo degli animali possibili e condurre esperimenti che siano robusti e riproducibili e che portino a un autentico e significativo avanzamento delle conoscenze;
- Refinement, minimizzare sofferenza e danno degli animali in laboratorio e migliorare le condizioni di vita di questi animali e tutte le procedure non direttamente connesse con l'esperimento che aumentino il benessere dell'animale;
A queste 3 R si aggiunge una quarta R che riguarda la Responsibility dello scienziato nella gestione della ricerca.
Obiettivi dei modelli animali
Esistono due tipi di modelli animali volti a raggiungere due principali obiettivi:
- Riprodurre i modelli di malattia, al fine di comprendere eziologia e patogenesi;
- Eseguire studi preclinici di farmacologia, includenti la farmacocinetica (cioè, lo studio del metabolismo del farmaco) e la farmacodinamica (ciò che il farmaco fa all'organismo).
Per ottenere le condizioni di patologia nel modello, esistono animali knockout, a cui è rimosso un gene, e animali knockin, a cui è aggiunto o attivato un gene, o ancora knockdown, in cui l'espressione di un gene è ridotta. Quando parliamo di modelli di malattia ci riferiamo a sistemi di vertebrati con l'esclusione di sistemi modello come il nematode, la Drosophila o il lievito che, pur avendo enormi utilità nella comprensione di alcuni meccanismi molecolari, non sono sufficientemente rappresentativi dell'uomo. Il modello più largamente utilizzato è il topo, per alcuni vantaggi sperimentali:
- Piccole dimensioni, e quindi facilità di stabulazione;
- Alto numero di progenie, e quindi disponibilità di molti animali per gli esperimenti;
- Gravidanza breve e raggiungimento della maturità in mesi, e quindi la possibilità di effettuare molti esperimenti in tempi brevi;
- Composizione genica, il topo è largamente isogenico all'uomo e possiede essenzialmente lo stesso numero di geni, circa 20.000, con una similitudine dell'85% di questi geni.
Limiti nell'utilizzo del topo
I limiti nell'utilizzo del topo sono:
- A livello genomico, nelle regioni codificanti per proteine esiste una identità dell'85% che però può variare dal 60 al 90% in base ai geni. Questo rappresenta un problema se singole variazioni di sequenza nucleotidica possono avere effetti rilevanti sulla fisiologia e sulla possibilità di sviluppare la malattia. Inoltre, nelle sequenze non codificanti, l'identità scende a circa il 50%.
- L'inbreeding, cioè l'uso di ceppi di topo geneticamente identici che servono a ridurre le interferenze dovute alla variabilità individuale e garantire grande riproducibilità, ma che non è la situazione dell'uomo dove invece esiste una notevole variabilità individuale. Al più questo modello potrebbe servire per comprendere i meccanismi molecolari delle malattie monogeniche ma non quelli delle poligeniche. Per superare questo limite si utilizzano topi che si sono incrociati per almeno 20 generazioni, perché presentano variabilità genetica data dal crossing over e dalle trasposizioni orizzontali (trasposoni ed elementi trasponibili, cioè segmenti del DNA che possono restare nella loro sede, ma che vengono e copiati e la copia trasportata in un'altra sede, oppure che vengono tagliati e spostati. Alcuni sono fossili, cioè che in passato si spostavano, e altri ancora attivi. In ogni caso sono eventi abbastanza rari, che portano a modificazioni del DNA che portano quasi sempre a malattia e solo raramente all'acquisizione di nuove caratteristiche);
- Condizioni di stabulazione, che minimizzano la componente ambientale (rendendola omogenea) al fine di evidenziare la componente genetica. Questo può alterare lo sviluppo di particolari malattienei modelli e modificare la risposta ad alcuni farmaci, che nell'uomo sarebbero influenzati dalle variazioni ambientali.
Differenze tra uomo e topo
Le differenze tra uomo e topo possono causare gravi errori nella valutazione degli effetti dei farmaci. Esempio della fialuridina (FIAU): un analogo dei nucleosidi, che negli animali aveva mostrato buona efficacia come farmaco antivirale soprattutto contro il virus dell'epatite B, e con scarsissima tossicità nel topo. Il primo trial clinico con FIAU, nel 1993, produsse effetti disastrosi: 7 di 15 pazienti arruolati svilupparono insufficienza epatica e 5 morirono. Gli studi seguenti mostrano che un trasportatore di membrana, SLC29A1 era il responsabile della tragedia. Questa proteina nell'uomo è localizzata sulla membrana mitocondriale e trasporta all'interno dei mitocondri i nucleosidi, incluso FIAU. Nel mitocondrio FIAU impedisce la duplicazione del DNA mitocondriale provocando il fallimento della produzione di energia. Nel topo questo non avviene perché SLC29A1 non si localizza sulla membrana mitocondriale.
Nuovi modelli animal-free
I limiti e i problemi etici ci portano a pensare a nuovi modelli animali più rappresentativi del sistema Homo sapiens o a mettere a punto sistemi animal-free che possano essere utilizzati in alternativa o in associazione ai modelli animali, come le iPS o iPSC (Induced Pluripotent Stem Cell), gli organoidi, la stampa 3d e gli omics.
Cellule iPS
Le cellule iPS. Yamanaka, nel 2006, ha capito che partendo da cellule somatiche, differenziate, frequentemente fibroblasti, in coltura, e forzando l'espressione di specifici geni (definiti appunto di Yamanaka) si potevano riottenere cellule in uno stadio non differenziato staminali. Queste cellule pluripotenti hanno la capacità di differenziarsi in una vasta gamma di tipi cellulari, e quindi organi e tessuti, sotto stimolazione di induttori chimici, proprio come le cellule staminali embrionali, ma senza l'utilizzo di embrioni, evitando quindi le problematiche etiche legate all'uso di embrioni umani. Le iPS possono essere usate poi per studi in vitro, per creare modelli cellulari specifici per malattie genetiche o complesse, permettendo di studiarne i meccanismi e testare nuovi farmaci, per la costruzione di organoidi e, potenzialmente, per la re-introduzione nel paziente a scopo di terapia con cellule staminali. È un modello che, partendo da una cellula direttamente dal paziente, è molto sovrapponibile al paziente stesso.
Organoidi
L'organoide è il modello che riproduce un'architettura quasi normale e fedele di un organo, partendo proprio dalle cellule iPS, messe nelle condizioni di dare origine alla struttura. Un esempio di organoide semplice da ottenere e che rispecchi fedelmente le caratteristiche morfo-funzionali dell'organo originale è la ghiandola mammaria. Su questi organoidi sono possibili studi di meccanismo di malattia, di tossicologia e farmacologia, ecc. La singola cellula presenta il limite di non avere interazioni con altre cellule, cosa che invece è importante comprendere in uno studio. L'organoide supera questo limite, per uno studio d'insieme.
Stampa 3D
La stampa 3D è una tecnologia che ha rivoluzionato molti settori, tra cui l'essere utilizzata come alternativa ai modelli animali. Grazie alla capacità di creare strutture tridimensionali complesse a partire da materiali biologici o sintetici, la stampa 3D può simulare in modo molto accurato organi, tessuti e altre strutture biologiche, riducendo la necessità di test sugli animali.
Bioprinting
La stampa 3D biocompatibile utilizza tecniche come la bioprinting, che consiste nell'uso di materiali biologici (come cellule, biomateriali e idrogel) per costruire strutture simili ai tessuti umani.
Fasi del processo di stampa 3D
Le fasi principali di questo processo includono:
- Creazione del modello digitale: Si crea un modello tridimensionale del tessuto o dell'organo che si vuole replicare, utilizzando scansioni o immagini medicali (come le risonanze magnetiche o le tomografie computerizzate).
- Preparazione del materiale: Si preparano "inchiostri biologici", composti da cellule viventi (come cellule staminali, cellule epiteliali, muscolari o nervose) e biomateriali che sostengono la crescita cellulare.
- Stampa: Il modello digitale viene stampato strato dopo strato, con precisione microscopica, per creare una struttura tridimensionale che replica il tessuto o l'organo desiderato.