Farmaci agonisti e simpaticomimetici: meccanismi d'azione ed effetti
Documento universitario sui farmaci agonisti (o simpatico-mimetici). Il Pdf esplora i farmaci agonisti e antagonisti del sistema nervoso simpatico, descrivendo adrenalina, amfetamina, tiramina ed efedrina, con i loro meccanismi d'azione e farmacocinetica.
Mostra di più16 pagine
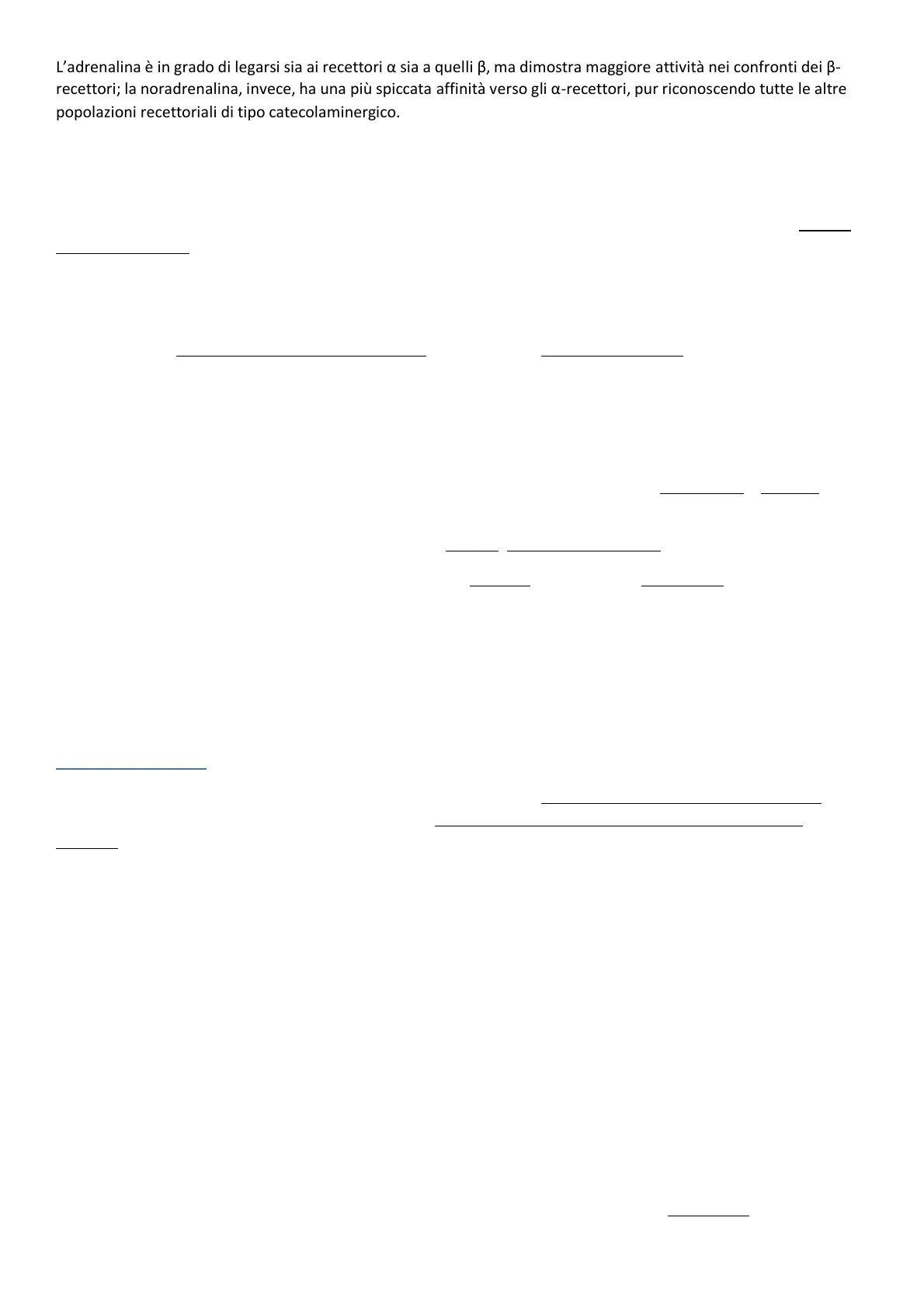
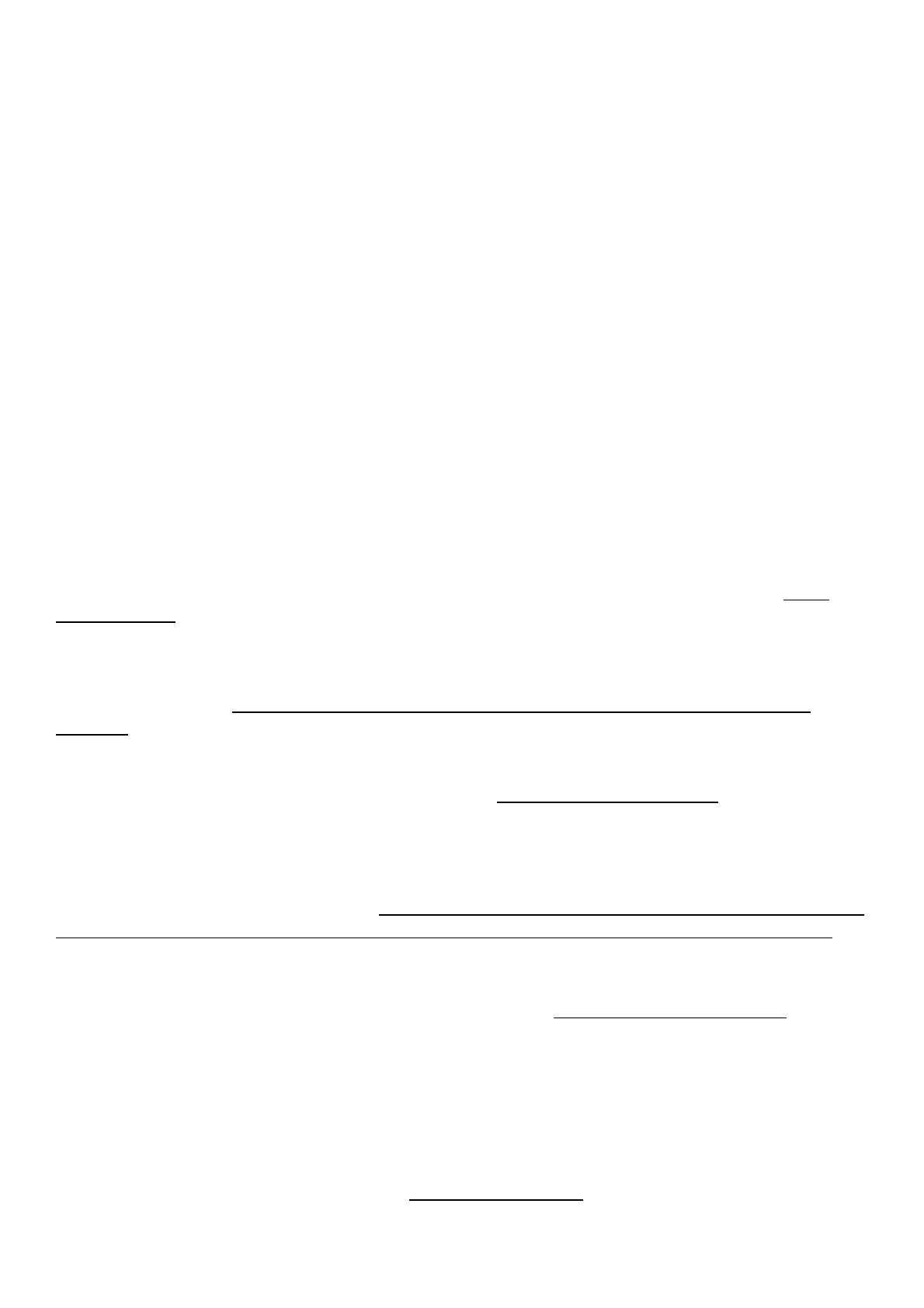
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Farmaci Agonisti (Simpatico-Mimetici)
I farmaci che mimano le azioni della adrenalina o della noradrenalina a livello periferico sono definiti come farmaci simpatico-mimetici; in particolare i simpatico-mimetici possono essere raggruppati in base al meccanismo d'azione e in base ai recettori che sono in grado di attivare in: simpatico-mimetici diretti, simpatico-mimetici indiretti e simpatico-mimetici ad azione mista.
- Agonisti diretti > legano e attivano direttamente gli adrenorecettori, possono legarsi specificatamente agli alfa o ai beta recettori (farmaci alfa-selettivi e beta-selettivi) o a tutti e due (farmaci non selettivi). Gli effetti dei simpaticomimetici diretti dipendono dalla via di somministrazione, dalla loro relativa affinità a livello dei vari recettori adrenergici e dalla loro relativa espressione a livello dei tessuti target
- Agonisti indiretti (i loro effetti sono più marcati in condizioni di attività simpatica aumentata) > aumentano il tono catecolaminergico attraverso diverse azioni: a) induzione del rilascio delle catecolammine per spiazzamento dai terminali nervosi (amfetamina o tiramina) b) diminuzione della clearance delle catecolammine per inibizione del re-uptake neuronale, cioè aumentando la disponibilità del neurotrasmettitore in via indiretta (cocaina, antidepressivi triciclici) c) inibizione del catabolismo: farmaci inibitori delle MAO (pargilina) e delle COMT (entacapone)
- Agonisti adrenergici ad azione mista (con azione diretta ed indiretta)
Catecolamine Endogene
Adrenalina (Epinefrina)
Meccanismo d'azione dell'adrenalina
È un potente stimolante sia degli a sia dei ß recettori rappresentando uno dei più potenti farmaci vasopressori con azione incisiva su cuore e muscolatura liscia vasale. > maggiore attività cardiaca e aumento della pressione arteriosa. Tuttavia bisogna specificare come basse dosi di adrenalina possono causare caduta dei valori pressori: ciò è dovuto ad una maggiore sensibilità dell'adrenalina per i recettori 2 (che mediano vasodilatazione soprattutto a livello della muscolatura scheletrica) rispetto ai recettori a (che mediano vasocostrizione). Quindi quando viene somministrata adrenalina c'è una differenza a seconda che vengano utilizzate dosi terapeutiche o dosi basse:
- a basse dosi prevalgono gli effetti beta sul sistema vascolare, quindi vasodilatazione; in particolare si ottiene un effetto paradosso, cioè anziché vedere un aumento della pressione arteriosa si osserva un effetto di tipo ipotensivo
- a dosi elevate sono più marcati gli effetti alfa, quindi vasocostrizione
Questa è una delle differenze principali che distingue l'adrenalina dalla noradrenalina, in quanto:
- l'adrenalina ha duplice effetto di vasocostrizione (a dosi terapeutiche) e vasodilatazione (a basse dosi)
- la noradrenalina ha effetti sovrapponibili all'epinefrina ma, avendo più affinità per gli a recettori e non per i B, è sempre un vasocostrittore
L'adrenalina è un potente stimolante cardiaco; presenta azione diretta sul miocardio con conseguente incremento della forza di contrazione ventricolare (azione inotropa positiva), della frequenza cardiaca (azione cronotropa positiva) e della gittata cardiaca > questa azione si deve al legame dell'adrenalina con i recettori 31 presenti a livello del miocardio, delle cellule pacemaker e del tessuto di conduzione. In particolare, l'adrenalina comportaun'accelerazione della depolarizzazione lenta delle cellule del nodo SA, che si svolge durante la diastole (quindi va ad accorciare la fase 4 del potenziale d'azione); in questo modo il potenziale transmembrana delle cellule pacemaker sale più rapidamente e raggiunge più velocemente la soglia per innescare il potenziale d'azione successivo. Lo stesso meccanismo viene svolto a livello delle fibre di Purkinje (nelle quali accelera la depolarizzazione diastolica); sempre l'adrenalina può attivare cellule pacemaker latenti.
L'adrenalina non svolge soltanto un'azione a livello cardiaco, ma svolge anche un'azione a livello della muscolatura liscia vasale > infatti i meccanismi alla base dell'aumento della pressione arteriosa dovuto all'adrenalina comprendono gli effetti a livello cardiaco (azioni inotropa e cronotropa positiva) e la vasocostrizione di molti distretti vascolari (es. cute, mucose, rene), in aggiunta a marcata costrizione venosa. Si deve specificare che:
- a livello renale l'azione vasocostrittrice dell'adrenalina mediata sui diversi organi periferici porta all'aumento delle resistenze vascolari con riduzione del flusso ematico renale
- a livello dell'apparato iuxtaglomerulare l'adrenalina lega i recettori ß1 presenti a livello della macula densa, stimolando la sintesi di renina (e quindi di angiotensina 2) che va ad aumentare ulteriormente l'azione vasocostrittrice dell'adrenalina > i ß1 recettori presenti a livello dell'apparato iuxtaglomerulare sono bersaglio dei beta-bloccanti: bloccando questi recettori, non si ha produzione di renina e di conseguenza si ha vasodilatazione e caduta della pressione arteriosa (effetto antipertensivo ei beta-bloccanti)
- a livello cardiaco l'adrenalina non causa vasocostrizione ma vasodilatazione con conseguente aumento del flusso coronarico > questo è dovuto al fatto che l'adenosina co-secreta insieme alla noradrenalina va a bilanciare l'azione a1 vasocostrittrice dell'adrenalina
- anche a livello della muscolatura scheletrica l'adrenalina causa vasodilatazione (sempre per azione sui (2)
Per quanto riguarda gli effetti a livello dell'apparato respiratorio, l'adrenalina presenta una potentissima azione broncodilatatrice attraverso il legame con i recettori 32 presenti a livello della muscolatura liscia dell'albero bronchiale. In particolare, questo effetto di broncodilatazione è più evidente quando ci troviamo in condizioni di iper-reattività bronchiale come in caso di asma, BPCO o quando abbiamo una risposta broncocostrittrice causata da una massiva liberazione di istamina (come accade nello shock anafilattico). Infatti gli effetti benefici dell'adrenalina nell'asma sono dovuti all'inibizione del rilascio antigene-indotto di mediatori dell'infiammazione da parte dei mastociti. Nelle reazioni anafilattico (mediate dalla classe delle IgE) si ha una iper-reattività del sistema immunitario: il legame delle IgE alle mastcellule determina la degranulazione delle stesse con conseguente liberazione di istamina e leucotrieni, responsabili della broncocostrizione tipica dello shock anafilattico. Proprio per questo motivo nello shock anafilattico il farmaco di elezione è l'epinefrina per via sottocutanea perché causa broncodilatazione nell'arco di pochi minuti e antagonizza l'azione dell'istamina (l'istamina broncocostringe, l'adrenalina broncodilata). È chiaro che quando si parla di asma non su base allergica, di BPCO o di bronchite cronica si utilizzano anche altri farmaci quali glucocorticoidi, inibitori dei leucotrieni (come il Montelukast) e farmaci B2 agonisti che hanno effetti antinfiammatori più pronunciati: l'adrenalina viene utilizzata principalmente nelle condizioni di emergenza (shock anafilattico > attraverso il legame con i recettori 32 espressi sulla muscolatura liscia bronchiale e sui mastociti promuove broncodilatazione e inibizione del rilascio dei mediatori dell'infiammazione).
Sempre per quanto riguarda l'azione sulla muscolatura liscia, a livello vescicale l'adrenalina rilassa il muscolo detrusore della vescica (per attività sui ß recettori), ma comporta contrazione dei muscoli del trigono e dei muscoli sfinterici per attività sugli a recettori con effetto netto di continenza > contrasta l'incontinenza vescicale.
Gli effetti a livello del SNC sono molto scarsi perché l'adrenalina ha una natura polare e di conseguenza non riesce a superare la barriera ematoencefalica. Gli effetti collaterali tipici dell'uso dell'adrenalina quali tremore, agitazione psicomotoria e cefalea non sono mediati dal SNC, bensì dall'azione dell'epinefrina sul sistema cardiovascolare, sul muscolo scheletrico e sul metabolismo intermedio. Per quanto riguarda l'apparato oculomotore, l'adrenalina fisiologicamente funge da midriatico, ma se instillata nel sacco congiuntivale provoca la riduzione della pressione intraoculare e può trovare impiego, anche se soltanto in determinate condizioni, nel glaucoma.
Da un punto di vista metabolico l'adrenalina ha un effetto iperglicemiazante: aumenta le concentrazioni ematiche di glucosio e di lattato, inibisce la secrezione di insulina (per azione sugli a2 recettori presenti sulle cellule ß pancreatiche) mentre aumenta la secrezione di glucagone (per azione sui ß recettori presenti sulle cellule apancreatiche) > quindi diminuisce l'up-take del glucosio a livello periferico e aumenta i processi di glicogenolisi. Inoltre ha anche azione ipertrigliceridemizzante per azione sui recettori ß3 adipocitari, per cui in ultima analisi l'adrenalina comporta un aumento del metabolismo > il sistema catecolaminergico entra in funzione nelle situazioni di stress (fight or flight) quando si ha bisogno di tutto l'apporto energetico possibile.
Usi terapeutici dell'adrenalina
Gli usi terapeutici dell'adrenalina (oltre a quelli già elencati) sono:
- shock anafilattico (emergenza) > adrenalina farmaco d'elezione per via sottocutanea
- ripristinare il ritmo sinusale in pazienti con arresto cardiaco (per via intracardiaca)
- emostasi topica per la sua azione vasocostrittrice (es. in ambito di interventi odontoiatrici o durante endoscopia in caso di ulcere sanguinanti); inoltre sempre per la sua azione vasocostrittrice l'adrenalina viene usata per aumentare la durata dell'anestesia locale
- per via inalatoria nel trattamento post-intubazione e nel croup infettivo (infiammazione importante a livello della laringe, generalmente di origine virale, che provoca difficoltà all'inspirazione, per cui quando il paziente inspira si sente una sorta di fischio > questo perché per la presenza di fenomeni edematosi indotti dall'infiammazione di natura infettiva lo spazio respiratorio della laringe si restringe, provocando nel paziente difficoltà a respirare)
Farmacocinetica dell'adrenalina
- l'adrenalina non può essere somministrata per via orale perché è una sostanza polare e verrebbe rapidamente metabolizzata ad opera delle MAO che si trovano a livello periferico ed epatico soprattutto >quindi la somministrazione orale non può essere utilizzata perché non verrebbe assorbita, cioè nel sangue se ne ritrovano quantità irrisorie che non sono in grado, proprio perché basse, di svolgere quella che è la loro azione terapeutica
- si preferisce la somministrazione parenterale: 1) via sottocutanea > assorbimento più lento, 2) via intramuscolare > più rapida rispetto la precedente, 3) via endovenosa > utilizzata nelle condizioni di emergenza (es. arresto cardiaco) dove si salta completamente la fase di assorbimento e si passa immediatamente alla fase di distribuzione nel sangue
- un'altra via di somministrazione che può essere utilizzata è la via inalatoria; in questo caso si preferisce quando si vuole ottenere un effetto di tipo locale, quindi a livello del polmone > però bisogna prestare attenzione a non esagerare con il dosaggio perché altrimenti può causare reazioni sistemiche, comprese aritmie
- l'escrezione dell'adrenalina avviene principalmente per via renale
- per quanto riguarda le formulazioni, l'adrenalina è disponibile in una varietà di formulazioni per differenti usi clinici e vie di somministrazione, compresa l'auto-somministrazione per reazioni anafilatticosaggio varia da 1 mg/ml a 0,5 mg/ml a 0,1 mg/ml; la dose sottocutanea va da 0,3 a 0,5 mg/ml. La somministrazione per via endovenosa deve essere sempre fatta con cautela, preferibilmente in ambiente ospedaliero, previa diluizione e iniezione lenta. La dose endovenosa raramente è superiore ai 0,25 mg/ml con l'eccezione dell'arresto cardiaco quando si possono rendere necessarie dosi maggiori
Interazioni farmacologiche dell'adrenalina
L'uso di adrenalina è controindicato in tutti quei pazienti che sono sottoposti a terapia con ß-bloccanti non selettivi da lungo periodo > questo perché il farmaco in questione blocca i recettori beta, sia ß1 (azione benefica a livello del flusso coronarico) sia ß2 (vasodilatazione soprattutto a livello del muscolo scheletrico), per cui tagliando fuori la componente beta prevale la componente alfa, soprattutto a1 con accentuazione dell'azione vasocostrittrice, aumentando il rischio di ipertensione severa e possibile emorragia cerebrale.
Effetti collaterali dell'epinefrina
Dosi maggiori di epinefrina possono scatenare extrasistoli ed aritmie ventricolari che possono risultare letali. Questo effetto è molto raro quando si usano delle dosi terapeutiche del farmaco, ma può verificarsi quando ad esempio il paziente che andiamo a trattare con epinefrina è stato sottoposto ad anestesia o presenta un'ischemia miocardica: questi due eventi, seppure diversi tra di loro, hanno in comune l'effetto di sensibilizzare il cuore all'azione dell'adrenalina e, quindi, una dose terapeutica può diventare per questi soggetti una dose "tossica" (quando si ha