Biochimica: Inibizione Enzimatica e Meccanismi di Regolazione
Documento di Biochimica sull'inibizione enzimatica. Il Pdf esplora l'inibizione reversibile e irreversibile, con esempi come l'aspirina, e i meccanismi di regolazione enzimatica. Questo documento universitario di Chimica è utile per lo studio autonomo degli studenti.
Mostra di più8 pagine
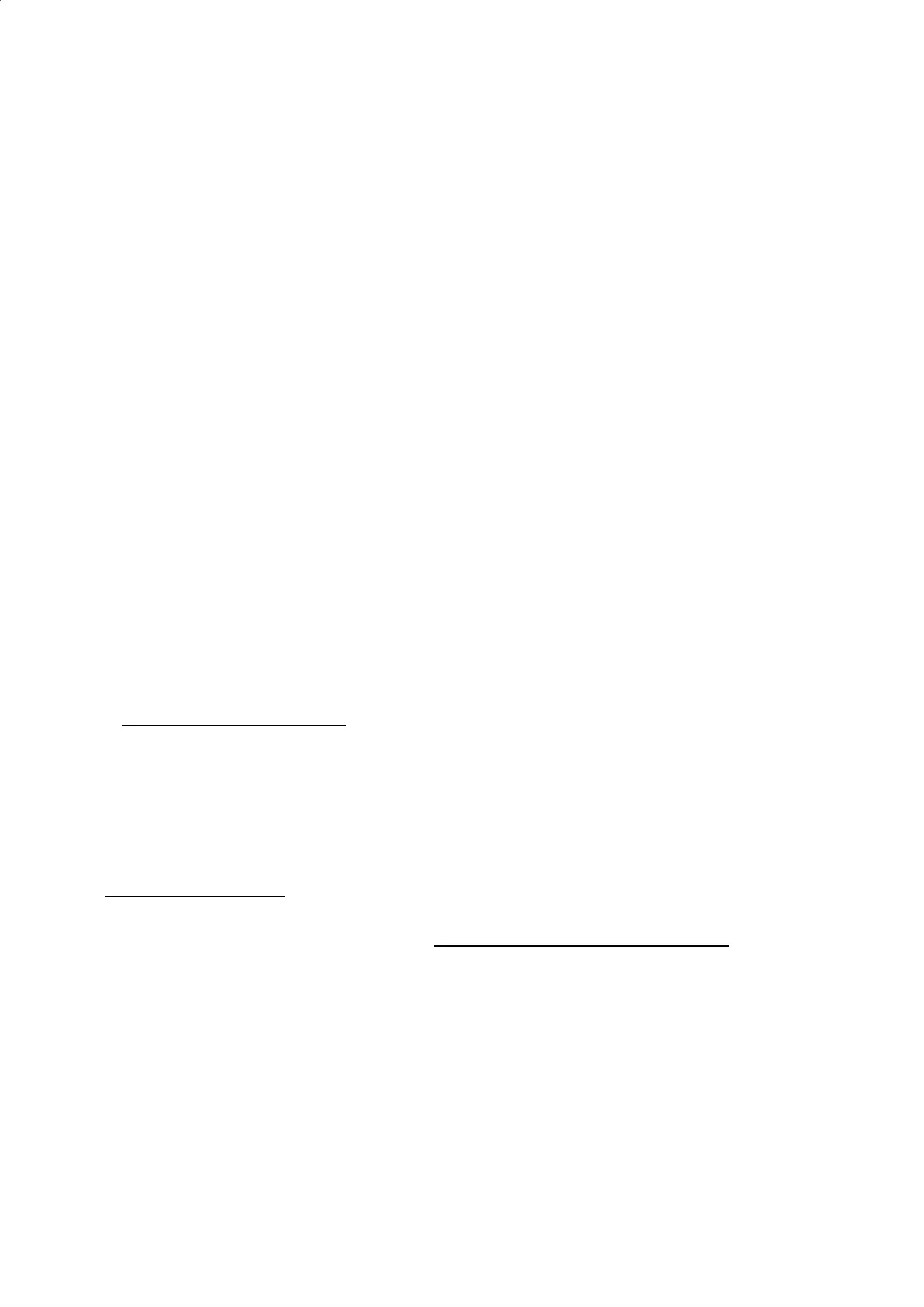
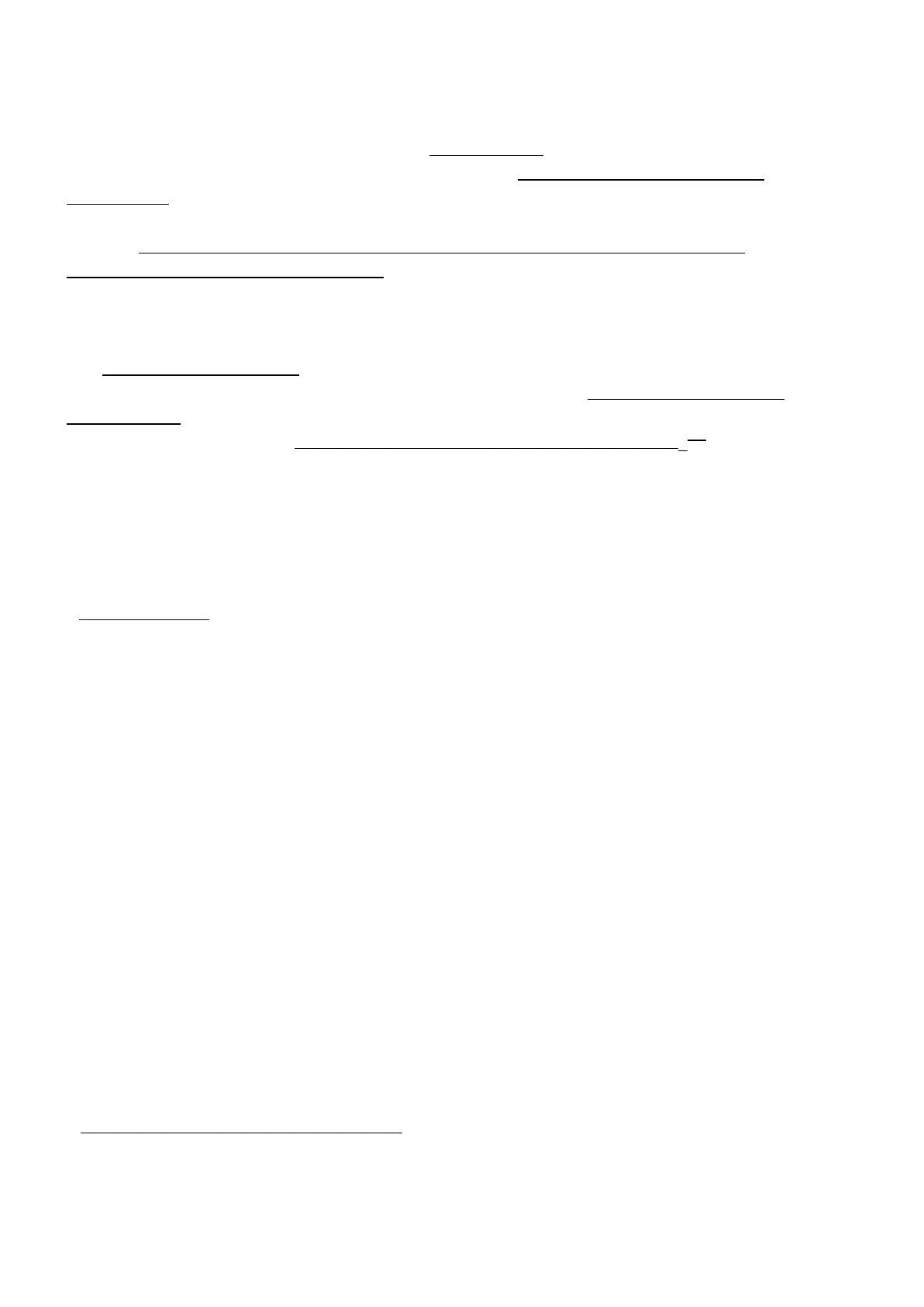
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Definizione di Velocità Massima e KM
Ricordiamo sinteticamente le definizioni di velocità massima e KM· La velocità massima è espressione del potere catalitico dell'enzima. Essa è massima quando c'è concentrazione infinità di substrato. Se vogliamo sapere il valore esatto di velocità massima dobbiamo graficare le funzioni 1/v vs 1/s nel grafico dei doppi reciproci.
La KM è definita in 3 modi:
- un rapporto di costanti;
- parametro che misura l'affinità dell'enzima col substrato;
- concentrazione del substrato in cui l'enzima lavora in regime di velocità semimassimale, cioè 1/2 della velocità massima.
Inibitori Enzimatici e Loro Importanza
Gli inibitori enzimatici sono molecole che interferiscono con la catalisi, rallentando o bloccando le reazioni enzimatiche, in particolare la loro velocità. Gli enzimi catalizzano la quasi totalità dei processi cellulari e quindi non sorprende che gli inibitori enzimatici siano tra i più importanti farmaci conosciuti. Per esempio, l'aspirina (acetilsalicilico) inibisce l'enzima che catalizza la prima tappa della sintesi delle prostaglandine, composti che intervengono in molti processi biologici, compresi quelli che partecipano alla produzione del dolore. Lo studio degli inibitori enzimatici ha fornito anche molte informazioni sui meccanismi di azione degli enzimi e ha contribuito a individuare alcune vie metaboliche. Esistono due tipi di inibizione enzimatica: l'inibizione reversibile e l'inibizione irreversibile.
Inibizione Reversibile
- INIBIZIONE REVERSIBILE
Tra i tipi di inibizione reversibile abbiamo l'inibizione competitiva, l'inibizione incompetitiva e l'inibizione mista (non competitiva) (quest'ultimi si osservano praticamente solo con gli enzimi a due o più substrati, ma spesso vengono riferiti anche a enzimi che catalizzano reazioni a un substrato).
Inibizione Competitiva
Con inibizione competitiva si intende un tipo di inibizione che coinvolge un inibitore competitivo. Quest'ultimo compete con il substrato per il sito attivo dell'enzima. Quando l'inibitore (I) occupa il sito attivo, impedisce il legame del substrato con l'enzima. Molti inibitori competitivi sono strutturalmente simili al substrato e si combinano con l'enzima formando complessi EI, senza dar luogo alla catalisi.
In presenza di un inibitore, i parametri cinetici dell'enzima cambiano? Per rispondere a questa domanda occorre analizzare quantitativamente l'inibizione competitiva, ciò può essere studiato per mezzo della cinetica dello stato stazionario.Se consideriamo una provetta all'interno della quale sono presenti un inibitore, un substrato e un enzima, la velocità massima di reazione non cambierà in quanto in questa condizione si studia il substrato a concentrazione infinita e dunque, il substrato risulterà vincitore sull'inibitore. Ciò che non potrà fare altro che cambiare sarà la KM che essendo calcolata a velocità semimassimale e non essendo il substrato, in questa condizione, a concentrazione infinita, saranno dunque necessarie più molecole di quest'ultimo affinché si possa raggiungere la velocità semimassimale.
Questa nuova K calcolata si chiama Ky apparente (KyªPP), man mano che aumenta la concentrazione di inibitore, sarà necessario più substrato affinché la reazione possa avvenire.
Inibizione Incompetitiva
Nell'inibizione incompetitiva, l'inibitore si lega a un sito distinto da quello del substrato e, contrariamente all'inibitore competitivo, solo al complesso ES. Prima si deve formare il complesso ES ma se arriva l'inibitore si forma il complesso ESI che è inattivo. Le analisi matematiche ci dicono che cambia sia la velocità massima che i valori di Kyapp, proprio per il fatto che l'inibitore si attacca ad una parte speciale dell'enzima che non coincide col sito attivo.
(Spesso questi inibitori vengono sintetizzati in laboratorio e vanno a reagire con enzimi specifici).
Inibizione Mista
L'inibizione mista coinvolge un inibitore che è in grado di legarsi all'enzima indipendentemente dal fatto che l'enzima abbia già legato o meno il substrato ma presenta una maggiore affinità per uno stato o l'altro.
Se la capacità dell'inibitore di legare l'enzima è esattamente la stessa indipendentemente dal fatto che l'enzima abbia già legato o meno il substrato, l'inibitore sarà di tipo non competitivo.
Nell'inibizione mista la velocità massima cambia in quanto l'inibitore si andrà a legare facilmente all'enzima che può avere già legato il substrato o meno.
Quindi, l'enzima formerà in entrambi i casi il complesso ESI e non si formerà il prodotto. (La velocità massima dipende dalla concentrazione di inibitore).
Nel dettaglio, la velocità massima diminuisce perché diminuisce il numero massimo di molecole che possono formarsi e trasformarsi in prodotto.
Ciò dipenderà dalla concentrazione di inibitore nella miscela, sebbene il substrato sia presente a concentrazione infinita.
Inoltre, siccome questo tipo di inibitori si legano anche senza la formazione del complesso ES, cambierà anche il valore di KyªPP , poiché saranno necessarie più molecole di substrato per raggiungere la velocità semimassimale, quindi essa aumenta.
L'inibizione mista di tipo non competitivo, invece, è un tipo di inibizione che causa una diminuzione della velocità massima ma non modifica la KM, quindi lascia invariata l'affinità dell'enzima con il substrato.Con KM reale viene inteso un parametro intrinseco dell'enzima, mentre la KM apparente indica la quantità di substrato necessaria a raggiungere la velocità semimassimale.
Inibizione Irreversibile
- INIBIZIONE IRREVERSIBILE
Gli inibitori irreversibili si legano covalentemente, eliminando cosi gruppi funzionali essenziali all'attività degli enzimi (es .: gas nervino che blocca l'acetilcolinesterasi), o formano associazioni non covalenti particolarmente stabili. La formazione di un legame covalente tra un inibitore irreversibile e l'enzima è una condizione abbastanza comune. Gli inibitori irreversibili sono anche un mezzo molto utile per caratterizzare i meccanismi di reazione.
Inattivatori Suicidi
Una speciale classe di inibitori irreversibili è costituita dagli inattivatori suicidi. Questi composti sono relativamente stabili fmo a che non si legano al sito attivo di uno specifico enzima. Un inattivatore suicida va incontro ad alcuni passaggi chimici che fanno parte del normale meccanismo di reazione dell'enzima, ma invece di essere trasformato nel normale prodotto l'inattivatore viene convertito in un composto molto reattivo che si combina irreversibilmente con l'enzima. Alcuni di questi composti sono anche detti inattivatori basati sul meccanismo di reazione, perché essi indirizzano il normale meccanismo di reazione dell'enzima verso l'inattivazione. Gli inattivatori suicidi hanno un ruolo importante nella progettazione razionale dei farmaci, un approccio moderno che serve a ottenere nuovi farmaci basandosi sulla conoscenza dei meccanismi di reazione degli enzimi.
Il DFP esercita il suo effetto tossico formando un intermedio covalente nel sito attivo dell'acetilcolina esterasi impedendo all'enzima di degradare il neurotrasmettitore acetilcolina A. Reazione normale dell'acetilcolinesterasi Acetilcolina Colina Acetato O H3C-C-O-CH2-CH2- N(CH3)3 HO-CH2- CH2 - N(CH3)3 HC- 20 O OH 0-C-CH3 - H2O OH Enz -Ser + Enz - Ser + Enz - Ser B. Reazione in presenza di inibitori organofosforici CH3 O CH3 H-C-O-P-O-C-H F- H* OH CH3 F CH3 1 CH3 O CH3 11 Enzima inattivo CH3 0 CH3 Enz - Ser Un altro esempio di inibitore covalente è l'aspirina, essa deve i suoi effetti alla capacità di di ridurre nell'organismo la produzione delle prostaglandine (mediatori flogistici, mediatori dei processi derivanti dalle infiammazioni). L'acido acetilsalicilico si lega covalentemente alla cicloossigenasi. L'inibizione di quest'ultimo indotta dall'aspirina porta a una ridotta produzione di prostaglandine con conseguente L'acetilcolina che è un neurotrasmettitore - quest'ultimo prodotti dai neuroni che li sintetizzano, liberati nello spazio e vanno a reagire sui neuroni adiacenti reagendo con altre molecole, una volta che reagisce deve essere degradato - viene degradata dal acetilcolinesterasi. Ser- 0 CHa Ser OH COX + COO COO 0 -C' OH CH3 Salicilato Aspirina (acetilsalicil CH 3 CH 3 CH CH 0 CH2 CH CH3 COO" Ibuprofene CH CH3 COO Naproxene (b) COX acetilata e inattivata + Enz -Ser + H-C-O-P-O-C-Heffetto antipiretico, antinfiammatorio e antidolorifico. L'aspirina inibisce la prima reazione acetilando un residuo di serina essenziale per l'attività dell'enzima. L'ibuprofene e Il naproxene inibiscono la stessa reazione, probabilmente perché la loro struttura è simile a quella del substrato o a un Intermedio della reazione.
Perché termina l'azione di un farmaco perché l'enzima è una proteina, quando viene degradato, le nuove molecole non porteranno il farmaco con se.
Altri inibitori sono gli analoghi dello stato di transizione che si legano in maniera più salda all'enzima rispetto che al substrato.
Un esempio di questi inibitori è la penicillina. Quest'ultima si lega molto fortemente alla glicopeptidil transferasi, enzima necessario ai batteri per la sintesi della parete cellulare. Questo enzima la lega alla serina del proprio sito attivo.
Meccanismi Generali di Regolazione Enzimatica
MECCANISMI GENERALI DI REGOLAZIONE ENZIMATICA
Come possono essere regolati gli enzimi? I meccanismi possono riguardare la regolazione di:
- concentrazione totale dell'enzima, o dei substrati;
- efficienza catalitica dell'enzima.
Possiamo dire che aumentando la concentrazione di enzima, aumenta il numero di prodotti che riusciamo a formare, quindi i meccanismi che regolano la concentrazione della proteina enzimatica o la regolazione dei substrati.
Altri meccanismi regolano l'efficienza enzimatica, cioè quanto e come l'enzima riesce a velocizzare la reazione.
Tra i principali meccanismi di controllo osserviamo quelli di tipo:
- Genico (enzimi inducibili)
- Allosterico
- Tramite la velocità di degradazione
- Tramite modifiche covalenti reversibili
- Tramite la concentrazione dei substrati
- Tramite proteine regolatrici
- Tramite attivazione proteolitica irreversibile
- Tramite la compartimentazione
Per quanto concerne la sintesi di un enzima, sappiamo di poter controllare l'espressione genica attraverso gli enzimi inducibili, che sono quegli enzimi la cui concentrazione è regolata a livello genica, se la cellula ne ha bisogno lo sintetizza se non serve lo degrada.