Museologia, Museografia e Museotecnica: concetti e gestione museale
Documento di Università su Museologia, Museografia e Museotecnica. Il Pdf, utile per lo studio dell'Arte a livello universitario, fornisce definizioni e concetti fondamentali, trattando argomenti come l'acquisizione, i prestiti, la conservazione e il restauro delle opere.
Mostra di più10 pagine
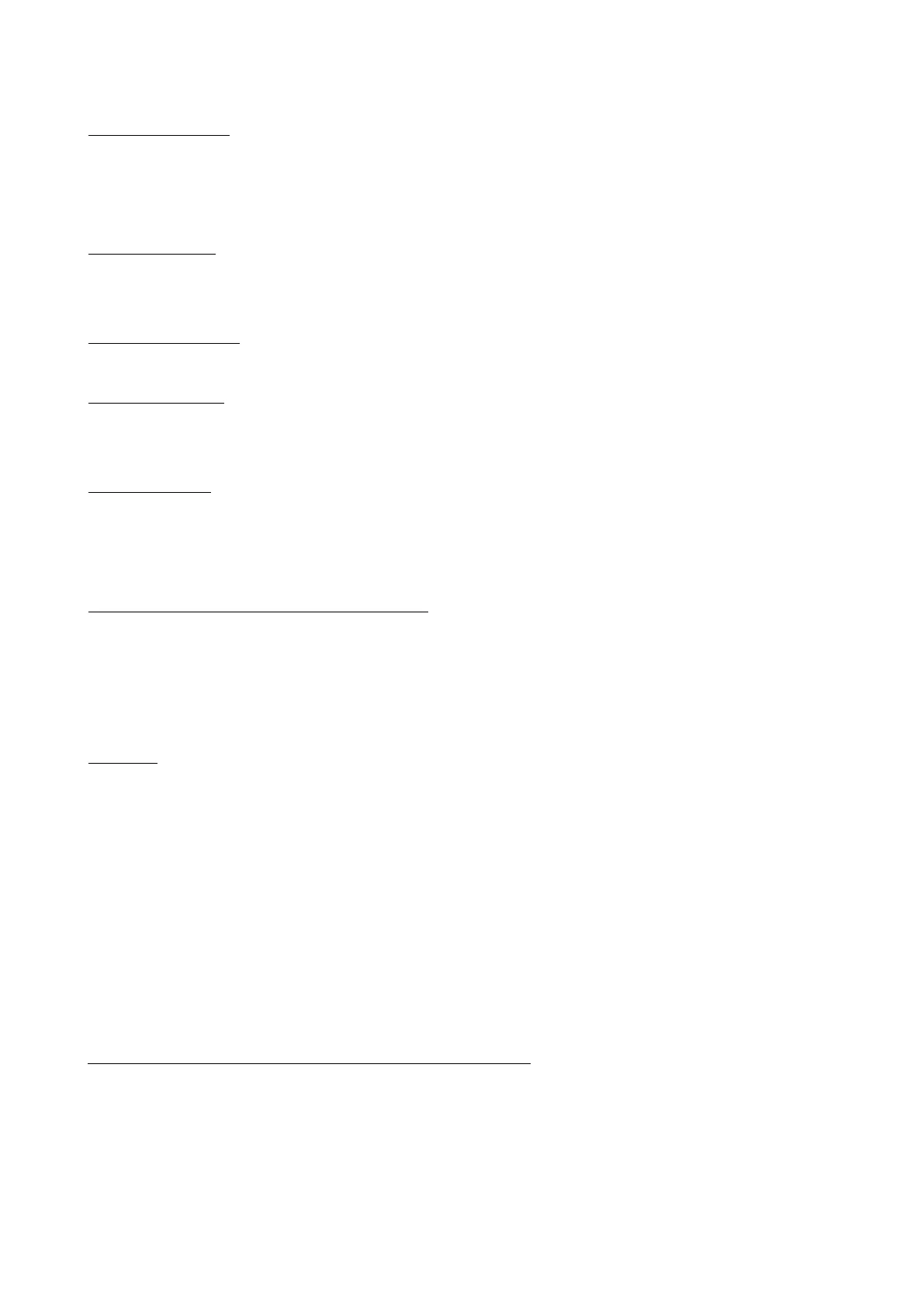

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
MUSEOLOGIA, MUSEOGRAFIA E MUSEOTECNICA
MUSEOGRAFIA: disciplina che si occupa della progettazione della sede museologica, del museo, degli uffici, ... creare un museo non significa solo architettura ma anche museologia. Indirizza la progettazione degli spazi espositivi nella loro variegata complessità.
MUSEOLOGIA: scienza sociale che unisce conoscenze specialistiche, umanistiche o scientifiche cercando di affrontare contenuti immateriali dei musei, gli obbiettivi, le funzioni, i vincoli, ciò che viene creato nell'ambito museale.
MUSEOTECNICA: insieme delle conoscenze pratiche che permettono lo svolgimento della missione d'istituto.
MUSEOGRAFO: architetto specializzato che può collaborare con il museologo, coautore dell'allestimento e propone la distribuzione degli spazi, le attrezzature, gli arredi, ...
MUSEOLOGO: responsabile scientifico che conosce la natura e le vocazioni delle raccolte, principi e metodi della loro valorizzazione e possiede la capacita di elaborare la filosofia del proprio museo e is poi programmi, cura l'attuazione dei progetti connessi.
INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM): associato UNESCO, organizzazione internazionale dei musei con lo scopo di preservare, assicurare la continuità e comunicare il valore del patrimonio culturale e naturale mondiale, ha delle linee guida per musei e protocolli all'interno dei musei.
MUSEO: secondo l'ICOM è un'istituzione permanente senza scopo (parzialmente) di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperto al pubblico, compie ricerche che riguardano testimonianze materiali e immateriali, le acquisisce, le conserva, le comunica, le espone. a differenza dell'archivio, il museo diffonde. Il museo ha diverse funzioni: l'incremento e la disponibilità delle collezioni, catalogazione, documentazione e ricerca scientifica per poi pubblicare, conservazione/manutenzione/restauro (alcuni musei nascono come laboratori di restauro), allestimenti, attività educative per la formazione permanente, accesso alla documentazione archivistica e iconografica, informazione sul museo/promozione pubblicitaria e diffusione, scambi culturali.
PATRIMONIO, ACQUISTO E NUOVE ACCESSIONI
Le forme di acquisizione sono: la donazione, il lascito testamentario, il deposito, il comodato a termine, il rinvenimento fortuito, dismissione o soppressione di enti e del loro patrimonio mobile (es con soppressione province le opere sono state portate dai vecchi istituti ai nuovi), campagne di raccolta promosse dai musei, beni confiscati da parte degli organigiudiziari e scambi con altri musei. Necessaria una commissione che valuta ciò che si vuole inserire nel museo.
I criteri per l'incremento delle raccolte: autenticità e coerenza (è indispensabile che un museo svolga il proprio lavoro efficientemente e acquisire solo patrimoni che vanno conservati e valorizzati), vincoli e sostenibilità (il vincolo è il controllo del bene, che può vincolare patrimoni pubblici e privati, il contro di questo vincolo è che si può gestire un bene sempre con vincoli della soprintendenza, tuttavia il pro è che la soprintendenza può aiutare il privato sia per il trasporto che per la conservazione del bene.).
Gli elementi che regolano la politica delle nuove accessioni: la vocazione intrinseca alla natura delle collezioni, il rapporto fra consistenza, specificità e scenario geografico-museale in cui si trova (coerenza), la sostenibilità dell'incremento rispetto alla previsione delle risorse disponibili per assicurare i livelli ottimali di conservazione e valorizzazione (fruizione per pubblico ed enti, accertarsi prima di compare un'opera di avere le risorse necessarie per conservare e valorizzare).
I PRESTITI DELLE OPERE D'ARTE
Motivi per ACCETTARE il PRESTITO
I motivi per ACCETTARE il PRESTITO: il direttore del museo valuta se il progetto/cessione del prestito è valido, vengono riunite le opere che il tempo ha diviso (burocratiche, per conflitti), accessibilità alle opere che solitamente non lasciano mai i depositi, conoscenze di nuove culture (multi-disciplinarità), restauro dell'opera (manutenzione in cambio dell'esposizione), per favorire gli scambi e le collaborazioni tra i musei.
Motivi per RIFIUTARE il PRESTITO
I motivi per RIFIUTARE il PRESTITO: restrizioni o problemi legali, progetti scientifici non validi, mancanza di fiducia nell'organizzazione (spesso per l'organizzazione dei trasporti), problemi di conservazione o recente esposizione dell'opera (opere vulnerabili, di materiale deperibile, facilmente rovinabile, potrebbe subire un periodo di 'pausa'), l'opera non è disponibile nel periodo richiesto (spesso per il nullaosta, tempistiche), la richiesta non viene presentata regolarmente, la sede espositiva non risponde agli standard/requisiti museali previsti (FACILITY REPORT).
La LETTERA DI RICHIESTA per chiedere un'opera va inserito il progetto scientifico, una scheda della mostra (dove si riassume l'operatività della mostra, luogo, curatori, orari, ... ), il contratto di prestito (assicurazioni, trasporti, ... aggiornato da chi presta l'opera), il facility report.
L'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE: chi decide di prestare un'opera necessita quest'autorizzazione, un nullaosta. Questa include, in allegato: la richiesta di prestito, il piano scientifico, l'elenco delle opere previste in esposizione, il facility report, lascheda conservativa e il controllo assicurativo (o proposta di contratto assicurativo e il trasporto, ditte che fanno trasporti di opere d'arte in Italiana sono poche).
CAMPAGNA DI CATALOGAZIONE
Ma come si progetta una CAMPAGNA DI CATALOGAZIONE? Uno dei compiti di chi gestisce i musei è quello di identificare i principali manufatti artistici da catalogare. Si parte dai nuclei primari, sia nei musei che nelle pinacoteche. Si identifica i nuclei prioritari secondo i criteri a medio termine del museo (allestimento, esposizioni, fattori di rischio, ... ). Vanno individuate le competenze dei catalogatori, i termini della formazione, le risorse finanziarie necessarie e le risorse logistiche. Si valuta poi i tempi e le fasi del lavoro, risorse umane, vincoli e rischi, risorse tecnologiche, bisogna poi prevedere i vincoli d'uso, diritti d'autore, la pubblicazione e la diffusione dei risultati. Chi si occupa della catalogazione, svolge la sua attività in un settore specifico e quindi dovrà essere specializzato. La catalogazione ha un costo alto.
Gli strumenti iconografici complementari alla schedatura sono: la documentazione fotografica e grafica (rilievi, radiografie, ... ).
Gli archivi possono essere cartacei e digitali: gli ARCHIVI ANTICHI sono fondi archivistici e non dovrebbero essere mai smembrati e, se si ritiene opportuno dislocare un documento o informazione è meglio ricorrere alla riproduzione (opera d'arte va manipolata il meno possibile, la miglior cosa è digitalizzarla, cosi da avere l'opera in sicurezza), SCHEDARI cartacei e/o fotografici, SUPPORTI DI MEMORIA DIGITALE archivi di testo e immagini completamente digitali (consigliabile che siano salvati anche su supporto cartaceo). Un conservatore deve fare più salvataggi (server+cartaceo) e conservarli in posizioni diverse per non perdere i dati. Nei musei ogni opera è diversa dall'altra, le campagne di catalogazione hanno un costo importante, è differenziata a seconda della specializzazione.
Il museo è un centro di documentazione, è un centro polivalente: serve per la ricerca e gestione interna, un servizio permanente e accessibile ad altri. Si deve regolare come un qualsiasi altro archivio e biblioteca aperti al pubblico.
Nella programmazione e previsione di bilancio bisogna tener conto: della salvaguardia dei vecchi archivi, previsioni di incremento dei libri, risorse finanziarie, risorse umane, regole di accesso (tariffe, agevolazioni, ... ) per fornire informazioni e documentazioni a terzi, pagamenti di diritti d'autore per opere originali, entrate per i diritti di produzione, rispetto delle informazioni riservate, ...
Il responsabile del centro di documentazione lavora a contatto con chi svolge ricerche nel museo, chi svolge funzioni didattiche, chi svolge promozione e con chi ha ruoli amministrativi. L'attività editoriale del museo può promuovere una propria attività editoriale, per la pubblicazione di cataloghi, riviste, bollettini. Può mettersi in relazione con l'università, istituiti di ricerca e singoli studiosi; successivamente può ricorrere a tipografia o case editrici. La tipografia, a seconda della richiesta, stampa mentre lacasa editrice da una serie di servizi più ampi come la correzione di errori, la verifica delle informazioni, ...
I canali privilegiati delle pubblicazioni museali: vendita nella sede del museo, nelle librerie locali, nelle librerie specializzate, omaggi per recensioni, biblioteche, rappresentanza, scambi con altri musei e istituzioni culturali.
Tutela, salvaguardia e tutelazione
Tutela, salvaguardia e tutelazione: la CARTA DEL RESTAURO è fondamentale per quanto riguarda la conservazione e salvaguardia. Prima del 1972 ogni restauratore faceva in modo soggettivo il restauro, senza seguire una linea guida. La carta del restauro introduce elementi da tenere in considerazione per la tutela e salvaguardia, gli elementi da tenere in considerazione sono la MATERIA e l'ESPRESSIONE per prevenire e arrestare le modifiche della materia senza incidere sui valori dell'opera, il FUNZIONAMENTO di strumenti musicali/oggetti, il CONTESTO anche se si è già perso l'ambiente di origine è possibile un ulteriore decontestualizzazione, la STORIA per conservare i dati documentari, iconografici, ... , l'AURA ciò che influenza la percezione da parte dell'osservatore ed è necessario l'aura che può essere minacciata da affollamento di oggetti, didascalie, affollamento, rumorosità, ...
La trasmissione al futuro dell'oggetto è alla base della missione del museo e condizione di ogni altra sua attività. La conservazione dell'oggetto è direttamente proporzionale alla conoscenza dell'oggetto, al riconoscimento del suo valore per la comunità, alla formazione del conservatore, alla cultura e coinvolgimento, alla notorietà, alla più larga fruibilità, ...
CONSERVAZIONE PREVENTIVA e SICUREZZA
Attenzione verso provvedimenti atti a ridurre i rischi del deperimento o perdita degli oggetti. Non si imposta solo sull'oggetto.
Ci sono sempre responsabili tecnici.
I FURTI possono essere di qualsiasi tipo e sono molto frequenti a differenza di quello che si pensa. Un piano di tutela dal furto richiede misure di prevenzione diverse, anche per atti di VANDALISMO, a seconda del tipo di esposizione delle opere (se durante l'orario di visita, di chiusura, nel trasporto ... ). Le assicurazioni vengono fatte per evitare, dall'inizio alla fine, problematiche a "chiodo a chiodo". Fattore umano limitante (atti amministrativi lenti, scarso senso di responsabilità, conoscenze inadeguate, ... ), punti critici.
In caso di furto è prevista la denuncia, si comunica alla compagnia di assicurazione e poi in contatto con la soprintendenza. Se un'opera catalogata viene rubata verrà poi bannata nel sito.