Appunti di Sociologia: origini, prospettive e interazionismo simbolico
Documento di Università sulla sociologia, le sue origini post-rivoluzione industriale e le prospettive funzionaliste e conflittualiste. Il Pdf analizza le diverse tipologie di azione sociale secondo Weber e approfondisce l'interazionismo simbolico di Simmel e Mead, con un focus sulla socializzazione e l'interazione sociale.
See more27 Pages
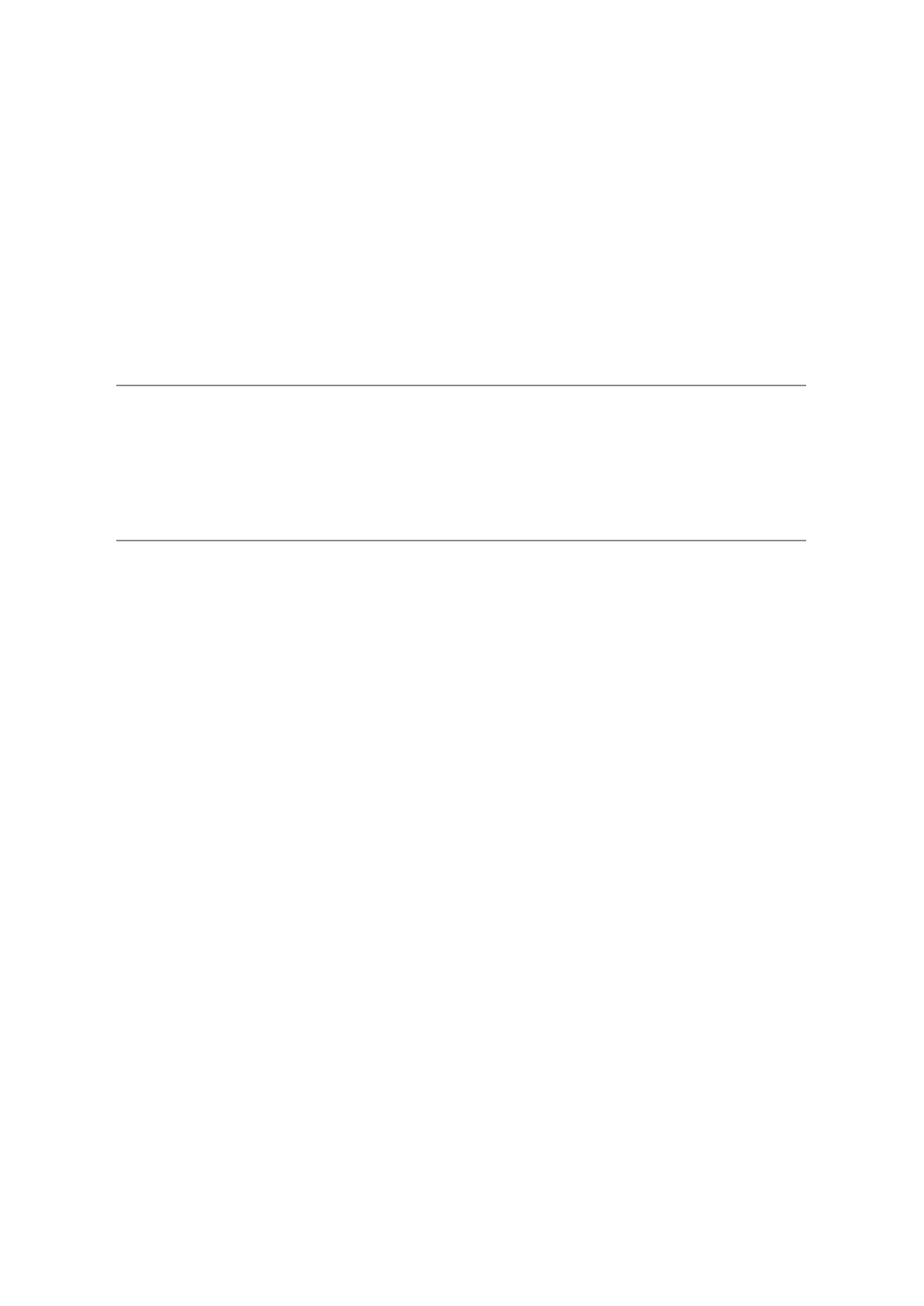

Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Sociologia: Origini e Prospettive
Se si parla di sociologia, ci collochiamo tra l'800 e il 900, dopo la rivoluzione industriale (grandi cambiamenti sociali che investono le società occidentali). Essa è un sapere che tiene in dialogo prospettive anche molto differenti tra loro, per questo definite metaforicamente 'occhiali' che permettono di vedere aspetti diversi del mondo sociale.
- di cosa si occupa la sociologia?
Per definizione, la sociologia è lo studio di come le persone stanno insieme e di come non stanno insieme.
Ambiti della Sociologia
La sociologia che studia le interazioni tra le persone all'interno di una coppia -> micro sociologia; all'interno di un gruppo -> meso sociologia nella società -> macro sociologia La sociologia è, perciò, un sapere interdisciplinare per natura.
Disuguaglianze Sociali
La sociologia studia, quindi, anche come le persone non stanno insieme, e per farlo analizza e denuncia tutti quei fattori che intralciano le interazioni tra due persone, le "disuguaglianze" che la sociologia stessa vuole denunciare. Ad esempio, in una coppia alla fine del matrimonio lei dice "il peso dei figli, il lavoro domestico, ... è tutto a carico mio". Questa non è un'informazione corretta personale, è una struttura sociale occidentale che si riflette nel collettivo, nel comune. Questo ci spiega quindi come le persone non stanno assieme.
Il Funzionalismo
La sociologia nasce funzionalista. Se premettiamo che i primi "proto-sociologici", quali Comte e Spencer, iniziarono a definire la società in un'ottica estremamente organicista, attraverso la metafora del corpo umano (società come corpo dove ogni organo lavora per un obiettivo comune), da questo organicismo, la prima corrente che si studia è il funzionalismo. Esso sostiene che ogni sistema abbia una funzione, ogni organo deve svolgere un certo compito utile (e fondamentale) all'organismo intero, che deve stare in una sorta di equilibrio.
Classici della Sociologia e Cambiamenti Sociali
I cosiddetti 'classici' della sociologia elaborano le proprie teorie tra 800 e 900, a partire dai cambiamenti che investono le società occidentali in quel periodo (rivoluzione industriale, l'emigrazione, le fabbriche .. ). Problematizzano e si chiedono come vivono in questa società. Ma anche la migrazione di masse di persone dalle campagne alle città (inurbamento) e l'organizzazione del lavoro in fabbrica.Questi fenomeni, cambiando il modo di vivere e le forme del legame sociale, segnano il passaggio a forme di organizzazione sociale diverse dalle precedenti e fanno sorgere questa domanda:
- Cosa tiene insieme la società? Come fa la società a stare insieme? Cosa dura nel tempo e cosa cambia?
Questa domanda è al cuore della prospettiva funzionalista. Per Spencer e Comte (Comte stesso ha coniato il termine 'sociologia'), la società sta insieme perché ogni sistema 'svolge una funzione' (cfr metafora del corpo umano), in questo modo si garantisce l'ordine sociale. Comte si interrogava sull'ordine sociale (statica sociale, cioè gli elementi stabili in una società) e sul mutamento sociale (dinamica sociale, cioè le trasformazioni sociali). Comte, Marx -> come facciamo a tenere insieme la società? Sta insieme perché i diversi organi stanno in un equilibrio armonioso. Metafora del proto sociologi -> sta insieme come il cervello perché ogni organo svolge una funzione -> collaborazione modo di guardare la società -> corrente funzionalista -> la collettività è importante Per i funzionalisti, ci sono delle funzioni che ogni individuo e ogni sistema deve svolgere per giovare all'intero. Dobbiamo pensare a una società come ad un sistema in equilibrio, ed è essenziale considerarlo come l'omeostasi ((fenomeno secondo cui, in biologia, gli organismi viventi tendono a mantenere in equilibrio le proprie caratteristiche interne al variare dei fattori esterni) in un sistema. Se c'è segno di un conflitto bisogna affrontarlo (come si affronterebbe la malattia nel corpo).
Filosofi Positivisti e Progresso
I filosofi positivisti europei (quali Spencer e Comte), abbracciando l'idea di progresso inarrestabile attraverso sviluppo industriale, scienza e tecnica, sostengono che la conoscenza, anche sociologica, avvenga solo analizzando fatti empirici e formulando leggi. L'intento non è solo descrivere le trasformazioni sociali, ma anche spiegarle, prevederle e indirizzarle. L'equilibrio è quindi positivo e va mantenuto, ed anzi, tutti i sistemi tendono spontaneamente ad esso.
Evoluzione delle Società secondo Spencer
Spencer, nello specifico, parla di evoluzione delle società per intendere che così come gli organismi da monocellulari diventano pluricellulari e sviluppano organi diversi che svolgono ognuno una propria funzione vitale, così le società si evolvono per adattarsi all'ambiente, sviluppando sempre più funzioni.
Il Conflittualismo
In questo stesso periodo, nasceva un'altra corrente del pensiero sociologico, che rispetto all'ordine sociale privilegia lo studio del mutamento sociale: il conflittualismo. approccio conflittualista -> la metafora degli organi all'unisono è fuorviante. Si tratta di guardare ai conflitti, a ciò che non funziona e l'ordine non ha nulla di positivo. È una rappresentazione ideologica e le classi sono caratterizzati da continui conflitti (micro, macro) società = sistema in equilibrio. ordine sociale e equilibrio = positivi da mantenere -> ARMONIA ES. Il funzionalismo sta a vedere chi svolge la funzione economica Quando parliamo di sistemi parliamo di sistema economico includendo industrie, consumatori ... il sistema va dal micro dell'individuo al macro.
- Teorie funzionaliste
Come scritto nell'introduzione, questa prospettiva è debitrice dei lavori di autore quali Comte e Spencer, ma si considerano Durkheim il fondatore del funzionalismo e Parsons il primo a fornire una teoria onnicomprensiva della società come sistema di parti interrelate.
Émile Durkheim (1958-1917)
È positivista e inaugura il funzionalismo. Durkheim dice: 'per studiare la società serve un metodo scientifico'. Come per le altre scienze, anche lo studio delle società ha bisogno di un metodo e di un oggetto di studio preciso che distingua, ad esempio, la sociologia dalla psicologia. Durkheim ha molto influito anche sull' antropologia: per esempio, attraverso gli studi sulle tribù primitive del suo ultimo allievo Mauss, si arriva a capire che il 'dono' (fatto da un donatore ad un donatario), avendo la funzione di creare e mantenere i legami comunitari, è una pratica sociale con un carattere di obbligatorietà -> chi riceve deve poi ricambiare. Questo, per Mauss, è un fatto sociale totale, esplicativo dell'organizzazione di una società nel suo complesso. L'oggetto della sociologia sono i fatti sociali. Per Durkheim i fatti sociali sono convenzioni, regole morali, credenze, pratiche, leggi e rituali, i quali sono determinati dalla collettività, non dal singolo individuo. Questi fatti sociali sono coercitivi (perché si impongono all'individuo come esterni, in quanto credenze e comportamenti dettati dalla collettività) e il sociologo deve spiegare i fatti sociali ricorrendo ad altri fatti sociali. Per esempio, Durkheim riconduce un'azione apparentemente tanto personale e intima quanto il suicidio a cause sociali, scartando dall'analisi e il fattore psicologico.
I Fatti Sociali
I fatti sociali comprendono:
- Convenzioni
Quando guido, so che il verde significa 'vai' e il rosso 'stop'; questa è una convenzione. lo nasco in una realtà dove c'è questa convenzione. La mia psiche individuale e la mia volontà non determinano questo fatto sociale. Allora questo fatto sociale è 'duro', perché mi imbatto in qualcosa che è stato deciso dalla comunità -> la collettività ha un potere che esercita sull'individuo.
- Regole morali
'Le regole morali escono nel tempo anche a seconda delle lotte che fanno le minoranze'. Sono determinate collettivamente, esterne, 'dure' rispetto al singolo (critica al funzionalismo). Le regole morali non sono 'fisse', e allora come ci spieghiamo il cambiamento? Durkheim dice 'intanto, se parlate di eventi sociali, riguardano comunque la collettività, il singolo non può intervenire'. La società è coercitiva sul singolo per Durkheim.
- Credenze
stereotipi ... pensiamo di avere un pensiero personale su tanti argomenti ... MA sottovalutiamo spesso quando le nostre credenze siano collettive. Tutti noi pensiamo di aver sviluppato delle credenze personali su determinate cose, ma in realtà tante sono collettive. ES: le credenze religiose -> io appartengo a una religione, in cui le credenze dipendono da una condivisione, sono stata educata in un certo modo; non sono credenze personali, io le posso condividere ma non le ho create io, non è 'farina del mio sacco'.
- Pratiche
Tante sono pratiche sociali. ES: pratica della lezione: la lezione è dettata dalla collettività, fare lezione è un modo imposto dalla società; ci sono orari, ci sono norme, anche spazialmente è normata. Se io mangio il panino con le mani: ok. Se mangio la lasagna: posso farlo, ma non cambio le pratiche. sociali. È la forza della collettività che dice che il primo si mangia con la forchetta
- Leggi
Si arriva all'arresto, la forza della collettività arriva ad isolare il singolo, non facciamo noi le leggi. Se infrango la legge, si raggiunge l'arresto -> forza della collettività che va ad isolare il singolo
- Riti
Interazioni normate che hanno spazio e tempo, come andare a messa ma anche andare allo stadio. C'è un tempo, un luogo, uno spazio, ci sono delle norme che prescindono dal singolo. Sono coercitivi rispetto all'individuo. Essi vanno spiegati ricorrendo ad altri fatti sociali. Durkheim studia i fatti sociali ricorrendo ad altri fatti sociali, non ricorrendo a concetti filosofici ecc.
Il Sacro
No esame, ma utile 'Durkheim considera il fenomeno religioso come fonte primaria di integrazione sociale. Egli tratta la religione come fenomeno sociale fondativo, perché istituisce la differenza tra sacro e profano: "la religione è il sistema condiviso di credenze di pratiche (reti) relativi a cose sacre, ossia separate, interdette le quali uniscono in un'unica comunità morale chiamata chiesa, tutti quelli che vi aderiscono". Gli uomini sentono la forza che la società esercita su di loro ma, non riuscendo identificarne la fonte nella società stessa, la trasferiscono al sacro. Dunque, per Durkheim, avvertendo una forza che li sovrasta, gli uomini la nominano indicando cose sacre come divinità, totem, re e sovrani (es: totem pagina 9). Quindi, è spesso nel fenomeno religioso che si celebra il carattere sacro del gruppo, fatti sociali e sacro sono dunque elementi su cui si basa l'integrazione sociale.'