Appunti di Sociologia Generale: evoluzione della memoria culturale
Documento dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia su Appunti Sociologia Generale - Cevolini. Il Pdf esplora l'evoluzione della memoria culturale e dei sistemi di conoscenza, dalla ripetizione alla produzione di nuove informazioni, con contributi di autori come Harrison, Drexel e Muratori.
Mostra di più41 pagine
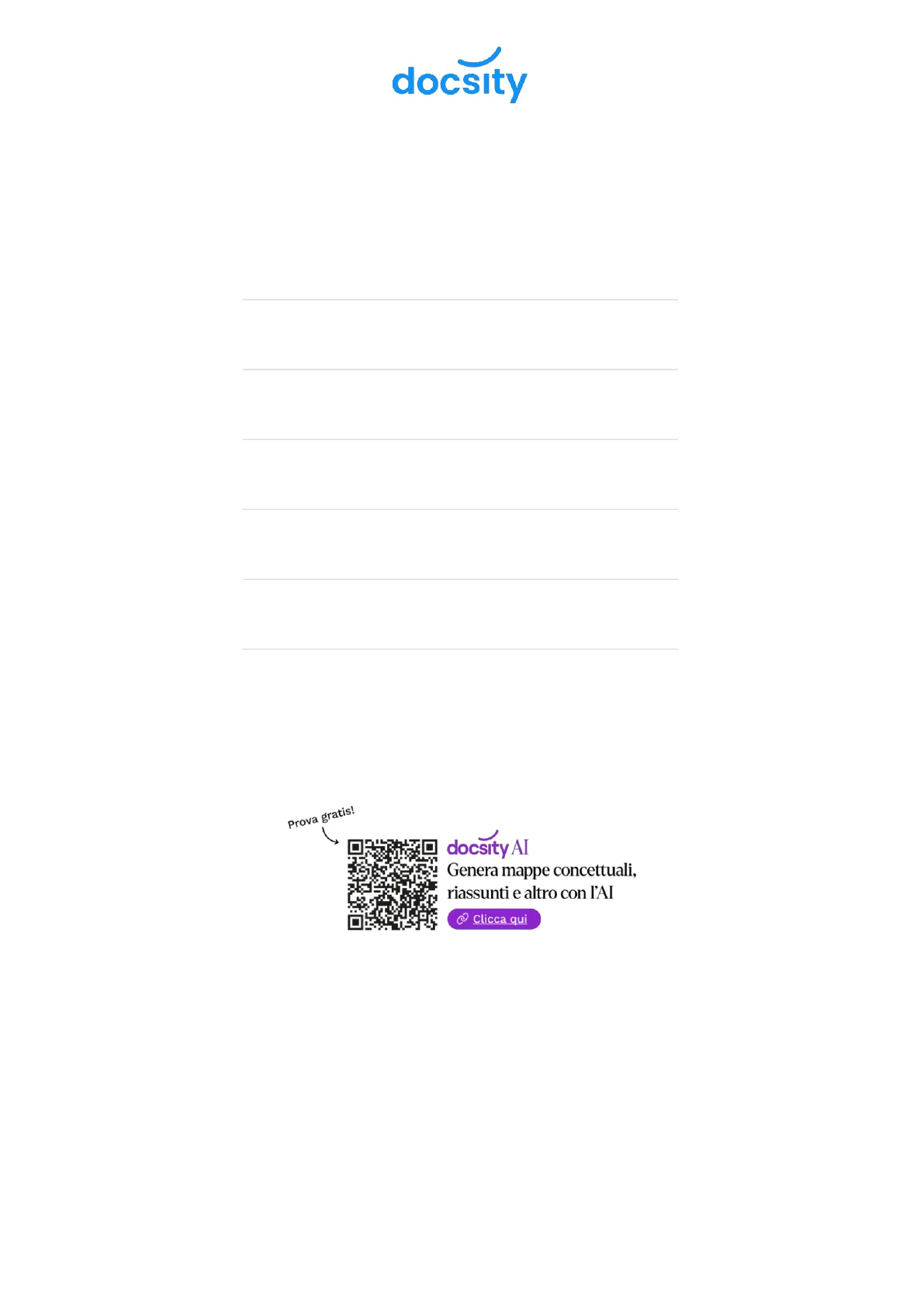

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
docsity
Appunti Sociologia Generale - Cevolini Sociologia Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) 38 pag. Prova gratis! docsity AI Genera mappe concettuali, riassunti e altro con l'AI ~ Clicca qui Downloaded by: alessia-saselle (alessiasaselle@gmail.com)Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-sociologia-generale-cevolini/5399137/ Downloaded by: alessia-saselle (alessiasaselle@gmail.com)PARTE I
Sociologia Generale
Il termine sociologia è relativamente recente, è inventato nel 1839 dal francese A. Comte ("Corso di filosofia positiva", 1830- 42). La sociologia nasce dallo spirito del positivismo, con l'idea che per cambiare la società in meglio e incoraggiarne il progresso bisogna capirne le leggi. Per comprendere le leggi del progresso sociale, le scienze sociali dovranno essere sviluppate con gli stessi metodi delle scienze naturali, quindi con approccio positivista attraverso il metodo scientifico.
Comte all'inizio non parla di sociologia ma di fisica sociale, termine già coniato da Quételet in ambito però statistico: si notano delle strane ridondanze nella casualità, nella contingenza. Comte per distinguersi allora inventa un nuovo termine: sociologia. Il neologismo è abbastanza improprio, nel senso che si basa sulla parola latina 'societas' e sulla parola greca 'logos', ma è comunque una nuova disciplina, una scienza della società, divisa in statica sociale e dinamica sociale: la statica vuole comprende le regole dell'ordine sociale, la dinamica invece vuole studiare le leggi del divenire con la forma di progresso.
Come ambito di ricerca e di insegnamento, la sociologia si è poco alla volta istituzionalizzata dalla fine dell'Ottocento. Come disciplina scientifica, la sociologia è invece ancora oggi indisciplinata, in quanto non è ancora riuscita a dotarsi di una teoria condivisa da parte di tutti i sociologi. Lo si vede bene dal fatto che non esiste un linguaggio teorico comune condiviso in modo unanime e non c'è neanche una referenza empirica (una realtà a cui fare riferimento) che sia univoca, chiara, obiettiva e precisa. Questa è quella che oggi è chiamata crisi della sociologia.
Qual è l'unità elementare della realtà sociale? Si hanno due risposte distinte: azione, una delle prime risposte, e, quasi mezzo secolo dopo, comunicazione, risposta molto più recente (dalla seconda metà del 1900).
Azione
- M. Weber - uno dei più grandi sociologi che ha provato a dare un contributo alla teoria sociologica, pur non essendo un sociologo di formazione. Nell'introduzione di "Economa e società", pubblicata postuma nel 1921, definisce i concetti fondamentali della sociologia. Non si può ancora dire che con qui comincia la sociologia, ma almeno vi è uno sforzo teorico per creare una teoria della società.
- T. Parsons - con le due opere "La struttura dell'azione sociale", 1937, e "Il sistema sociale", 1951, in cui definisce l'azione come unità fondamentale della società. Non solo l'azione è un sistema, ma la società è un sistema d'azione.
Comunicazione
- J. Habermas - nell'opera "Teoria dell'agire comunicativo" del 1981, parla di agire, che può essere strumentale per ricevere profitto (tutto ciò che riguarda economia, capitalismo) o comunicativo per creare consenso.
- N. Luhmann - nell'opera "Sistemi sociali" del 1984 (non è la sua prima opera, ma è la sua 'opera 0'), parla di sistemi sociali che producono comunicazione.
Max Weber
L'unità fondamentale della società è l'azione, però non tutte le azioni sono azioni sociali.
Come si distingue il comportamento dall'azione?
Gli individui hanno una coscienza capace di elaborare senso, quindi sono soggetti, i quali possono possono comportarsi o agire. Nella distinzione tra fare e tralasciare, W. identifica il comportamento. Prima però introduce un'altra distinzione: fra interno (pensare di fare o tralasciare qualcosa) e esterno (fare o tralasciare qualcosa, azione osservabile), ed è su quest'ultima che bisogna concentrarsi. Per quanto riguarda il fare, il soggetto lo può imputare a se stesso o può essere eteroimputato, e ha una ragione; il tralasciare invece non è motivato o intenzionato.
Il comportamento diventa azione quando viene collegato al proprio fare o tralasciare un senso inteso soggettivamente.
Come si distingue l'agire sociale dall'agire non sociale?
Perché un'azione sia sociale, non è sufficiente collegare al proprio fare o tralasciare un senso soggettivo, ma è necessario che il soggetto che agisce si orienti e tenga conto contemporaneamente anche del comportamento degli altri. Si parla perciò di co-orientamento. W. identifica due forme di agire non sociale: l'agire collettivo (es. piove e tutti aprono l'ombrello), a cui viene connesso un senso soggettivo ma non tiene conto del co-orientamento, e l'agire determinato dalla massa (es. uno stadio si svuota perché è diventato pericoloso), quando è quasi determinato dal comportamento della massa e anche in questo caso viene a mancare il co-orientamento.
1 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-sociologia-generale-cevolini/5399137/ Downloaded by: alessia-saselle (alessiasaselle@gmail.com)Attraverso queste due grandi discriminazioni, W. identifica l'unità elementare della società: l'agire sociale.
W. fa un'ulteriore distinzione fra orientamento al comportamento degli altri (noti o anonimi), intesi come soggetti agenti ai quali ci si sta co-orientando, dunque è sociale, e orientamento al comportamento degli oggetti, che, poiché si tratta di oggetti, non ha niente a che fare con l'azione sociale. Nel sistema sociale, ci si dovrà co-orientare non solo al comportamento degli altri, ma anche al co-orientamento degli altri al proprio comportamento. Per questo si parla di circolarità di reciproco co- orientamento. Nel co-orientamento al comportamento degli altri, il comportamento può essere passato, presente o atteso in futuro.
Classificazione delle forme di agire sociale
- Agire razionale rispetto allo scopo (primato nella società moderna): è determinato dalle aspettative sul comportamento di oggetti/individui del mondo esterno, usate come mezzo per raggiungere scopi razionali. Il soggetto che agisce in modo razionale giudica se i mezzi sono adeguati al raggiungimento dello scopo e valuta anche se le conseguenze possono essere desiderate o meno. Il soggetto considera gli scopi che potrebbe raggiungere e dà più valore allo scopo migliore di altri. Ciò a cui si orienta il comportamento del soggetto agente sono quindi le sue aspettative sul possibile comportamento delle persone/ cose. Si parla dunque di un co-orientamento del soggetto agente a se stesso.
- Agire razionale rispetto al valore: il soggetto agente crede ciecamente a qualcosa e si orienta al valore di questo qualcosa, decidendo di agire razionalmente a prescindere dal successo del proprio agire.
- Agire sociale di tipo tradizionale: il soggetto agente si orienta a tutte quelle abitudini che si sono in qualche modo sedimentate dentro di lui.
- Agire sociale di tipo affettivo o emotivo: il soggetto agente si orienta ai propri impulsi.
W. parla ora di relazione sociale per indicare il comportarsi di più soggetti agenti che si orienta al comportamento degli altri e si regola di conseguenza (quindi reciprocamente) secondo quello che è il contenuto di senso dell'agire di ciascuno. La circolarità del co-orientamento è la caratteristica determinante, per questo si parla di relazione e non più di azione. Questo concetto è fondamentale poiché la nozione di relazione sociale si avvicina molto al concetto di sistema sociale, anche se egli non usa mai la parola sistema.
Luhmann dice - "un sistema sociale è una connessione di senso tra azioni sociali che si riferiscono le une alle altre e si lasciano delimitare da un ambiente di azioni che non appartengono al sistema". Questo marca un confine di senso e di co- orientamento tra sistema e ambiente.
Cosa non funziona nel modello di Weber?
- Tutto quello che è sociale deve passare necessariamente per un soggetto agente? W. differenzia il comportamento dall'azione grazie al senso. Questo significa che per W. alla base della società vi sono dei soggetti agenti che cercano di comprendere il senso delle azioni interpretandole. Ma molti fenomeni sociali oggi prescindono da soggetti agenti (es. borsa, finanza: vedo listini, grafici, andamenti, tutto questo è sociale ma non passa per soggetti agenti; altro es. libro: quando lo leggo partecipo a un'azione sociale anche se non c'è l'autore davanti a me né dentro il libro).
- Come si accede al senso inteso da un altro soggetto? È possibile fraintendere le motivazioni dell'altro. Ad esempio il dono: il dono è in realtà soltanto un segno, qualcosa che rimanda a qualcos'altro che dovrebbe essere la motivazione dell'azione del soggetto agente. Ma quel qualcos'altro è inaccessibile, per questo si deve passare per segni, simboli, testimonianze ecc. che sono quindi la prova che non è possibile accedere al senso inteso dall'altro soggetto. Allora il modello crolla, perché il co-orientamento al comportamento degli altri è inaccessibile.
- Quanto tempo ci vuole a comprendere il senso inteso da un altro soggetto? Secondo W. non c'è un prima o un poi, il tutto avviene contemporaneamente, per questo si parla di co-orientamento. Ma se il senso inteso da un altro soggetto è inaccessibile, ammesso pure che si possa interpretare attraverso dei segni, i tempi per il co-orientamento sarebbero davvero lunghi e la società non sarebbe in grado di assumere un proprio ritmo. La realtà sociale perciò non deve tener conto del senso inteso soggettivamente, ma a prescindere. La società esiste proprio perché i processi sociali possono prescindere dal senso inteso dai soggetti agenti, è solo in questo modo che è possibile procedere in ordine.
2 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-sociologia-generale-cevolini/5399137/ Downloaded by: alessia-saselle (alessiasaselle@gmail.com)
Talcott Parsons
Nell'opera "La struttura dell'azione sociale", P. esprime con estrema chiarezza le sue conclusioni teoriche, prima nell'introduzione del libro e poi alla fine.
La prima distinzione che si incontra è tipica della fisica classica: teoria vs. fatto empirico. Ritenerle come separate è un fraintendimento poiché non c'è fatto empirico che non sia descritto attraverso una teoria di riferimento e non c'è teoria che non si riferisca a fatti empirici.
Cos'è una teoria?
Una teoria è un corpo di concetti generali che si riferiscono a dati empirici e che sono in relazione logica tra di loro. È un po' improprio usare il termine 'corpo', correggibile con 'sistema' (questa correzione la farà P. stesso) costituito da concetti generali, universali e quindi astratti (nella fisica classica vanno sotto il nome di variabili).
Questi concetti generali si riferiscono a dati empirici e si parla quindi di eteroreferenza (referenza alla realtà esterna). Questi concetti sono in relazione logica fra di loro e non ci può essere neanche un concetto di una teoria che sia slegato logicamente dagli altri della medesima teoria. La relazione logica, che deve essere reciproca, fa di questi concetti non solo un insieme ma una teoria. Per questo formano un sistema (dal greco 'ciò che è collegato assieme da una relazione') e non un corpo. Questa relazione logica corrisponde al lato autoreferenziale della teoria.
La conseguenza è che se si fanno osservazioni empiriche che contraddicono i concetti della teoria, o si correggono i concetti o si fa una teoria nuova. Poiché se un concetto cambia, allora cambia anche tutta la teoria, non si può correggerla, bisogna farne una nuova più adeguata ai dati empirici.
Cos'è un fatto empirico?
I concetti generali si riferiscono sempre a fatti empirici. Un fatto empirico è un'affermazione empiricamente verificabile relativa a un fenomeno concreto, formulata entro un dato schema concettuale. Da notare che utilizza il termine 'affermazione' (e non 'evento'), come descrizione di un fenomeno concreto. Il fatto è sì riferito alla realtà esterna, ma è un fattore interno allo schema concettuale.
Viene prima il fatto empirico o la teoria? Né l'uno né l'altro. La teoria deve essere sempre verificata dai dati empirici e tiene finché ha capacità di previsione dei fatti; allo stesso tempo però nessuno può osservare fatti empirici senza avere uno schema concettuale di riferimento. Quello dell'evoluzione teorica è una forma di autosostituzione di una teoria con un'altra, e questo è implicito dal fatto che tra teoria e dato empirico vi è un rapporto reciproco.
La teoria è un sistema di concetti logicamente chiuso, appunto perché i concetti devono sempre stare in una determinata relazione logica tra di loro. Il sistema teorico è aperto sul piano empirico se è chiuso sul piano logico.
La teoria non dà mai le risposte alle domande ma ci dice piuttosto a quali domande si dovrebbe cercare una risposta.
Quali concetti sono necessari per costruire una teoria?
- Schema di riferimento (concettuale o descrittivo) Non si tratta semplicemente di una descrizione o riproduzione della realtà esterna. Lo schema di riferimento è un tentativo di ordinare in modo selettivo i fatti empiricamente verificabili. Esso permette di descrivere la società come sistema d'azione e l'azione come sistema.
- Unità elementare Per spiegare i fenomeni bisogna scomporli. Il processo di scomposizione della realtà in unità elementari (sulle quali si concentrerà l'attenzione) vede l'atto unitario o azione come unità fondamentale, sulla quale poi si potranno produrre affermazioni empiriche che potranno essere generalizzate.
- Elementi analitici Gli elementi analitici sono gli attributi generali, universali, astratti, dei fenomeni concreti, rilevanti entro un dato schema di riferimento (quelli che la fisica classica chiama variabili). ACTOR L'insieme di UNITA CT END CONDITIONS SITUATION MEANS NORMATIVE ORIENTATION sociale". Vi sono relazioni logiche tra gli elementi analitici che permettono di descrivere unità elementari entro uno schema di riferimento. queste relazioni logiche è chiamata struttura. L'unità elementare della teoria sociologica è l'atto unitario, lo scopo è studiarne la struttura. La sociologia è quindi l'analisi della struttura dei sistemi d'azione, da qui il titolo dell'opera "La struttura dell'azione
3 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-sociologia-generale-cevolini/5399137/ Downloaded by: alessia-saselle (alessiasaselle@gmail.com)