Dalle parole ai dizionari: analisi linguistica e lessicografica
Documento dall'Università degli Studi di Milano (unimi) su Dalle parole ai dizionari - Libro di Marcello Aprile. Il Pdf, un documento di Lingue di livello universitario, esplora la storia della lessicografia italiana, presentando i principali dizionari come il Vocabolario della Crusca, il Tommaseo-Bellini e il GDLI, oltre a vocabolari etimologici e glossari.
See more53 Pages
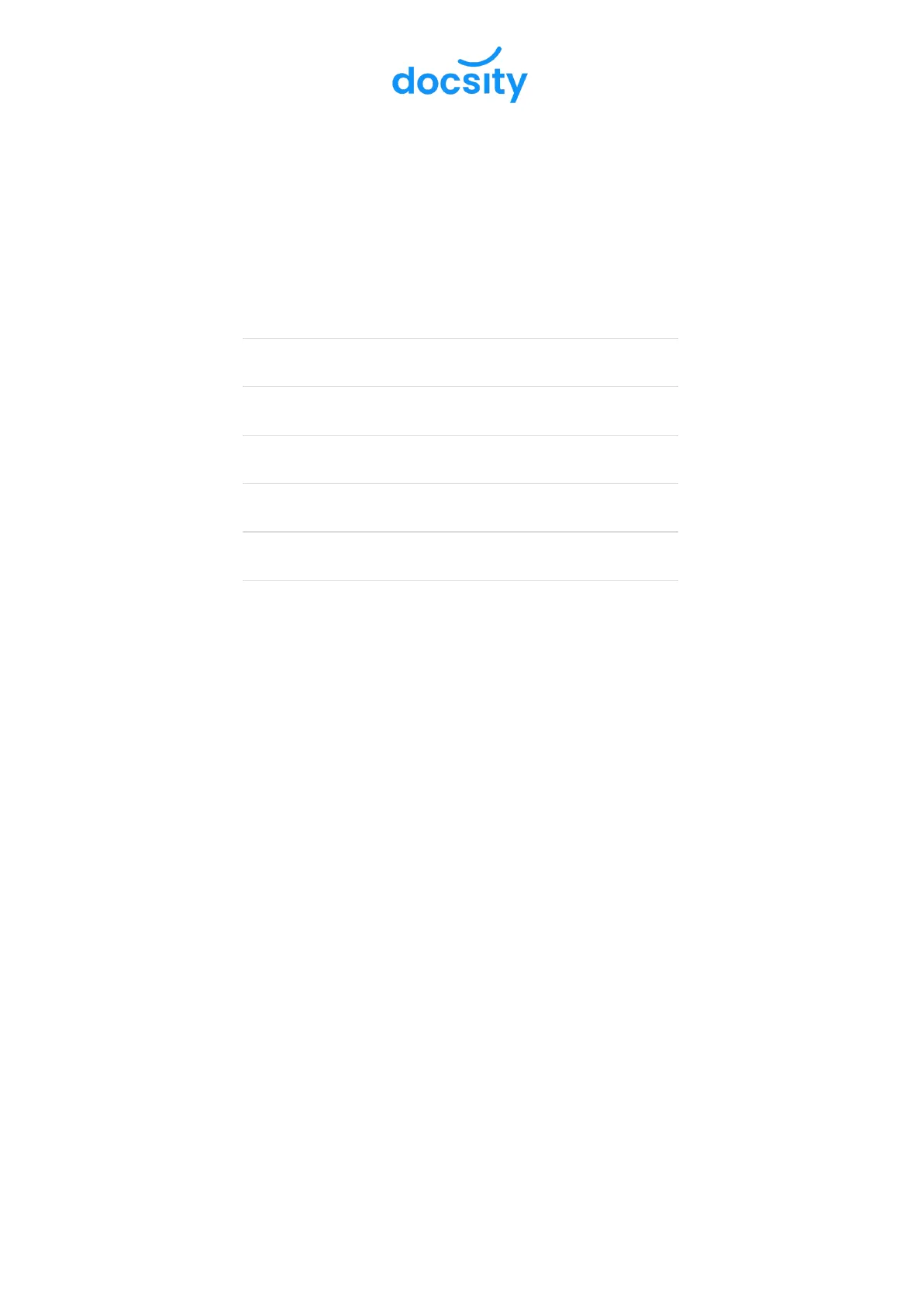

Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
CAPITOLO 1. LE PAROLE
1. Parole. lessemi. varianti
Sono molti gli studi intorno al significato linguistico di parola, ma possiamo in genere attribuirle alcuni caratteri condivisi, ovvero:
- la parola è un'unità minima isolabile all'interno della frase;
- la parola è composta da una sequenza di suoni, in particolare da fonemi (ovvero uno o più suoni che hanno la particolarità di distinguere due parole diverse; b e f sono fonemi diversi in quanto distinguono botte e fotte);
- è dotata di un significato autonomo fondamentale (per le parole semanticamente 'piene' come nomi, aggettivi, verbi ed avverbi) o di una funzione sintattica (parole semanticamente vuote, come articoli, pronomi, congiunzioni e preposizioni).
In relazione al mezzo, vi è una differenza tra parola fonologica, ovvero quella del parlato, che consiste in una sequenza di suoni i cui confini sono determinati da regole riguardanti la struttura delle sillabe, accento e simili, e parola grafica nello scritto, facilmente riconoscibile perché è composta da una sequenza di lettere intervallate da spazi. La parola fonologica è meno riconoscibile. Si ha l'impressione che una parola abbia confini definiti, ma questo non è vero quando parliamo. Il lessico, cioè il patrimonio delle parole, è un insieme complesso, composto da diversi filoni e strati di differente importanza quantitativa e qualitativa. Le unità del lessico non sono indipendenti ma sono disponibili alla formazione di enunciati (le frasi). Per quest'operazione ci si serve di parole semanticamente piene e vuote, utilizzate per la realizzazione di rapporti grammaticali che rendono possibili le frasi, cioè la comunicazione. All'interno di un dizionario, bisogna cercare il lessema (tipo dare) e non le forme flesse. Oltre ai verbi, hanno variante flessionale i pronomi (questo/questa/questi), gli aggettivi (bello/bella/belli/belle).
2. Parole e grammatica
Il numero delle parole è, di base, arricchibile all'infinito, mentre il numero delle regole di grammatica è un insieme ristretto e stabile: il cambiamento di una regola produce a sua volta trasformazioni e riassestamenti in tutto il sistema, quindi è un fatto molto rilevante, talvolta distruttivo; si pensi al graduale passaggio dal sistema delle declinazioni latine alla semplice opposizione singolare/plurale che ha portato alla fine del latino. Il lessico è un insieme aperto, dotato di un notevole dinamismo, ed è più semplice dare giudizi di accettabilità grammaticale che di accettabilità lessicale. Ma lessico e grammatica sono mondi comunicanti, perché quando si realizza una frase le parole vengono adattate secondo un insieme di regole grammaticali. Ci sono alcuni elementi del lessico usati con funzione grammaticale, come ad esempio le locuzioni preposizionali o congiunzionali, cioè insiemi fissi di parole che costituiscono unità autonome con la funzione di una preposizione o di una congiunzione (a causa di, dal momento che): si tratta di elementi grammaticali che si sono lessicalizzati, cioè hanno subito un processo di lessicalizzazione. Viceversa, ci sono elementi che un tempo appartenevano alla sfera della grammatica e poi con l'uso si è trasformato in una vera e propria preposizione (come nel caso di alcuni participi presenti come mediante che vuol dire 'per mezzo di'). In questo caso abbiamo avuto un processo di grammaticalizzazione opposto a quello di lessicalizzazione.
3. Vocabolario comune e vocabolario di base: la disponibilità all'uso
Ciascuna parola possiede una frequenza d'uso o una disponibilità all'uso. Calcolare questa frequenza o disponibilità è un'operazione difficile: da un punto di vista pratico, si può essere certi che una parola si usi più di un'altra solo all'interno di un determinato corpus, ovvero un insieme di testi, orali o scritti, scelti come campione di rilevamento. Se cambia il campione, cambia la frequenza. Più il campione è ampio e più possiamo essere sicuri che ci avviciniamo a un risultato accettabile, per quanto mai privo di incertezze:
per quanto [il corpus] possa essere vasto e vario, potrebbero figurarvi come rare, o non figurarvi affatto, parole ben note alla stragrande maggioranza dei parlanti; e, al contrario, potrebbero figurarvi come piuttosto frequenti parole legate a un'attualità che dopo la costituzione del corpus è nettamente scemata. (Introduzione alla prima edizione Sabatini-Coletti, 1997)
Il problema della frequenza d'uso diventa di primo piano nell'apprendimento dell'italiano come lingua straniera. Qualunque strumento di acquisizione dell'italiano per stranieri o qualunque vocabolario pensato per età è fondato sul principio della frequenza del lessico, che consente di indirizzare e canalizzare il suo apprendimento in modo razionale. Normalmente, nei manuali di apprendimento di una lingua vengono selezionate le parole più frequenti in una quantità variabile; esse consentono la comprensione di gran parte degli enunciati e dei testi. Quel che conta è il principio applicativo che appare incontestabile: per l'apprendimento di una lingua da parte di un bambino o di uno straniero è un sistema migliore partire dalle parole che appaiono più usate. A livello storico, esiste una correlazione tra le parole fondamentali e l'antichità della loro esistenza in vita. Delle circa 4.000 parole che costituiscono lo zoccolo duro dell'italiano, l'87% era giù in uso alla fine del Trecento; un altro 10% viene aggiunto nel XV e XVI secolo. Il Novecento aggiunge solo l'1% circa. La crescita delle parole in italiano è un fenomeno in costante accelerazione che ha portato al loro raddoppio nel corso del XX secolo, accomuna la nostra lingua alle grandi europee di cultura ed è dovuto ad un grande sviluppo del lessico tecnico e scientifico nel corso dell'età moderna; ma non tocca, o quasi, il lessico ad alta disponibilità. È difficile e forse impossibile stabilire a quante parole corrisponda la reale competenza di un adulto, che secondo il Grand Robert (il più importante vocabolario francese contemporaneo) si aggira intorno alle 10.000 - 12.000 parole. La competenza può essere maggiore o anche minore, ma non può essere molto al di sotto di questa soglia almeno per quanto riguarda la competenza passiva, cioè nella capacità di comprensione di parole che poi non vengono effettivamente usate.
4. Il lessico mentale
Conseguenza di quanto detto è che possiamo elaborare il concetto di lessico mentale come insieme delle parole memorizzate da un parlante e la relazione che un parlante stabilisce tra le parole memorizzate. Questa relazione può essere:
- di tipo formale come le rime, le assonanze, le allitterazioni o altri schemi simili;
- di tipo semantico tra sinonimi, antonimi, iperonimi/iponimi
- di tipo insieme formale e semantico come le relazioni che si sviluppano all'interno della formazione di parole.
5. Rapporti paradigmatici e rapporti sintagmatici
All'apertura del dizionario, le parole sono disposte secondo un ordine alfabetico, ma questo ordine non rispecchia l'idea delle strutture del lessico. La correlazione delle parole può essere di diversi tipi. Di primaria importanza sono i legami semantici che collegano tra loro i componenti di una frase, quelli che chiameremo rapporti sintagmatici (se diciamo Carlo premette il pedale dell'- e l'auto partì la nostra competenza linguistica ci permette di integrare, senza difficoltà, la parola omessa, cioè acceleratore). Se invece consideriamo rapporti i rapporti semantici che legano ciascun componente della frase con i suoi possibili sostituti abbiamo i cosiddetti rapporti paradigmatici, con l'alternanza di opposti ed antonimi. Se pensiamo ancora ai rapporti sintagmatici e consideriamo l'espressione il frigorifero pieno, possiamo metterla in relazione con una serie di espressioni come il frigorifero vuoto, frigorifero piccolo ecc., in cui ciascuna possiede un ordine fisso, articolo + nome + aggettivo (chiameremo queste espressioni sintagmi nominali). I sintagmi nominali sono semanticamente accettabili perché il significato associato alle singole parole che costituiscono il sistema linguistico è accettabile. Quindi, le parole si richiamano tra loro secondo modalità prevedibili (libro > giornale, miagolare > gatto); più è ampia l'estensione e meno i contesti sono prevedibili. Le parole di pertinenza grammaticale che sono semanticamente vuote, sono soggette di solito solo a restrizioni grammaticali, non semantico-pragmatiche, nel senso che in un sintagma come il frigorifero spento l'articolo maschile singolare è correlato con il genere e numero di 'frigorifero', ma se lo sostituissimo con l'articolo femminile il sintagma diverrebbe inaccettabile.
CAPITOLO 2. IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE
1. Significante, significato e referente
Il rapporto tra parola e significato può essere osservato da molti punti di vista; questa è, anzitutto, disciplina della semantica, la scienza del significato (sia del lessico che della sintassi). Sulla base delle intuizioni di Ferdinand de Saussure, possiamo distinguere, in una parola, due parti: un'espressione (significante = una forma) e un contenuto (significato). Nella parola tavolo il significante corrisponde all'immagine acustica, cioè all'insieme di suoni composti dalle lettere. Questa serie di suoni arriva a costituire una parola se le si associa una rappresentazione determinata di quello che possiamo chiamare un oggetto mentale (che può corrispondere anche ad un'estrazione), e quindi l'immagine del mobile. Ai due elementi si aggiunge poi un elemento extralinguistico: la realtà, che è situata al di fuori del linguaggio. Il significante evoca solo una rappresentazione schematica della cosa (nel caso di tavolo, la categoria di un mobile con quattro gambe ecc). Il rapporto tra il significante e il referente (l'elemento non linguistico, cioè il tavolo reale) è mediato dal significato (il concetto del tavolo).
2. Convenzionalità, immotivazione, rimotivazione secondaria
Se nelle diverse lingue uno stesso oggetto mentale viene designato con immagini acustiche diverse, ne consegue che non esiste alcuna relazione di necessità, alcun rapporto tra significante e significato: non esiste necessità che l'oggetto con quattro gambe e una superficie si chiami tavolo. In sostanza, la parola che i parlanti scelgono per designare un oggetto mentale è frutto di una scelta 'arbitraria' ( secondo la terminologia di De Sausurre) o meglio ancora 'convenzionale', come dice Ullman. La controprova è data dal fatto che si usa la stessa successione di suoni per oggetti mentali che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, come capita nelle diverse lingue. Anche se siamo portati a credere il contrario, non c'è quindi nessun rapporto di identità tra l'oggetto e la parola con cui lo designiamo. Noi tendiamo invece a identificare istintivamente la parola con la cosa. L'aneddotica è ricchissima.