La catalogazione descrittiva e semantica: funzioni, norme e strumenti di lavoro
Slide sulla catalogazione descrittiva e semantica: funzioni, norme e strumenti di lavoro. Il Pdf approfondisce lo scopo della catalogazione semantica e le funzioni dell'indice per il recupero e la navigazione delle informazioni, utile per studenti universitari.
See more57 Pages

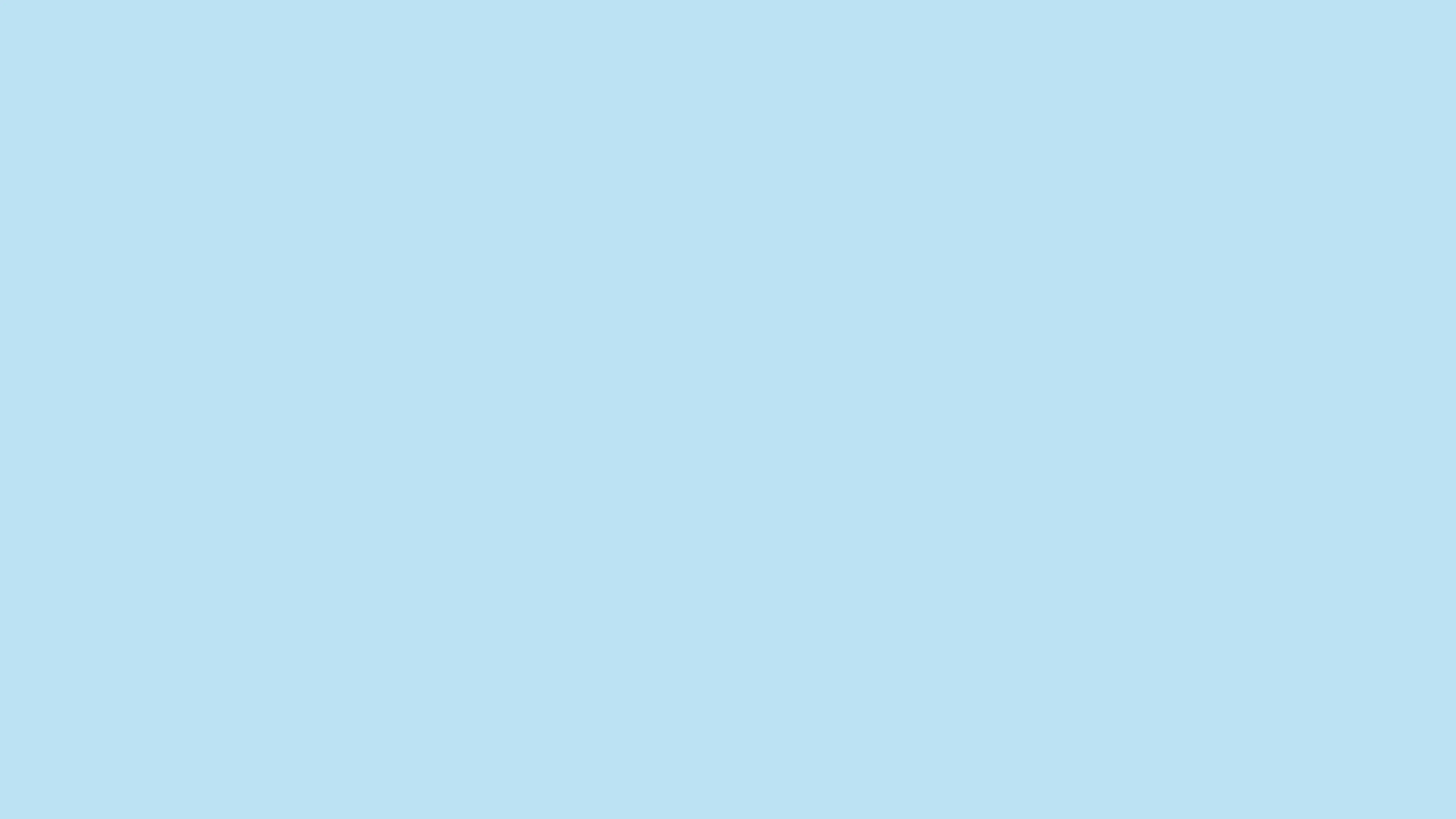
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
La catalogazione descrittiva e la catalogazione semantica: funzioni, norme, strumenti di lavoro
Antonella Trombone
Due aspetti, e due fasi, della stessa attività
Catalogazione
La catalogazione è un'attività biblioteconomica che consiste nel realizzare un catalogo che svolga un servizio specifico per una biblioteca, o per una rete di biblioteche che lavo- rano in cooperazione: informare gli utenti sulle collezioni, ovvero sulle raccolte possedute o accessibili tramite ciascuna istituzione bibliotecaria, nonché sulla loro fruizione, cioè la consultazione e il prestito del patrimonio bibliografico. Si basa su una solida teoria e su norme che il catalogatore deve conoscere, saper interpretare e applicare, regole comuni che indicano come operare e che permettono di risolvere gli stessi casi catalografici nel medesimo modo. L'uniformità è un requisito ancor più indispensabile per la catalogazione nei cataloghi col- lettivi, che con l'automazione delle biblioteche si sono diffusi enormemente, per i quali è particolarmente necessario che le informazioni siano presentate in modo conforme e nel rispetto di norme e modelli condivisi. Il catalogo realizza un servizio e costituisce un'unità informativa della biblioteca.
Attività professionale complessa
Alla base della catalogazione vi deve sempre essere l'interpretazione e la valutazione dell'oggetto catalografico nel suo insieme, basata sulle sue caratteristiche formali, sugli elementi necessari per descriverlo, sul suo contenuto. Tale attività viene svolta seguendo principi e regole e richiede, perciò, una solida preparazione professionale, oltre che una altrettanto valida cultura generale. Dagli anni Novanta del Novecento le biblioteche hanno posto, giustamente, grande impe- gno nell'informatizzazione e anche nelle tematiche legate alla cooperazione nella gestio- ne e nei servizi, spesso sottraendo attenzione e forza lavoro alla catalogazione. Gli erro- ri evidenti nei grandi cataloghi collettivi, gli inutili sdoppiamenti delle intestazioni e delle schede catalografiche, per non menzionare gli errori ortografici, derivano, in molti casi, dall'aver ritenuto che la catalogazione sia un'attività meccanica, esecutiva, che si possa basare solo sulla mera cattura o sulla duplicazione di registrazioni catalografiche, senza che venga valutata in modo professionale la loro correttezza, o la loro corrispondenza con la pubblicazione che si sta catalogando.
Importanza della catalogazione
Malgrado la qualità a volte modesta della catalogazione, il catalogo elettronico può arriva- re, comunque, a rispondere alle domande degli utenti, ma ciò avviene al prezzo di lunghe e spesso complicate ricerche, che di certo non risparmiano il tempo del pubblico delle bi- blioteche. In casi come questi, quel che rimane grave è che il principale strumento infor- mativo sulla collezione di una biblioteca, o di una rete di biblioteche, restituisca al pubbli- co l'impressione di imprecisione nei contenuti e di inaffidabilità nelle risposte. Premesso, quindi, che i cataloghi servono a fornire un servizio fondamentale agli utenti delle biblioteche, è necessario che quanti studiano o approfondiscono le discipline biblio- grafiche e biblioteconomiche, a qualsiasi livello, dispongano di un quadro completo delle norme, dei codici e dei modelli che vengono adottati nel lavoro di catalogazione.
Catalogazione descrittiva
Il catalogo online, al quale oggi il pubblico delle biblioteche è avvezzo, ha una struttura unitaria che racchiude al proprio interno più categorie di informazioni, che nei cataloghi in forma cartacea venivano suddivise in più schedari. Questi ultimi, di norma, corrispondevano al catalogo per autori e titoli, a quello per soggetto, al catalogo classificato e al catalogo to- pografico. Tali differenti tipologie di informazioni soddisfano diverse categorie di ricerche e di punti d'accesso, che il catalogo di biblioteca ammette e rivolge ai propri utenti. Sono espresse all'interno di ciascuna notizia catalografica, oppure a essa collegate, e possono essere così suddivise:
- gli elementi descrittivi di ciascuna pubblicazione, a stampa e non, posseduta da una biblioteca, che permettono di identificarla in modo univoco; ma anche di accomunarla a pubblicazioni che hanno caratteristiche simili, oppure di distinguerla da esse;
- gli elementi descrittivi di ciascun autore rappresentato nel catalogo, che permettono di identificarlo in modo univoco; ma anche di mostrare agli utenti tutte le opere e le pub- blicazioni riconducibili a quello stesso autore, possedute da una biblioteca;
- le informazioni relative in modo specifico all'esemplare, cioè alla copia di una pubblica- zione posseduta e collocata in una biblioteca;
Catalogazione semantica
- gli elementi semantici che permettono la ricerca di opere su un determinato argomen- to, basati sull'uso di espressioni del linguaggio naturale, che esprimono il contenuto con- cettuale del documento descritto;
- gli elementi semantici che permettono la ricerca di opere su una determinata materia, basati su un sistema di simboli convenzionali, che esprimono il contenuto concettuale del documento descritto indicandone l'appartenenza a una determinata classe, in base a un sistema di classificazione.
Descrizione, soggettazione e classificazione
Nella teoria e nella prassi della catalogazione è comune distinguere:
- la fase della descrizione (definita catalogazione descrittiva), che individua ed espri- me catalograficamente le prime tre tipologie di informazioni sopra elencate;
- la fase della soggettazione e della classificazione (definita catalogazione seman- tica), che individua ed esprime catalograficamente le due categorie di elementi se- mantici sopra citati.
In realtà, la catalogazione descrittiva e la catalogazione semantica sono due diversi aspetti della medesima attività, tra loro strettamente connessi, che vengono svolti dai ca- talogatori seguendo un unico flusso di lavoro. È impensabile, infatti, avviare un'attività catalografica senza aver prima effettuato un'ana- lisi del documento nel suo complesso, che inquadri una pubblicazione individuando, al suo interno, tutti gli elementi (tipologici, linguistici, descrittivi, l'organizzazione dei contenuti, il paratesto, le caratteristiche dell'esemplare posseduto dalla biblioteca) utili per un'analisi compiuta che permetta sia la catalogazione descrittiva sia quella semantica, qualunque sia la natura dell'oggetto catalografico da rappresentare nel catalogo.
La catalogazione descrittiva
Registrazione catalografica
La descrizione costituisce la base della notizia catalografica. Si tratta di un processo di registrazione catalografica che permette di individuare nel catalogo una pubblicazio- ne, cioè un prodotto editoriale che consiste in un insieme di copie identiche, prodotte da un'unica matrice, o da una sua copia o derivazione, e destinate alla diffusione. L'oggetto della descrizione può anche non essere una pubblicazione indipendente, ma una sua par- te: un capitolo di un libro, l'articolo di un periodico, un saggio contenuto in un volume mi- scellaneo. La descrizione può anche riguardare un oggetto unico, come un manoscritto o un disegno, oppure un documento reperibile in rete, anche prodotto su richiesta. Ogni tipologia di documento può essere oggetto di descrizione. Quel che è importante stabilire è che la catalogazione descrittiva non descrive la singola copia, ma, proprio come le bibliografie e le citazioni bibliografiche, fornisce i dati identifi- cativi comuni a tutte le copie, cioè descrive la pubblicazione a cui la copia posseduta ap- partiene.
Descrizione bibliografica
Nella definizione di catalogazione descrittiva è compresa la fase della descrizione bi- bliografica di una pubblicazione, ovvero della presentazione ordinata dei dati che de- scrivono la pubblicazione stessa. Queste informazioni sono oggettive, perché presenti sul documento che si cataloga, o ad esso direttamente collegate; perciò, permettono di iden- tificare in modo univoco una pubblicazione posseduta da una biblioteca e descritta nel suo catalogo. Permettono poi di distinguerla dalle altre edizioni della stessa opera, come anche da altre pubblicazioni simili. Nei codici di catalogazione, le norme per la descrizione catalografica sono state trattate di solito insieme alla normativa per la formulazione delle intestazioni, che è finalizzata al recupero e all'indicizzazione delle notizie catalografiche, anche se i due concetti vanno ben distinti.
Formulazione delle intestazioni
Mentre la descrizione bibliografica presenta gli elementi descrittivi (per esempio i nomi degli autori, i titoli) in modo inalterato, cioè così come si trova espresso nella pubblica- zione, al contrario, la formulazione delle intestazioni prevede un processo di formaliz- zazione della forma dei nomi degli autori che, a vario livello, hanno un rapporto di respon- sabilità con il documento che si sta descrivendo. Per fare un esempio, se nella descrizione bibliografica il prenome di un autore precede il cognome, così come si trova indicato sul frontespizio di un libro, invece per la formulazione di un'intestazione occorre riportare il nome in forma normalizzata, operando l'inversione: cognome-nome. Nel catalogo cartaceo le intestazioni delle notizie catalografiche rappresentavano an- che gli unici punti d'accesso alle schede catalografiche. Tale prospettiva è stata comple- tamente ribaltata nei cataloghi elettronici, nei quali la ricerca viene effettuata in modo simultaneo in tutti i campi della descrizione bibliografica, comprese le intestazioni. Poten- zialmente, perciò, ogni elemento inserito in un campo catalografico svolge la funzione di punto d'accesso al catalogo.
Registrazioni d'autorità
Rientrano nelle attività della catalogazione descrittiva anche le registrazioni di autorità. Il nome di una persona o di un ente che ha una relazione di responsabilità, a vario livello, con una notizia catalografica, costituisce un elemento di accesso controllato e normaliz- zato, definito voce di autorità. Tutte le forme varianti di una voce d'autorità presenti nel catalogo vengono messe in relazione tra loro, oltre che con la voce d'autorità stessa. A questa unica forma del nome sono collegate tutte le opere di un autore, a prescindere dal fatto che in una specifica opera il suo nome abbia una forma diversa, per esempio sia tradotto in un'altra lingua. Tale controllo avviene anche per individuare il titolo uniforme di un'opera, che nelle varie tipologie di pubblicazioni può essere indicato con titoli diversi, tradotti, o in forme diffe- renti. Anche il titolo uniforme dell'opera nel catalogo costituisce un elemento di accesso controllato.