Strategie didattiche: organizzazione, valutazione e istruzione
Documento sulle Strategie Didattiche di A. Calvani. Il Pdf esplora le strategie didattiche, suddividendole in organizzazione, valutazione e istruzione, analizzando approcci come quello basato sugli obiettivi e il "progetto aperto" per l'università.
See more14 Pages

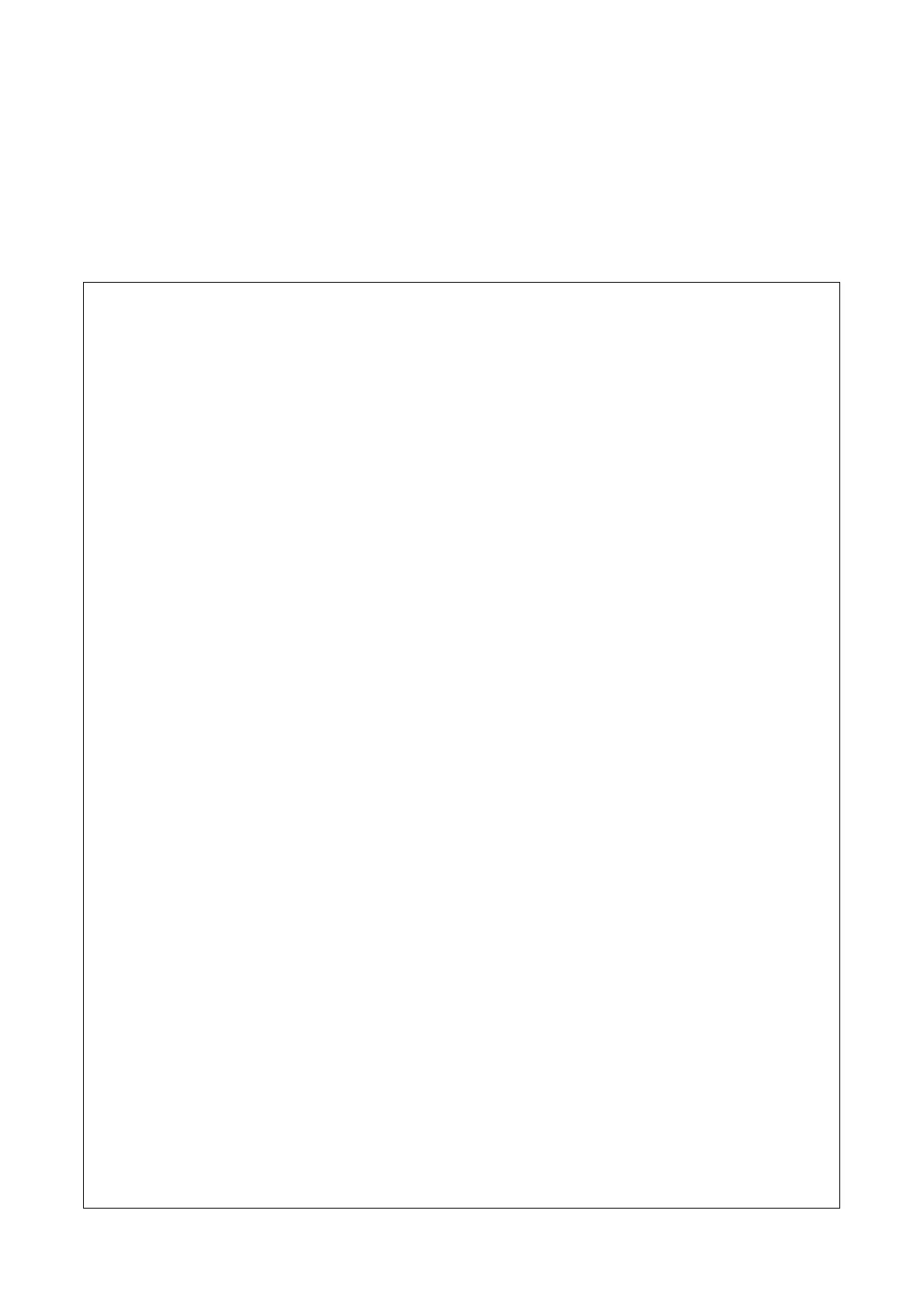
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Strategie Didattiche e Ambienti di Apprendimento
La didattica si preoccupa essenzialmente di prospettare, allestire, gestire "ambienti di apprendimento1" vale a dire particolari contesti che vengono corredati di specifici dispositivi2 ritenuti atti a favorire processi acquisitivi.
Di cosa si avvale nella sua attività di allestimento e nei suoi successivi interventi? Esistono regole, indicazioni, suggerimenti nell'attività di progettazione e preorganizzazione di tali ambienti? E si riescono ad individuare elementi che caratterizzano un'azione "competente" da una di segno diverso?
Dobbiamo subito dire che non esistono criteri e soluzioni univoche e che ci inoltriamo qui in un ambito in cui anche il linguaggio diventa necessariamente più impreciso. Ciò di cui essenzialmente si avvale la competenza didattica è di un bagaglio eterogeneo di orientamenti, modi di porsi, strumenti concettuali, a cui si correlano più specifiche procedure, formati o strategie d'intervento, che si son messi in luce attraverso molteplici esperienze, variamente documentate soprattutto negli ultimi cinquant'anni: tuttociò assume la forma di un complesso armamentario teorico a cui è opportuno sapersi richiamare, anche se nella pratica occorreranno mediazioni ed adattamenti continui.
Possiamo avvalerci del seguente schema che individua tre ambiti fondamentali all'interno dei quali possiamo collocare l'insieme eterogeneo degli apparati principali (formati e strategie)3 proposti dalla riflessione didattica:
organizzazione (progettazione) valutazione istruzione
(organizing strategies) (assessing strategies) (instructing strategies)
L'ambito che chiamiamo dell'organizzazione riguarda il lavoro preliminare all'utilizzo didattico, le attività di pianificazione ed allestimento dell'ambiente didattico stesso, tipiche della progettazione didattica (Instructional Design).
L'ambito di "valutazione" riguarda i criteri che si assumono sia in itinere, sia a livello terminale per valutare il processo/prodotto; assumono almeno due valenze distinte, quella del controllo di funzionalità del sistema didattico concernente anche decisioni "politiche" sul cambiamento d'indirizzo, quella della gestione relazionale interna come il mantenimento di un clima adeguato, conduzione adeguata dei rapporti.
L'ambito dell'istruzione include le forme più note di organizzazione dello svolgimento didattico (quali la lezione, l'organizzazione di gruppo ecc.); esse si presentano con un set di formati riconoscibili a cui si potrà fare ricorso a seconda dei casi. A quelli, per così dire "classici", basati 1 Un ambiente di apprendimento può essere così visto come una risultante dell'integrazione di diverse componenti culturali e tecniche, variamente integrate ed adattate. Usiamo qui un'espressione generale che può includere varie tipologie specifiche, ad esempio sistemi di istruzione programmata, curricoli o loro sezioni (una lezione, un'unità didattica ecc.), corsi ed apparati per la formazione, ambienti di apprendimento nell'accezione strettamenente costruttivistica (articolazione su cui si soffermiamo qui di seguito). 2 Con il termine dispositivo non ci riferiamo solo a strumentazioni fisiche ma anche ad apparati invisibili (interventi sul piano istruttivo, normativo, relazionale, del clima emotivo). Una strategia didattica, una griglia di lavoro, un dossier di autovalutazione, al pari di una interfaccia software sono ugualmente dispositivi, cioè componenti che possono essere variamente collocate nell'ambiente allo scopo di orientare le dinamiche acquisitive in un senso o in un altro. 3 Intendiamo con il termine formato una sequenza di azioni algoritmicamente prestabilite. Il termine strategia lascia invece intendere che in ogni singolo momento decisionale si mantengano anche dei gradi di libertà, anche se tra i due termini le differenziazioni diventano spesso difficili: una "lezione" è un "formato" o una "strategia"? Assume il carattere di un "formato" nel senso che essa si presenta come una sorta di canovaccio precostituito su come l'insegnante deve comportarsi; assume però anche il carattere di strategia perchè istante per istante l'insegnante può decidere iniziative peculiari, con un certo grado di autonomia.essenzialmente sull'insegnante, si è aggiunta più recentemente una gamma di suggerimenti, centrati sull'alunno, concernenti il saper leggere e studiare con la consapevolezza metacognitiva che si dovrebbe accompagnare a queste attività, che genericamente possiamo chiamare "strategie di studio".
Questi ambiti sono qui oggetto di alcune osservazioni più analitiche.
Formati e Strategie di Organizzazione e Progettazione
Atteggiamento centrato su obiettivi e unità didattiche
Ha un taglio oggettivista e razionalista: si assume che le conoscenze e le competenze da acquisire siano delimitabili, rappresentabili, riducibili in parti più semplici.
Il percorso didattico è derivato in primo luogo dagli obiettivi, strutturato secondo un approccio top- down: ha carattere sistematico e sequenziale.
Si parte da una task analysis; si analizzano le capacità necessarie alla competenza richiesta, le capacità si scompongono in sottocapacità e così via.
L'apprendimento si svolge generalmente in forma astratta, decontestualizzata.
La valutazione si avvale di un frequente uso di test in ingresso, in itinere, alla fine.
Ci si può avvalere di tecnologie più specifiche come l'istruzione programmata, tutoriali, C.A.I, I.C.A.I., mastery learning.
Si intende principalmente salvaguardare il principio dell'uguaglianza: portare tutti alla stessa meta con tragitti individualizzati.
Atteggiamento centrato sul progetto aperto
La pedagogia per progetti nasce negli anni '20. Decade negli anni '60. Torna in auge negli anni '80- '90.
Il percorso non è né predefinito né lineare, ha natura partecipata e flessibile.
Gli obiettivi si sviluppano sulla base dei bisogni emergenti nel contesto didattico
Si valorizza principalmente:
- l'autonomia progettuale
- le strategie metacognitive
- l'apprendere in contesto
- la costruzione negoziata del significato
- la ricorsività poliprospettica
- la cooperazione/distribuzione/alternanza di ruoli
La valutazione si allontana dal concetto di misurazione "obiettiva" a favore di forme di autovalutazione (dossier, portfolio), di valutazione "situata", di valutazione "intersoggettiva" (triangolazione, pluralità di osservatori).
Ci si può avvalere di tecnologie quali gli ipertesti e gli ambienti di comunicazione e cooperazione di rete. Si tende alla condivisione-distribuzione delle risorse (sharing).Si intende principalmente salvaguardare il principio della diversità: valorizzare stili ed esigenze individuali. Si dà risalto a possibili forme di personalizzazione dell'apprendimento.
Formati e Strategie della Valutazione
La nostra attività cognitiva si caratterizza per una continua attività di ponderazione; valutiamo costantemente, nel senso almeno che selezioniamo e diamo risalto ad alcuni aspetti rispetto ad altri creando dal loro intreccio continue configurazioni di senso; valutare è dunque un'attività intrinseca all'attività della mente.
Ciò che indichiamo con il termine generico "valutazione" si può collocare in un continuum che vede ad un estremo forme di "misurazione" vera e propria, all'altro forme di "interpretazione", nell'area centrale possiamo collocare forme di valutazione contrasegnabili con il termine di "stime".
Quante tipologie concrete di valutazione impiegabili a scopo didattico possiamo distinguere? L'attività valutativa, per la sua intrinseca complessità, assume una varietà di sfaccettature che la rendono difficilmente classificabile. Tradizionalmente quando si parla di valutazione ci si riferisce a particolari operazioni che concernono il profitto degli allievi. Accanto alla valutazione del profitto si sono affermate, in particolare negli ultimi venti anni, altre dimensioni della valutazione.
Sempre più la valutazione è considerata parte integrante, fondamentale dell'attività formativa. Le diverse modalità della valutazione si possono variamente suddividere ed articolare; per comodità possiamo distinguere quattro tipologie principali:
- Valutazione del profitto (degli apprendimenti)
- Valutazione del processo (come monitoraggio o presa di decisione in corso di attività)
- Valutazione di progetto
- Valutazione di sistema
Con "valutazione del profitto" intendiamo tutte le operazioni compiute tradizionalmente da un docente o responsabile della formazione nei riguardi delle attività degli allievi. Con l'espressione "valutazione del processo, ci riferiamo a quelle complesse attività in cui la raccolta di elementi informativi può essere riutilizzata per rettificare le decisioni in corso secondo modalità più o meno capaci di adattamento o autoregolazione.
Con la terza possibilità ci riferiamo alla valutazione di progetti o di altro materiale educativo (ambiente di apprendimento, courseware, software o altro) presentato sotto forma di ipotesi normalmente in fase preliminare.
Con il termine "valutazione di sistema" ci riferiamo a quelle operazioni che permettono di formulare una valutazione complessiva sul funzionamento di un sistema formativo (corso, innovazione ecc.).
Formati e Strategie dell'Istruzione
Ci riferiamo adesso ai formati/ strategie didattiche, cioè alle sequenze di interventi "istruttivi" che normalmente mette in atto l'educatore nell' interazione con l'allievo nell'intento di facilitare l'apprendimento.
Pensiamo ad una situazione "didattica" tipica: da un lato ci saranno uno o più educatori, dall'altro degli allievi, intorno una varietà di possibili di supporti sia tecnici come libri, supporti multimediali, telematici, sia umanicome tutor, compagni esperti.
Più analiticamente possiamo schematizzare la situazione nel modo seguente (fig. 1):Risorse del contesto: a) tecniche: libri, supporti multimediali, telematici) b) umane: tutor. comnagni esperti. Educatore Allievo Percezione Strutturazione cognitiva Comunicazione: orale scritta extra verbale area di negoziazione output, note, reazioni Attenzione Preconoscenze Memoria a lungo termine Imitazione consegne di lavoro definzione di obiettivi ecc. Memoria a breve termine Fig. 1
La fig. 1 mostra le tre componenti fondamentali che entrano in gioco in una situazione didattica tipica: educatore, allievo, supporti esterni. L'educatore "umano" ma in taluni casi anche artificiale, fornisce informazioni in forma verbale o non verbale4, definisce o aiuta a definire obiettivi e consegne di lavoro, presenta eventuali comportamenti auspicabili. Da parte dell'allievo intervengono funzioni cognitive più superficiali quali percezione, attenzione, memoria a breve termine, in eventuale integrazione con funzioni più profonde come attivazione di preconoscenze ed impiego della memoria semantica all'interno di eventuali comportamenti di imitazione (modellamento) e di strutturazione cognitiva. Al rapporto tra educatore ed allievo può aggiungersi un terzo elemento, un insieme di supporti contestuali di altro tipo (sia tecnologici che umani). In alcuni casi questo ulteriore elemento può assumere un ruolo decisivo: perde allora rilevanza il ruolo dell'educatore a favore di un impalcatura di risorse che può mettere in condizione di sviluppare maggiore autonomia nel discente.
Le strategie e formati possibili d'intervento possono più o meno far leva sul ruolo attivo del docente, del discente, su altri sostegni esterni quali tutor, compagni, libri, supporti tecnologici. Entrano in gioco due dimensioni, una più propriamente comunicativa3, un'altra costruttiva6.
4 Prescindiamo qui dal fatto che il ruolo dell'educatore può sensibilmente variare da quello di "trasmettitore di informazioni" a quello di "facilitatore dell'apprendimento". 5 Negli studi sulla comunicazione fino agli anni '60 ha prevalso una sostanziale identificazione della comunicazione umana con il messaggio verbale. La situazione si modifica a partire dagli anni '60 in particolare in virtù di approcci teorici nuovi, quali quelli della scuola di Palo Alto secondo cui in ogni comunicazione c'è una trasmissione di contenuto ed una trasmissione metacomunicativa; da allora si diffonde anche l'attenzione alla comunicazione attraverso i silenzi, la corporeità; nuovi rapporti con l'ermeneutica ampliano poi più recentemente la panoramica delle dimensioni comunicative. Come gestire il rapporto comunicativo e relazionale in classe è un aspetto studiato nel contesto italiano da Lucia Lumbelli.