Digital Humanities: metodi, strumenti e saperi, Università degli Studi di Milano
Documento dall'Università degli Studi di Milano su Digital Humanities: metodi, strumenti, saperi. Il Pdf esplora l'intersezione tra discipline umanistiche e tecnologie digitali, analizzando sfide e opportunità della storia digitale, inclusa l'interazione con i Social Network, per studenti universitari di Storia.
Ver más26 páginas
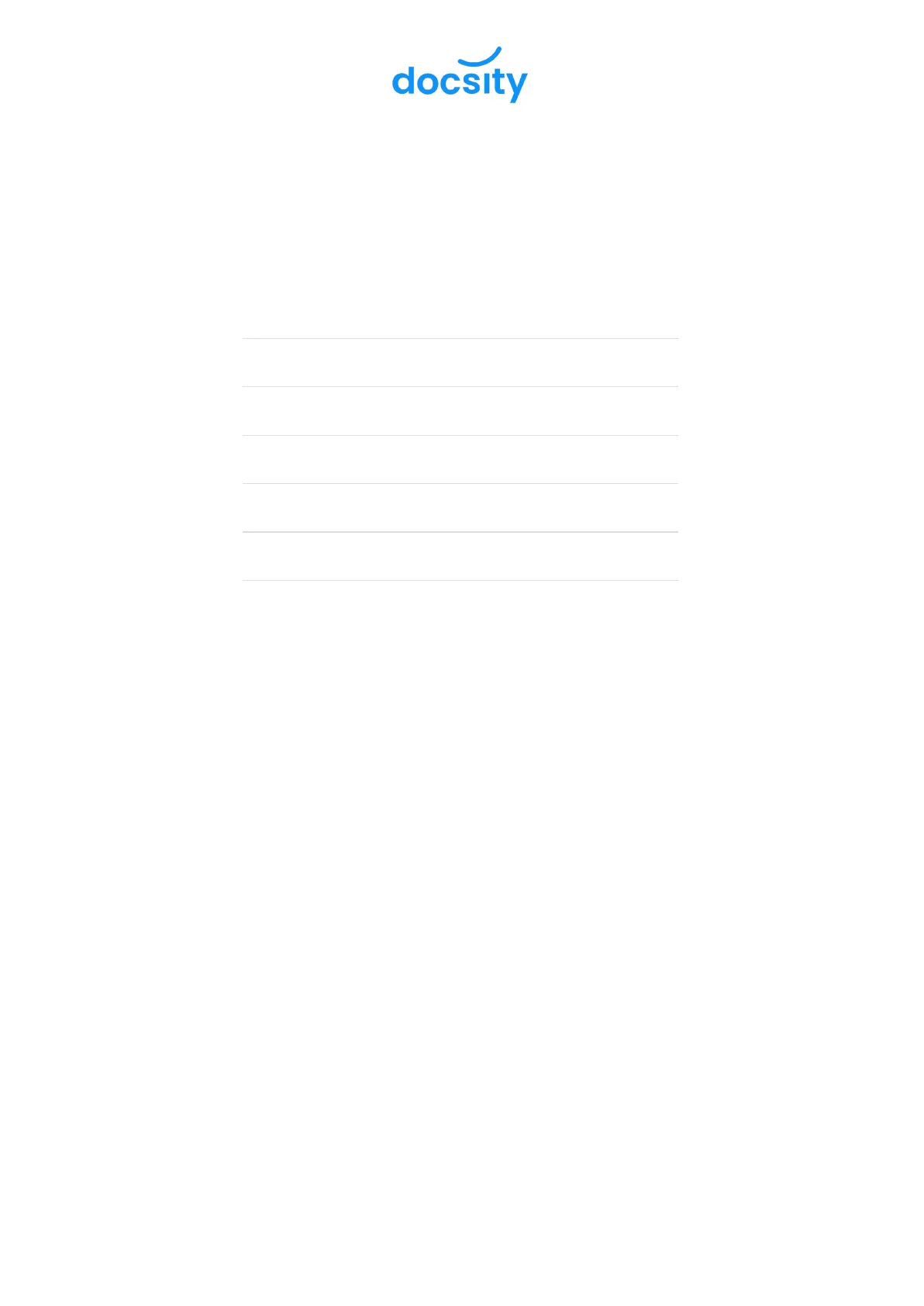
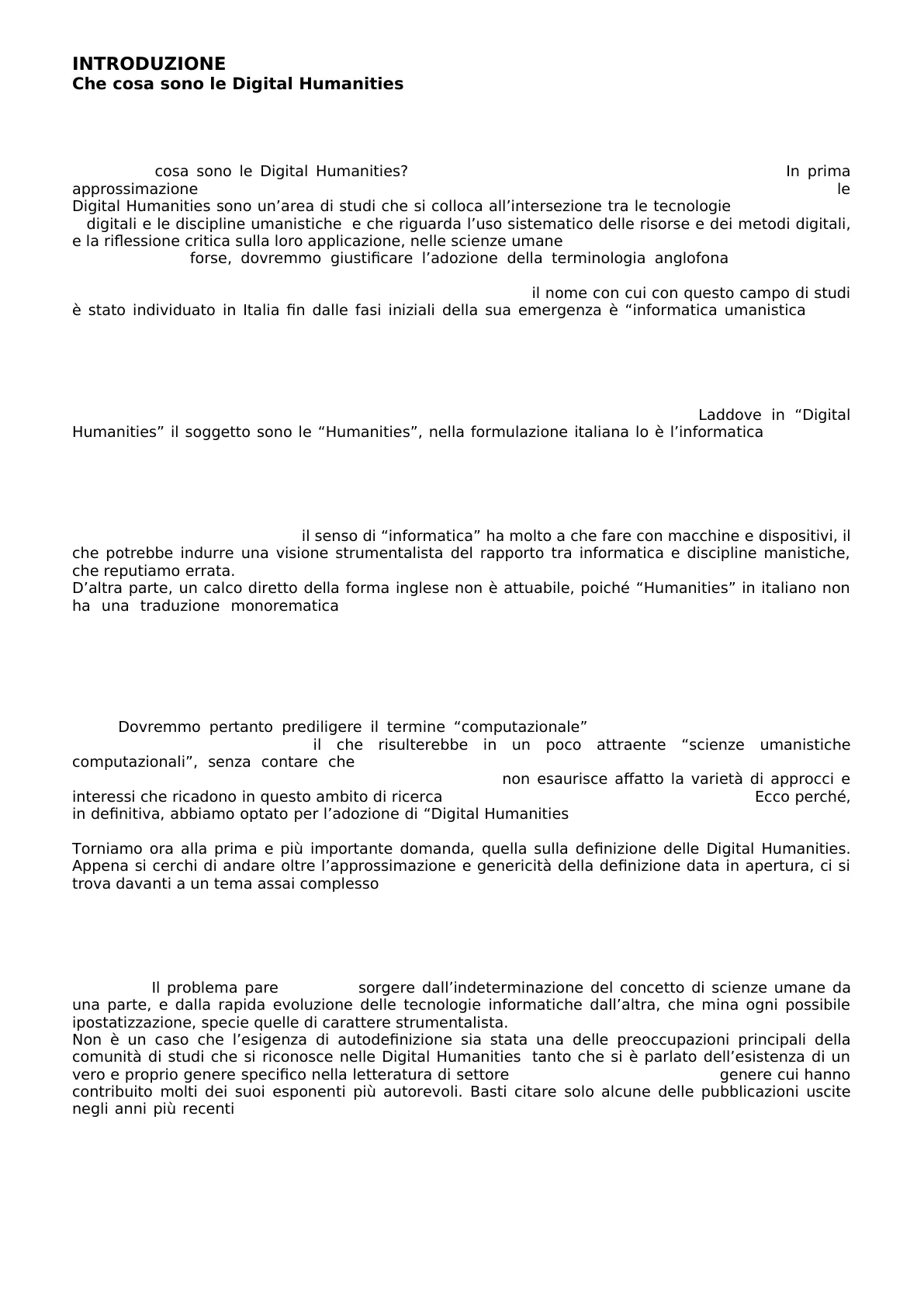
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
INTRODUZIONE - LA GALASSIA DELLE DIGITAL HUMANITIES DI FABIO CIOTTI.
Che cosa sono le Digital Humanities.
Un libro che ambisca a rappresentare lo stato dell'arte di un campo di studi relativamente nuovo e in forte espansione, peraltro dando voce ad autori e prospettive molteplici e diverse, dovrebbe in primo luogo fornire una definizione di tale campo, in modo da stabilirne i confini e delinearne i fondamenti. Dovremmo, dunque, in questa sede iniziare provando a fornire una risposta chiara e condivisa alla domanda: cosa sono le Digital Humanities? Pochi temi sono così dibattuti, come vedremo. In prima approssimazione - adattando la definizione della relativa voce su Wikipedia - possiamo dire che le Digital Humanities sono un'area di studi che si colloca all'intersezione tra le tecnologie computazionali o digitali e le discipline umanistiche, e che riguarda l'uso sistematico delle risorse e dei metodi digitali, e la riflessione critica sulla loro applicazione, nelle scienze umane.
Ancora prima, forse, dovremmo giustificare l'adozione della terminologia anglofona: non esiste un termine o un'espressione italiana che sia adeguata a denominare questo campo di studi e ci possa evitare di cedere al facile richiamo dell'anglicismo? In effetti il nome con cui con questo campo di studi è stato individuato in Italia fin dalle fasi iniziali della sua emergenza è "informatica umanistica" e in questo volume troviamo più volte attestata questa formula, a partire dalla Prefazione di Dino Buzzetti e dal CAP. 1 di taglio storico di Tito Orlandi e Francesca Tomasi. D'altra parte, anche in ambito anglosassone per lunghi decenni è stata prevalente la forma "Humanities Computing" che, specificità grammaticali a parte', è molto simile a quella italiana.
Il fatto è che il sintagma "Digital Humanities" non è coestensivo con la forma italiana- e nemmeno con quella inglese precedente-come si nota dall'inversione del ruolo sostantivale. Laddove in "Digital Humanities" il soggetto sono le "Humanities", nella formulazione italiana lo è l'informatica. Il che non sarebbe male, se prendessimo sul serio l'accezione del termine "informatica" che deriva alla sua etimologia attestata: la contrazione tra "informazione" e "automatica", ovvero studio dei processi di elaborazione automatica dell'informazione, che rende centrale il concetto di informazione ed elaborazione della stessa, e periferico quello delle macchine fisiche (e del modo in cui sono costruite) con cui ciò si può fare. Ma la storia delle parole prende spesso strade che allontanano il loro valore semantico dalle origini. E oggi il senso di "informatica" ha molto a che fare con macchine e dispositivi, il che potrebbe indurre una visione strumentalista del rapporto tra informatica e discipline manistiche, che reputiamo errata.
D'altra parte, un calco diretto della forma inglese non è attuabile, poiché "Humanities" in italiano non ha una traduzione monorematica ("umanistica" come forma sostantivale, infatti, sebbene abbia sporadiche attestazioni non è ad bora accolta da nessun dizionario) e dovremmo ricorrere, dunque, a sintagmi composti, come "scienze umane" o "discipline umanistiche": il risultato finale sarebbe di sicuro prolisso e poco efficace. Ci sarebbe peraltro da osservare come "digitale" (da "digit" che in inglese vuol dire "cifra") si riferisca alla sfera delle modalità di rappresentazione numerica (e binaria) dell'informazione, che è fatto contingente, poiché come noto l'applicabilità dei processi di elaborazione automatica della stessa è invariante rispetto all'insieme dei simboli usati, purché questi siano discreti e finiti. Dovremmo pertanto prediligere il termine "computazionale" (cosa che in effetti è di recente invalsa in alcuni contesti); che risulterebbe in un poco attraente "scienze umanistiche computazionali", senza contare che questa tendenza è legata al recente interesse per i metodi quantitativi e le nuove tecniche di analisi dei dati, che non esaurisce affatto la varietà di approcci e interessi che ricadono in questo ambito di ricerca, come testimonia questo stesso volume. Ecco perché, in definitiva, abbiamo optato per l'adozione di "Digital Humanities", e del relativo acronimo "DH", per il nome della cosa.
Torniamo ora alla prima e più importante domanda, quella sulla definizione delle Digital Humanities. Appena si cerchi di andare oltre l'approssimazione e genericità della definizione data in apertura, ci si trova davanti a un tema assai complesso, affrontato ripetutamente nel corso dei decenni e mai giunto a una sistemazione definitiva. Questa difficoltà non è legata solo al fatto che il nostro campo si pone, come detto, all'intersezione di aree del sapere tradizionalmente considerate distanti, se non antitetiche, quelle delle scienze umane e quelle dell'informatica. In fondo oggi l'informatica è talmente pervasiva che investe e informa ogni aspetto della vita sociale e culturale; e d'altra parte l'esistenza di ambiti di ricerca scientifica caratterizzati da forti livelli di inter e multidisciplinarità è ormai un fatto consueto. Il problema pare piuttosto sorgere dall'indeterminazione del concetto di scienze umane da una parte, e dalla rapida evoluzione delle tecnologie informatiche dall'altra, che mina ogni possibile ipostatizzazione, specie quelle di carattere strumentalista.
Non è un caso che l'esigenza di autodefinizione sia stata una delle preoccupazioni principali della comunità di studi che si riconosce nelle Digital Humanities, tanto che si è parlato dell'esistenza di un vero e proprio genere specifico nella letteratura di settore (cfr. Kirschenbaum, 2010), genere cui hanno contribuito molti dei suoi esponenti più autorevoli. Basti citare solo alcune delle pubblicazioni uscite negli anni più recenti: la fortunata miscellanea curata da Terras, Nyhan e Vanhoutte (2013), Defining Digital Humanities, che raccoglie lavori di varia estensione e tipologia usciti nel corso della prima decade del millennio ed è stata tradotta perfino in ruso e cinese; il libro Understanding Digital Humanities di Berry (2012) cui fa seguito dello stesso Berry con Fagerjord (2017) Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age; le due raccolte Debates in the Digital Humanities (cfr. Gold, Document shared on https://www.docsity.com/it/digital-humanities-metodi-strumenti-saperi/10919217/ Downloaded by: gabriele-prevosti (prevosti.gabriele20@gmail.com)2012; Gold e Klein, 2016); Big Digital Humanities di Svensson (2016); The Emergence of Digital Humanities di Jones (2013); gli interessanti articoli di Piotrowski (2018, 2020; cfr. anche Piotrowski, Xanthos, 2020); la ricca produzione di carattere storiografico, che spesso insiste sulla stessa questione, come i libri di Nyhan e Flinn (2016), di Jones (2016) e l'articolo di Ciotti (2018a) sulla tradizione italiana degli studi di informatica umanistica.
Questa rassegna bibliografica, peraltro non esaustiva, se da un lato conferma la centralità della definizione disciplinare delle Digital Humanities, lascia intendere come le visioni sul tema siano assai diverse, se non contraddittorie. A distanza di oltre un decennio, sembra ancora validissima la caratterizzazione dell'espressione "Digital Humanities" fornita da Stephen Ramsey in un assai dibattuto intervento al convegno annuale della Modern Language Association del 2011, intitolato sintomaticamente Who's In and Who's Out:
The term can mean anything from media studies to electronic art, from data mining to edutech, from scholarly editing to anarchic blogging, while inviting code junkies, digital artists, standards wonks, transhumanists, game theorists, free culture advocates, archivists, librarians, and edupunks under its capacious canvas (Ramsay, 2013, p. 239).
Senza dubbio ha sostanzialmente contribuito a tale diversità il fatto che nel corso dell'ultimo quarto di secolo questo campo di studi da fenomeno di nicchia, prevalentemente di ambito linguistico e letterario(sebbene anche storiografia e archeologia abbiano avuto una solida tradizione di rapporti con l'informatica) sia divenuto un movimento scientifico di primaria importanza e grande visibilità, sia nel mondo della ricerca e della didattica universitaria, sia nel più vasto dibattito culturale. Sebbene ancora sussistano differenze notevoli tra i vari contesti nazionali, specie in relazione al riconoscimento formale in ambito accademico, i numeri delle Digital Humanities in termini di quantità di ricercatori, posizioni, finanziamenti, progetti, centri di ricerca, corsi universitari, convegni, pubblicazioni, associazioni scientifiche nazionali e sovranazionali, sono straordinari. Questa "espansione" del "digitale" nel dominio umanistico ha perfino generato una controreazione da parte degli umanisti cosiddetti "tradizionali". Se fino a qualche anno addietro gli approcci computazionali e digitali erano ignorati o al massimo considerati con sussiego, ora si succedono prese di posizione critiche, e perfino allarmistiche, che spaziano dalla perplessità, se non scetticismo, sul loro contenuto scientifico e statuto epistemologico alla denuncia della loro valenza politica, ritenuta egemonista e dall'impronta "neoiperliberista" (cfr. Fish, 2012; Marche, 2012; Allington, Brouillette, Golumbia, 2016; Tomasin, 2017).
Durante questi anni di espansione, dunque, la comunità scientifica della Digital Humanities è divenuta così vasta e diversificata che è difficile individuare al suo interno un fondamento epistemico unitario e condiviso. D'altra parte, l'esigenza di autodefinirsi è un'attitudine tipica di ogni settore emergente della ricerca scientifica, specialmente quando esso ambisca ad assumere un ruolo e un riconoscimento nelle istituzioni accademiche. Questa attitudine non è solo la manifestazione di uno sterile interesse metateorico, come sembra intendere Cordell (2016), ma anche materialità istituzionale economica ed esistenziale. Si tratta insomma di rispondere a domande e questioni come:
- dove si fanno Digital Humanities: centri, dipartimenti, laboratori?
- che cosa si insegna nelle Digital Humanities? Qual è il sillabo di un corso di Digital Humanities?
- chi fa Digital Humanities? Come si seleziona in entrata e si promuove la carriera di chi fa ricerca in Digital Humanities?
- cosa sono buone Digital Humanities? Come si valutano i prodotti e i progetti di ricerca di Digital Humanities?
Per questo, nonostante il tema sia allo stesso tempo inflazionato e intrinsecamente difficile, intendiamo avanzare un tentativo di sistemazione della questione, che è anche una giustificazione della struttura e del contenuto di questo libro.
I paradigmi delle Digital Humanities
Il dibattito sulla definizione delle Digital Humanities è stato caratterizzato dalla dialettica - talvolta oppositiva talaltra sintetica - tra alcuni paradigmi fondamentali. Il primo e più importante tra questi, elaborato fin dalle origini di questo campo di studi, è il "paradigma metodologico", come rileva in modo assai efficace Kirschenbaum (2010, p. 15): "At its core, then, digital humanities is more akin to a common methodological outlook than an investment in any one specific set of texts or even technologies". In questo contesto il principium individuationis del campo umanistico digitale è costituito da un comune fondamento metodologico: la condivisione di un insieme di metodi computazionali e linguaggi digitali adottati per la "modellizzazione" dei fenomeni e dei processi appartamenti tradizionalmente al dominio delle scienze umane. La formulazione più nota di questo paradigma è quella elaborata da McCarty e Short (2001) nella relazione Mapping the Fields che introduce il concetto di Methodological Commons come nucleo delle Digital Humanities e ne rappresenta mediante una mappa concettuale le relazioni con il resto dei campi del sapere:
The Commons has within it the major data-types encountered in the humanities: (1) narrative or "running" text; (2) tabular alphanumeric ("chunky") data, (3) numbers, (4) visual images and (s) music, including other kinds of sound. The techniques applied to these data are not represented graphically Document shared on https://www.docsity.com/it/digital-humanities-metodi-strumenti-saperi/10919217/ Downloaded by: gabriele-prevosti (prevosti.gabriele20@gmail.com)