Diritto Penale: il principio di riserva di legge e i suoi corollari
Documento di Università sul Diritto Penale, il principio di riserva di legge. Il Pdf esplora il principio di riserva di legge e i suoi corollari, con un focus sulla legge regionale e le sanzioni amministrative, utile per lo studio del Diritto.
Ver más28 páginas

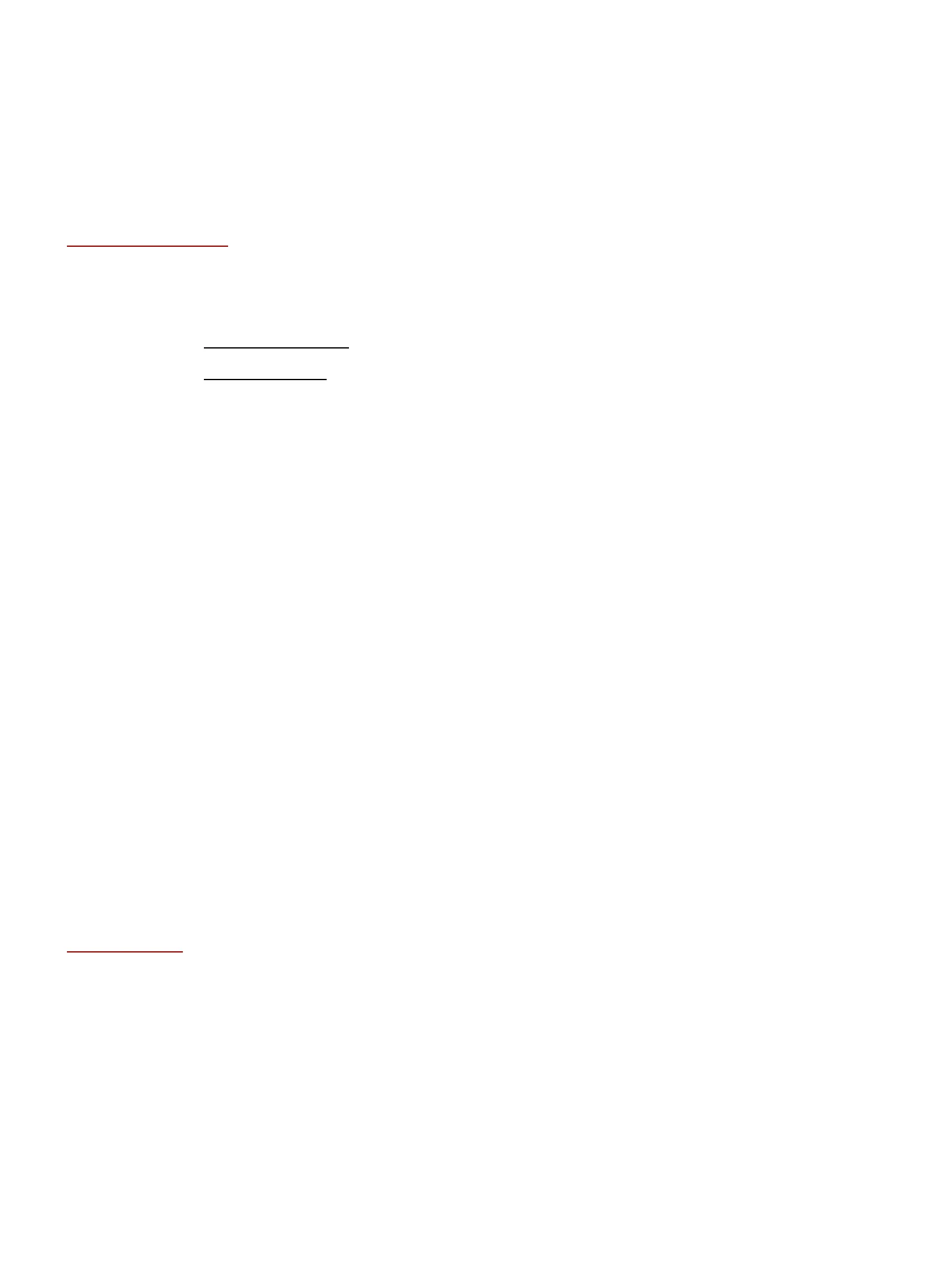
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
DIRITTO PENALE
IL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE E I SUOI COROLLARI
1. IL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE
Art. 25, co.2, Cost. - "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso."
La disposizione costituzionale in esame sancisce in materia penale due principi vigenti in materia penale, inerenti alla norma incriminatrice:
- Principio di riserva di legge
- Principio di irretroattività
Le questioni più controverse che sorgono nell'interpretazione del principio costituzionale della riserva di legge in materia penale riguardano essenzialmente due profili:
a) L'individuazione delle fonti normative che soddisfano la riserva di legge costituzionale ( in altri termini, cosa si intende per legge ai sensi dell'art.25, co.2, Cost.) b) La natura della riserva di legge e il conseguente spazio consentito alle c.d. fonti normative secondarie nella costruzione del precetto
2. La ratio politico-garantista della riserva di legge: il monopolio del Parlamento
La risoluzione delle suddette questioni prospettate richiede alcune considerazioni preliminari per individuare la ratio dell'art. 25, co.2, Cost., ovvero le ragioni per le quali il Costituente ha riservato alla legge la materia penale.
È affermazione ampiamente condivisa quella secondo cui la riserva di legge in materia penale ha un fondamento politico-garantista: è diretta a soddisfare un'esigenza di democraticità e rappresentatività nella formulazione della scelta incriminatrice.
L'art. 25, co. 2, Cost., attraverso il principio di riserva di legge, ha voluto riservare la c.d. scelta incriminatrice al Parlamento (cioè all'istituzione che soddisfa maggiormente le esigenze predette).
La pena infatti incide su valori fondamentali della persona (libertà personale, dignità sociale): da qui la necessità che la scelta del reato e delle relative sanzioni sia compiuta da un soggetto munito di rappresentatività (no incrimination without representation).
Il Parlamento, si rivela per diverse ragioni l'istituzione più idonea a compiere la scelta che precede l'introduzione del precetto.
- È l'istituzione direttamente rappresentativa dell'intera collettività nazionale (in quanto eletta a suffragio universale diretto);
- La procedura parlamentare di approvazione della legge (anche se si basa sul principio maggioritario) riesce ad assicurare una scelta mediata ( attraverso il confronto dialettico tra maggioranza e opposizione) e, soprattutto, offre possibilità di tutela e di interlocuzione anche alle minoranze.
La ratio della riserva di legge è dunque quella di assicurare nella materia penale il monopolio del Parlamento.La questione se esistano altre fonti abilitate ad incidere sulla materia penale (di rango primario o superprimario, ma diverse dalla legge parlamentare) deve, pertanto essere affrontata tenendo conto di questa ratio sostanziale di natura politico-garantista, sottesa all' art. 25, co.2, Cost.
Il criterio da utilizzare per selezionare gli atti normativi che soddisfano la riserva di legge è, in altri termini, un criterio non meramente formale, bensì sostanzialistico: verificare di volta in volta, qual'è il ruolo del Parlamento nel procedimento di formazione dell'atto normativo diverso dalla legge in senso formale.
Va sottolineato che ciò che conta non è la collocazione dell'atto normativo nella gerarchia delle fonti (cioè il fatto che abbia la stessa forza della legge o persino superiore).
Al contrario, ciò che rileva è se il relativo procedimento di formazione assicuri o meno al Parlamento quel ruolo centrale e tendenzialmente esclusivo, che solo è in grado di soddisfare l'illustrata esigenza di democraticità e rappresentatività.
Ci sono, ad esempio, atti normativi che nella gerarchia delle fonti hanno un valore superiore rispetto alla legge (come le fonti del diritto euro-unitario o le sentenze normative della Corte Costituzionale); essi, tuttavia proprio perchè non assicurano il monopolio del Parlamento nazionale, non possono direttamente produrre effetti penali in malam partem.
3. Gli atti aventi forza di legge adottati dal Governo: i decreti legislativi delegati e i decreti-legge
La questione concernente la legittimità costituzionale dei decreti legislativi delegati e dei decreti-legge in materia penale è stata da tempo affrontata e risolta dalla Corte costituzionale in termini positivi (anche la prassi parlamentare e governativa ammette che il decreto legislativo e il decreto-legge siano fonti abilitate a introdurre norme penali).
La Corte Costituzionale -pur condividendo la premessa secondo cui il criterio da utilizzare deve indagare il ruolo riservato al Parlamento, senza potersi risolvere nel dato meramente formale rappresentato dalla "forza di legge"- ha ritenuto che il Parlamento conservi un ruolo sufficientemente importante sia rispetto al decreto legislativo delegato, sia rispetto al decreto-legge.
- Decreto legislativo delegato: la sua inclusione tra le fonti abilitate ai sensi della riserva di legge in materia penale sarebbe giustificato dal fatto che il Parlamento, ai sensi dell'art. 76 Cost., deve dettare "principi e criteri direttivi" per il Governo, conservando per questa via il monopolio delle scelte punitive.
- Decreto-legge: a sua volta, la sua inclusione tra le fonti del diritto penale è legittimato
sulla base di un duplice argomento:
- Nel caso di conversione, le norme emanate dal potere esecutivo vengono fatte proprie dal Parlamento (che le traduce in una legge formale);
- Nel caso di mancata conversione, gli effetti del decreto-legge risulterebbero integralmente travolti sin dall'inizio (ex art. 77, co.3, Cost.).
3.1 Le critiche della dottrina rispetto all'uso del decreto legislativo in materia penale
Sebbene ormai, a livello operativo, la questione dell'ammissibilità in materia penale dei decreti-legge e dei decreti legislativi delegati sembri definitivamente risolta alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, il tema rimane invece aperto nel dibattito teorico.
Una parte della dottrina (Cupelli), infatti, non condivide la tesi accolta dalla Corte costituzionale e manifesta seri dubbi sulla legittimità costituzionale dei suddetti strumenti normativi.
Con riferimento al decreto legislativo delegato si osserva che la determinazione dei principi e dei criteri direttivi da parte del Parlamento circoscrive, ma non elimina la discrezionalità politica del potere esecutivo nell'esercizio della delega (a maggior ragione se si considera che nella prassi i criteri direttivi difettano di analticità e chiarezza).
Il confronto con l'ipotesi del regolamento delegato in materia penale rafforza queste critiche: e una legge parlamentare si limitasse a fissare principi e criteri direttivi e per il resto delegasse un regolamento governativo a formulare il precetto nel rispetto di quei principi e criteri, nessuno dubiterebbe della illegittimità di questa tecnica normativa di "creazione" del precetto, perchè in contrasto con la natura tendenzialmente assoluta della riserva di legge di cui all' art.25, co.2, Cost, che consente alla fonte secondaria solo un uso marginale, di specificazione in chiave tecnica, di elementi della fattispecie già definiti dalla legge.Non si vede, allora, perchè ammettere che il governo tramite decreto legislativo delegato possa fare ciò che certamente non può fare tramite il regolamento.
Le pur evidenti differenze (di forza e regime) tra decreto legislativo e regolamento delegato non appaiono, infatti, rilevanti per spiegare questa diversa possibilità di intervento in materia penale (negata al regolamento e ammessa per il decreto legislativo delegato).
Come si è già detto, la riserva di legge in materia penale ha la funzione politico- garantista di assicurare il monopolio del Parlamento nella scelta punitiva: la riserva di legge, per questa ragione, non guarda al rango formale della fonte normativa (primaria o secondaria) ma alla centralità del ruolo dell'istituzione parlamentare.
Tale ruolo, tuttavia, sembra ugualmente marginale sia nel regolamento delegato sia nel decreto legislativo delegato: in entrambi i casi, "l'autore" della scelta punitiva è il Governo; il Parlamento, attraverso la delega si limita a fissare criteri e principi che lasciano sopravvivere la discrezionalità politica dell'Esecutivo.
Ne può assumere alcuna rilevanza la circostanza che il decreto legislativo delegato è soggetto al sindacato di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, a differenza del Parlamento, che è invece sottoposto a un sindacato di costituzionalità diffuso (nel senso che è disapplicatile, se illegittimo, da qualsiasi giudice).
Questa differenza di regime è del tutto neutra rispetto alla ratio della riserva di legge di cui all'art. 25, co.2, Cost. La disposizione costituzionale vuole la legge non per assicurare il sindacato di costituzionalità accentrato sulle norme incriminatrici, ma per assicurare il monopolio parlamentare.
Il tipo di sindacato di costituzionalità (accentrato o diffuso) è, dunque, del tutto estraneo alla funzione della riserva di legge in materia penale.
Peraltro, il sindacato di costituzionalità accentrato è il segno della particolare forza dell'atto di rango legislativo (mai disapplicabile dal giudice comune, anche se incostituzionale).
Nell'ottica della tutela del cittadino, colpito da una norma incriminatrice incostituzionale, potrebbe, quindi, risultare più efficace un tipo di sindacato di costituzionalità diffuso (come accade per i regolamenti, disapplicabili, senza filtro, da qualsiasi giudice li ritenga incostituzionali).
Quanto appena detto conferma ulteriormente che l'abilitazione riconosciuta al decreto legislativo in materia penale (e la differenza rispetto al regolamento) non può essere giustificata dalla "forza di legge" e dalla conseguente tipologia di sindacato di costituzionalità che da tale forza deriva.
3.2 Le critiche della dottrina rispetto all'uso del decreto-legge in materia penale
Con riferimento al decreto-legge, si evidenzia che in caso di mancata conversione non sono più reversibili gli effetti sulla libertà personale (tanto nella forma delle misure cautelari, quanto nella forma di una pena conseguente a una condanna definitiva) prodotti da un decreto-legge che introduca nuove incriminazioni o inasprisca un preesistente trattamento sanzionatorio.
Inoltre, i presupposti di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del decreto- legge sono, nella maggior parte dei casi, incompatibili con quella esigenza di meditazione e ponderazione che, anche alla luce dell'idea del diritto penale come extrema ratio, dovrebbe precedere l'introduzione di nuove incriminazioni.
A ciò va aggiunto che il procedimento parlamentare di approvazione della legge di conversione del decreto-legge è retto da un'evidente esigenza di speditezza (al fine di assicurare la conversione nei tempi previsti dalla Costituzione). Questo determina il contingentamento dei tempi di discussione e la conseguente menomazione della dialettica parlamentare e, dunque, la significativa restrizione dei diritti delle minoranze.
La situazione è inoltre aggravata dalla diffusa prassi politica che spesso vede il Governo porre la c.d. questione di fiducia sulla conversione del decreto legge. Il Parlamento si trova così di fronte alla stringente alternativa tra convertire il decreto-legge (recependo le scelte punitive del Governo) oppure far cadere l'Esecutivo, con conseguente possibile scioglimento anticipato delle Camere stesse.
In questo contesto allora è difficile ammettere che nel caso del decreto-legge, nonostante la legge di conversione, il monopolista della scelta punitiva sia stato ancora il Parlamento.
Nel corso degli ultimi anni, la Corte costituzionale, pur continuando a non dubitare della legittimità costituzionale del decreto-legge in materia penale, ha comunque in vario modo cercato di reprimere l'uso da parte del governo di tale strumento.
Si tratta di interventi che riguardano l'uso del decreto-legge tout court (non solo, quindi, in materia penale), ma che hanno evidenti riflessi garantistici anche nella materia penale.
Si segnalano in particolare tre filoni giurisprudenziali:
a) Il divieto di reiterazione del decreto-legge non convertito: sin dalla sent. n. 360/1996 la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità costituzionale dei decreti-legge iterati o reiterati per violazione dell'art.77 Cost, quando tali decreti (considerati nel loro complesso o in singole disposizioni) abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi e sopravvenuti presupposti di necessità e di urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione.
b) L'evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza: è un vizio del decreto-legge che si trasmette alla legge di conversione, la quale, quindi, non ha efficacia sanante;