Il racconto di Marco: riassunto del Vangelo e analisi teologica
Documento dall'Università Cattolica del Sacro Cuore sul racconto di Marco, un riassunto completo del Vangelo. Il Pdf esplora l'autorialità, la datazione e la struttura teologica del Vangelo di Marco, con un focus sulla Croce e la Gloria, ed è adatto per lo studio universitario di Religione.
Ver más35 páginas
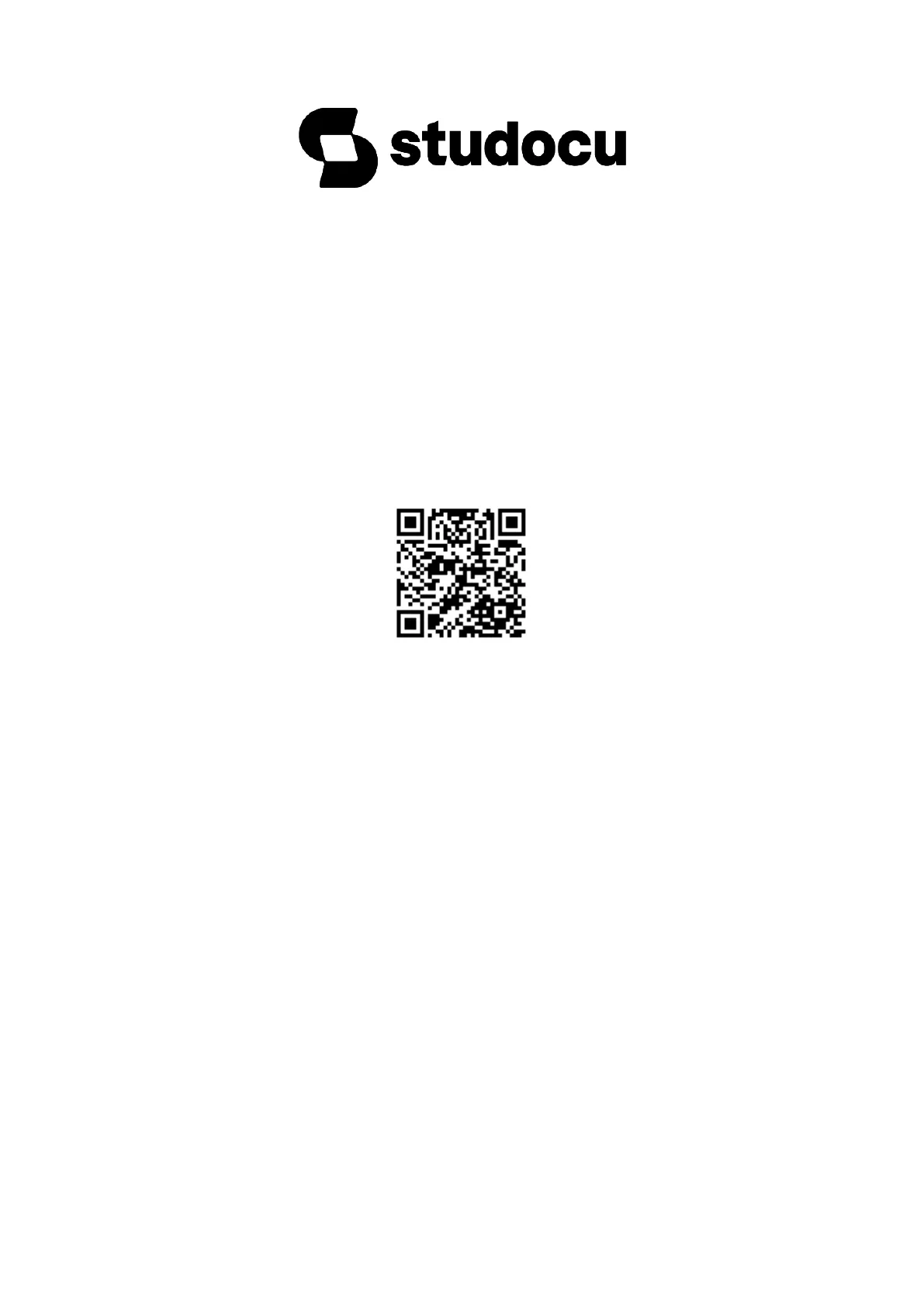

Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Introduzione al racconto di Marco
Autore e datazione del Vangelo di Marco
Chi è l'autore del secondo vangelo? La tradizione cristiana antica è unanime nell'attribuire il secondo vangelo a Marco; non c'è motivo serio per dubitare che si tratti di Giovanni Marco, personaggio più volte menzionato nel Nuovo Testamento. Secondo una notizia, la madre di Marco, Maria, era benestante e possedeva una casa spaziosa in cui poteva radunarsi l'intera comunità; è proprio in casa sua che Pietro trovò ospitalità dopo essere stato liberato dalla prigione. Marco ha due nomi: l'ebraico Giovanni e il soprannome greco/latino Marcos/Marcus; questo fa pensare ad una famiglia che parlava anche greco e che intratteneva rapporti anche con il mondo greco/romano. Paolo nomina Marco per primo nell'elenco dei collaboratori e ne parla anche nella lettera ai Colossesi, ponendolo fra i pochi giudei convertiti; nella prima lettera di Pietro, leggiamo che Marco è stato un carissimo collaboratore di Pietro. Oggi gli studiosi ritengono che il vangelo di Marco sia stato il primo ad essere scritto; in un certo senso, Marco è l'inventore del genere vangelo. Si discute sulla sua datazione: secondo l'opinione ancora oggi più diffusa sarebbe stato scritto intorno agli anni '70, anche se altri studiosi riportano la composizione del vangelo di Marco verso l'anno 50.
Struttura letteraria e teologica del Vangelo di Marco
A una prima lettura il vangelo di Marco può sembrare privo di ordine, ma in realtà c'è un ordine duplice: ORDINE STORICO: modellato sulle linee della più antica predicazione apostolica: comparsa di Giovanni Battista, il battesimo al Giordano e la tentazione nel deserto, il passaggio in Giudea, la passione e risurrezione. ORDINE KERIGMATICO: sorta di itinerario che intende condurre il lettore a comprendere e ad accettare il mistero di Gesù, un ordine più profondo. È piuttosto facile dividere questo vangelo in due grandi sezioni: la prima sezione ha come tema principale la rivelazione progressiva della messianità di Gesù; mentre la seconda sezione è tutta orientata verso la Croce. In modo più analitico:
- 1,1-20: prologo che racconta i primi avvenimenti della salvezza allo scopo di indicare al lettore le coordinate entro le quali leggere tutta la storia successiva;
- 1,21-8,26: sommari che Marco ha costruito per legare le varie parti e nel contempo generalizzare i racconti e si possono individuare tre sezioni: Gesù con la folla e i giudei; Gesù con i suoi discepoli; Gesù che si rivela ai discepoli, dei quali si sottolinea l'incomprensione;
- 8,27-9,13: passo importante e centrale che chiude la prima parte e apre la seconda; qui vengono indicate con chiarezza le due facce del mistero di Gesù: la croce e la gloria.
- 8,31-9,31-10,32-34: seconda parte del vangelo in cui ci sono i tre annunci della passione.
Un racconto da leggere a partire dalla sua conclusione
Marco non si è limitato a raccogliere i diversi ricordi e a ordinarli secondo uno schema storico; egli è convinto che i diversi aspetti della storia di Gesù non vanno semplicemente accostati bensì vanno letti e valutati a partire da un centro. Per Marco, il centro è la Croce/risurrezione. Dal capitolo 8,27 in poi, il racconto è scandito dalle tre predizioni della passione; già prima si legge che i farisei ed erodiani decisero di farlo morire; ancora più indietro, Gesù è descritto come lo sposo che ora è presente ma che sarà tolto. Marco ci invita dunque a leggere il suo racconto partendo dalla conclusione: il punto più panoramico in grado di mostrare per intero e in profondità la vicenda di Gesù è il Calvario.
Narrazione e teologia nel Vangelo di Marco
Nella prima metà del suo racconto, l'evangelista Marco non ci dà la risposta alla domande che gli sta a cuore "Chi è Gesù?", ma la prepara raccontando i fatti da cui è possibile dedurla. Da una parte, parole e gesti nei quali si manifesta la potenza di Dio che libera e salva e questo suscita la meraviglia della gente; dall'altra, una sconcertante debolezza: parole e azioni di Gesù sono le potenti opere di Dio che non si sottraggono alla contraddizione, discussione e incredulità. Per dire chi è Gesù non basta dire che è il Messia, in quanto il discepolo può ricadere nella logica degli uomini e attribuire una messianità secondo la carne; è la Croce che chiarifica e togli ogni equivoco: la passione non è semplicemente un gesto compiuto da Cristo a nostra salvezza, ma come un gesto che rivela il volto più vero e profondo di Dio; la passione conduce alla risurrezione: se il dono di sé rimanesse inutile e sconfitto non sarebbe il segno di Dio; invece lo è perché nell'amore è racchiusa la vittoria di Dio. Le donne, in visita al sepolcro, sono piene d'amore e tuttavia cieche difronte al mistero della Croce e cercano un crocifisso: con sorpresa scoprono che colui che cercano è risorto: l'amore non è sconfitto, ma vittorioso. Le tre predizioni della passione non parlano soltanto di morte, ma anche di risurrezione: lungo la via verso Gerusalemme, Gesù concede la sua gloria e anticipa la pasqua. Anche il racconto della crocifissione non si conclude senza un anticipo della risurrezione.
Un dibattito sul Vangelo di Marco
Marco è un vangelo breve che si concentra su pochi interrogativi: chi è Gesù? è il primo interrogativo; la domanda non riguarda solo la persona di Gesù di Nazareth, ma anche la presenza del Regno oggi nel mondo e nella comunità. Accanto al primo, un secondo interrogativo: chi è il discepolo? I due interrogativi sono il mistero che l'uomo deve comprendere e vengono sviluppati parallelamente. Si comprende come il vangelo di Marco sia interessante non solo per il tema che tratta, ma anche per il modo con cui lo tratta: un racconto essenziale, condotto secondo la tecnica del dibattito e con una logica di progressività che conduce il lettore sempre più dentro al mistero di Gesù.
Come leggere il Vangelo di Marco
Sbagliato è considerare il vangelo come cronaca; altrettanto sbagliato è considerare il vangelo come un libro dottrinale; non è un testo filosofico e teologico e non va letto come tale. Inoltre, non è un'antologia. Il vangelo è un racconto narrativo, opera unitaria e compiuta; nella lettura di un vangelo sono due le tentazioni a cui è necessario sottrarsi: di fronte a difficoltà di coerenza risolvere tutto sbrigativamente ricorrendo alla molteplicità delle fonti, alla loro discontinuità e frammentarietà; leggere, inconsapevolmente, il vangelo come se fosse un'antologia. La nostra lettura considera il vangelo come un racconto e lo legge seguendo le regole del genere letterario racconto, attenta alle coordinate temporali e spaziali, ai personaggi, alla composizione delle scene, alle tensioni; si tratta di una lettura ricca di suggestioni, fatta nella sua attuale stesura che comprende sia il materiale preesistente, sia il quadro e i ritocchi dell'evangelista. Un racconto è una vicenda che ha un inizio, uno sviluppo e una conclusione; è un intreccio di elementi diversi: coordinate spazio- temporali, personaggi e le loro relazioni, narrazione e descrizione, vicenda e discorso, gesti e parole, narrazione e commento, sviluppo globale e scene.
Le leggi del racconto evangelico
Il racconto è un intreccio di fili che formano un sistema: ogni frase e ogni scena va letta nell'insieme; nella lettura, l'attenzione deve concentrarsi sulle singole scene e sui particolari ma anche sull'intreccio delle scene e sul movimento dall'una all'altra. Questa lettura comporta di camminare continuamente avanti e indietro, ripercorrendo più volte l'intero cammino; certi passi e certi temi sono come dei nodi centrali per i quali passano tutte le strade. L'inconveniente della ripetitività è abbondantemente ricompensato: il racconto viene sviscerato nei suoi vari aspetti e prende vita sotto i nostri occhi. In ogni racconto esiste la tendenza alla ripetizione che è una delle tecniche principali per porre in evidenza qualcosa che interessa al narratore; il racconto parla narrando: non solo parla attraverso i discorsi, ma raccontando azioni e descrivendo situazioni. Il racconto non è soltanto da sentire, ma da vedere: bisogna leggerlo visualizzandolo. Nel racconto è importante mettere in luce le coordinate spaziali e temporali: nel racconto sono lineari e una delle cose peggiori è quella di leggere un racconto confrontandolo continuamente con la realtà. Il racconto ha le sue leggi: seleziona i particolari e li ordina diversamente; un conto è il tempo reale e un conto è il tempo narrativo; intreccia scene e sequenze: di queste esistono due tecniche, la concatenazione (una scena dopo l'altra) e l'incastro (una storia all'interno di un'altra). Se si vuole capire un racconto è importante studiare i personaggi, le loro azioni, trasformazioni e relazioni; la rete di relazioni fra personaggi è sempre di fondamentale importanza nella struttura di un racconto. Nessuna narrazione ha un'esistenza indipendente dall'ambiente in cui nasce: ogni opera compare sempre in un universo culturale e quindi nessuna lettura narrativa prescinde da un'ambientazione storica. Come ultima cosa, nelle mani di un abile narratore, l'episodio storico, datato, singolo, viene fatto "esplodere": rimangono i tratti datati ma vengono stilizzati per essere sempre validi; l'episodio viene tipicizzato e universalizzato, i personaggi diventano tipi.
Inizio del Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio (Mc 1,1-20)
Il prologo del Vangelo di Marco
Questa sezione svolge la funzione di prologo, il cui scopo non è tanto di narrarci i primi episodi di Gesù, quanto piuttosto di indicarci le coordinate entro le quali leggere tutta la sua storia. Alcuni termini ricorrenti e significativi ci rivelano già l'unità letteraria della sezione e le sue principali accentuazioni teologiche: vangelo, predicare, conversione, deserto, Spirito; inoltre due personaggi sono alternativamente protagonisti: Giovanni, nella prima parte, e Gesù nella seconda. Ciascuno è protagonista di un annuncio attorno al quale si forma un assembramento: la folla che accorre al Battista e i discepoli che seguono Gesù; questi due personaggi non sono semplicemente accostati, ma intrecciati: ciascuno compare nella scena in cui è protagonista l'altro e sono soprattutto confrontati e dal confronto emerge la superiorità di Gesù. L'intera sezione si articola su tre piani, rappresentati ciascuno da uno dei tre personaggi; i tre momenti non sono alla pari: al centro è Gesù, a cui il Battista indirizza e da cui la comunità scaturisce.
- il precursore: la preparazione che trova il suo centro nel Battista;
- Gesù: la sua storia;
- i discepoli: la comunità dei discepoli, cioè la storia aperta da Gesù che continua nella Chiesa.
Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio (Mc 1,1)
Possiamo considerare questa frase come il titolo dell'intero racconto; con poche parole, l'evangelista annuncia già la tesi che svilupperà nel suo intero racconto. Marco si dichiara convinto che il suo racconto sia un vangelo; ma che cosa intende di preciso con il termine vangelo? Nella grecità significava la ricompensa per una buona notizia; nel culto imperiale, vangelo era la nascita del futuro imperatore, la sua ascesa al trono e le sue vittorie. Per Marco, vangelo è ciò che riguarda Gesù di Nazareth; per Marco la lieta notizia è che il Signore sia Gesù di Nazareth, un Messia e Signore con tratti inattesi, differenti e persino capovolti. Paolo chiamò vangelo l'evento della morte e della risurrezione di Gesù: anche per Paolo, vangelo non è semplicemente un messaggio, ma la notizia di un evento che Paolo coglie esclusivamente nella morte e risurrezione di Gesù. Anche per Marco il centro è la Croce e la risurrezione, ma è esplicitamente sottolineato che l'intera storia di Gesù è lieta notizia. Anche la parola inizio merita attenzione: al passato, inizio dice che comincia qualcosa di nuovo: Marco sa che inizia qualcosa di nuovo rispetto all'Antico Testamento e rispetto alla storia degli uomini e alle loro speranze; la lieta notizia di Gesù è una notizia attesa, desiderata ma anche inaspettata e sorprendente; al futuro, inizio dice il primo germe di uno sviluppo, l'evento iniziale di un processo o di una storia. Il vangelo non è apparso come qualcosa di grandioso e di già perfettamente costituito, ma ebbe un inizio, un inizio umile e uno sviluppo. Inizio può anche significare origine, i primi rudimenti, fondamento, sommario; Marco si concentra sull'essenziale, sulla radice che tutto sorregge. Con una semplice parola, inizio, Marco è riuscito a dichiarare lo scopo della sua impresa: raccontare come la lieta notizia ebbe inizio; è convinto che, per far capire a fondo il vangelo, sia bene ricondurlo alla sua origine, coglierlo nel suo momento iniziale. Il genitivo di va inteso in senso forte: Gesù non è solo il portatore e l'annunciatore della lieta notizia, ma è Lui stesso la lieta notizia; Gesù è l'annunciatore e il contenuto del vangelo. Marco non riporta soltanto ciò che Gesù ha insegnato o annunciato: racconta la sua presenza, la sua attività e la sua persona. Gesù di Nazareth che è vissuto in quel modo, ha fatto quelle scelte, è stato condannato, è morto in Croce ed è proprio Lui il Messia e Figlio di Dio; la lieta notizia non è semplicemente la venuta del Messia ma è la venuta del Messia con quelle modalità concrete.
Come scritto in Isaia il profeta
"Come scritto in Isaia il profeta": Marco si premura di precisare che, al tempo stesso, il vangelo è in continuità con le antiche Scritture: novità e continuità non si contraddicono. La continuità evangelica non è ripetizione e la sua novità non è rottura. La storia di Gesù avviene nella continuità, anche se nel contempo può giustamente ritenersi una novità.