Riassunto di storia economica: industrializzazione e sviluppo globale
Documento dall'Università degli Studi di Pavia su riassunto di storia economica. Il Pdf, un riassunto di storia economica, esplora l'economia preindustriale, le rivoluzioni industriali e le dinamiche economiche mondiali tra il XIX e il XXI secolo, con un focus sull'industrializzazione in diverse nazioni, utile per lo studio universitario di Economia.
Mostra di più68 pagine
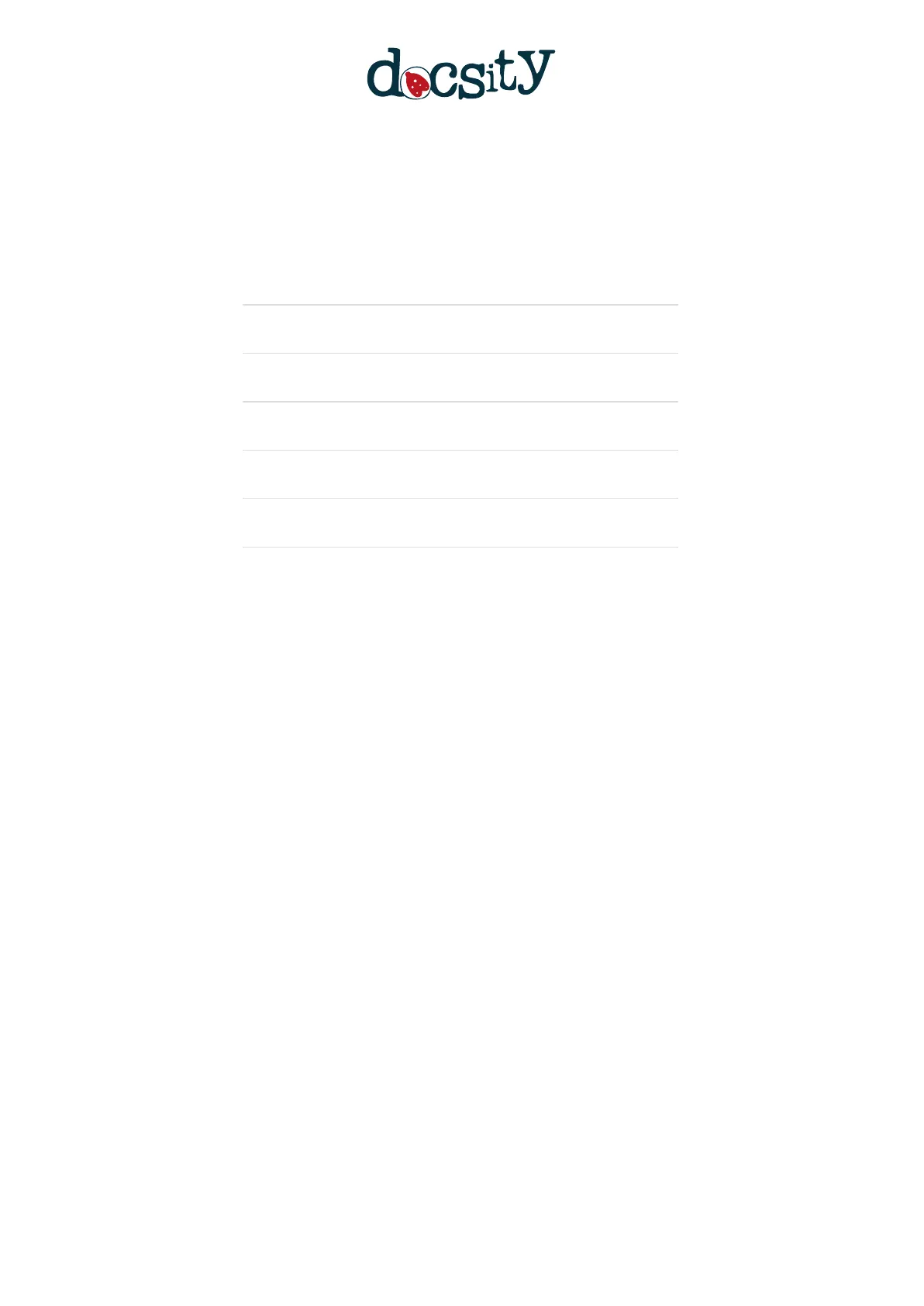

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Riassunto di storia economica
decsity Riassunto di storia economica Storia Economica Università degli Studi di Pavia 67 pag. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: yostina-nakhnukh (yostina.nakhnoukh01@icatt.it)STORIA ECONOMICA PROFESSORE: RIZZO MARIO VALENTINO (titolare) - 6 CFU ESAME: Orale LIBRO: Marco CATTINI, L'Europa verso il mercato globale. Dal XV secolo alla crisi di inizio XXI, Milano, Egea, 2015, seconda edizione, pp. 1-17, 22-29, 45-54, 63-291. + Stefano BATTILOSSI, Le rivoluzioni industriali, Roma, Carocci, 2002. PROGRAMMA: dopo aver brevemente descritto alcuni caratteri salienti dell'economia preindustriale, il corso affronta la Rivoluzione industriale inglese, per poi illustrare la diffusione dell'industrializzazione su scala europea e mondiale, delineando altresì taluni aspetti e tendenze fondamentali dell'economia mondiale nei secoli XIX, XX e XXI. Il programma si articola nei seguenti punti principali:
- l'economia preindustriale: alcuni aspetti salienti;
- il primo paese industriale: la Gran Bretagna;
- l'industrializzazione in Europa (1815-1914);
- l'industrializzazione fuori d'Europa: Giappone e Stati Uniti;
- la prima globalizzazione fra Otto e Novecento;
- da una guerra all'altra (1914-1945);
- l'economia mondiale fra prosperità, crisi e trasformazione (1945-2015);
- decolonizzazione, Terzo Mondo, globalizzazione: bilanci e prospettive.
Email: Ricevimento: 1 di 67 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: yostina-nakhnukh (yostina.nakhnoukh01@icatt.it)
CATTINI - L'EUROPA VERSO IL MERCATO GLOBALE
CAPITOLO 1: STRUMENTI E METODI INTERPRETATIVI
1.1 Introduzione
La storia economica e sociale è la disciplina che nasce tra la fine dell'800 e l'inizio del 900, quando è in corso il fenomeno di industrializzazione che sta cambiando il mondo (la seconda rivoluzione industriale), e che contribuisce a rinnovare le scienze sociali. La storia economica si fonda sul principio che l'approccio storico e quello socio-antropologico siano complementari e interdipendenti, cioè che per capire i fenomeni sociali non basta mettere insieme delle statistiche storiche, ma bensì bisogna tenere in considerazione anche altri elementi. Gli studiosi che adottano tale metodo sono convinti che i comportamenti economici individuali e collettivi dipendono anzitutto da sistemi di valori sociali e culturali riconducibili alla comunità di appartenenza. Infatti, gli studiosi nel condurre le indagini adottano un metodo olistico - cioè che considera il tutto. Bisogna quindi adottare uno sguardo complessivo e induttivo, che tenga conto delle forme politico-istituzionali, delle gerarchie sociali, delle mentalità e dei costumi, che condizionano i comportamenti individuali e collettivi.
1.2 La storia economica scienza sociale
Da quando, nella prima metà dell'800, in Europa occidentale l'industrializzazione cominciò a trasformare la vita quotidiana di un crescente numero di persone, gli studiosi compresero che le società stavano subendo delle trasformazioni senza precedenti. I sociologi distinsero le società in: società tradizionali (immobili) e società tecnologiche (dinamiche), andando a considerare tre aspetti: 1) le relazioni economiche, 2) l'organizzazione sociale e le mentalità collettive.
Società Tradizionali
· Per quanto riguarda le relazioni economiche, la maggior parte dei membri di queste società sono dediti all'agricoltura, all'allevamento, alla caccia e alla raccolta di frutti spontanei; queste società soddisfano una limitata scala di bisogni individuali e collettivi producendo da se sia i beni di consumo che quelli di investimento (autarchia), indispensabili per continuare i cicli produttivi annuali di piante e animali. Sono caratterizzate da una pluriattività stagionale, senza traccia di un'apprezzabile divisione del lavoro, ad eccezione di alcune attività che invece erano una prerogativa di pochi artigiani (come ad esempio la lavorazione dei metalli). Le tecnologie applicate nel lavoro agricolo sono elementari, così come le armi utilizzate per la caccia e per la guerra. Solitamente la terra, che è la ricchezza fondamentale di ogni comunità, appartiene in solido all'intero gruppo di abitanti che la sfrutta secondo ritmi lavorativi stagionali. La ripartizione dei raccolti e delle prede di caccia e pesca avviene secondo principi solidali di proporzionalità. Il raro capitale privato e la bassa produttività fanno si che la limitata produzione dipenda dalle condizioni meteo climatiche. Di conseguenza, vi era la necessità di una gestione comunitaria, il fallimento dei raccolti (carestia) incombeva ogni anno sugli uomini e un deficit di riserve di cibo poteva causare delle vere e proprie catastrofi demografiche. Inoltre, in questo modo raramente disponevano di riserve eccedenti, così che la lontananza tra i villaggi e i rari centri urbani, la lentezza e l'alto costo dei trasporti e le dogane sui cereali rendevano scarse le relazioni commerciali anche tra le comunità confinanti. All'interno delle società tradizionali le relazioni di compravendita erano relativamente fare e la moneta, quando c'era, assolveva la funzione per lo più di misura e di riserva di valore piuttosto che di mezzo di scambio. · L'organizzazione sociale è fondata su tre cardini: 1) La parentela assicura ai vincoli di sangue il primato fra i legami sociali e alle alleanze matrimoniali il ruolo fondamentale di collante sociale e culturale. Ognuno è identificabile secondo il grado di consanguineità che lo lega al tronco dell'albero genealogico della famiglia e di conseguenza, difficilmente gli stranieri riescono a stabilire delle durature relazioni sociali e quindi vengono percepiti come degli estranei o addirittura come delle potenziali minacce per il gruppo con il quale tentano di interagire. La parentela contempla degli obblighi e delle relazioni di reciprocità e le solidarietà parentali mettono al riparo dalla sottonutrizione e della fame chi manca di adeguate scorte alimentari. Inoltre, ogni aspetto della vita comune, dalle pratiche religiose alle feste e ai passatemi, è profondamente influenzato dalle relazioni mantenute tra i clan familiari. 2) In base al genere, uomini e donne delle società tradizionali obbediscono a norme non scritte e si uniformano a dei modelli comportamentali imposti loro sia dal clero, sia dal potere politico. 3) Infine, secondo l'età raggiunta, si accede a uno status o lo si cambia mediante dei riti di passaggio magico-religiosi. · Mentalità collettive. All'interno delle società tradizionali l'analfabetismo è dominante e si ha un gran numero di cognizioni attorno a piange, animali e astri, che si sono formate empiricamente e sono tutte ritenute vere, utili e pratiche. Ogni sapere empirico è il prodotto di un'attenta osservazione collettiva, continuata per molte generazioni e trasmessa oralmente da una generazione all'altra. Questo genere di società è quindi caratterizzata dal fatto di essere restia ad accettare delle innovazioni e dei mutamenti, che vengono percepiti come minacce per l'ordine culturale, sociale ed economico e sconvolgerebbero ogni rapporto mentale e pratico con le cose e con gli altri. Lo spazio dedicato alla scienza, alla storia e alla sociologia è occupato dai miti, che legano tra di loro cognizioni disparate e eterogenee, che una volta integrate acquisiscono significato e coerenza. La mitologia racconta l'origine lontana dell'ordine costituito e la sua evoluzione, concorrendo quindi a fondare la tradizione di un ordine fisico e metafisico nel quale il sacro, il magico e l'utile si fondono fornendo rassicurazione all'uomo.
Società Tecnologiche
· Per quanto riguarda le relazioni economiche, nelle società tecnologiche osserviamo il passaggio da organizzazione a sistema. 2 di 67 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: yostina-nakhnukh (yostina.nakhnoukh01@icatt.it)In queste società muta il rapporto con l'ambiente: se prima prevaleva l'idea della natura che dettava i ritmi produttivi, ora una fitta trama di meccanismi e organismi e di conoscenze scientifiche in costante evoluzione si interpone tra l'uomo e la natura con l'intento di dominarla e di sfruttarla. Le relazioni economiche hanno come scopo la credente produzione (piuttosto che la nera riproduzione) e il lavoro, applicato a fonti energetiche inanimate, assicura una crescente produttività. Vi è inoltre un dominio di transazioni contrattuali, facilitate dal ricordo alla moneta e al credito, e un'accentuata divisione del lavoro specializzato che favoriscono l'affermarsi di un sistema capitalistico in Occidente. Queste società sono caratterizzate dalla concezione di produrre per vendere piuttosto che per consumare e si avviò un processo produttivo fondato sull'economia di mercato, grazie all'appropriabilità dei terreni da parte di alcuni che se ne riservarono lo sfruttamento privato (per investire è necessario che la proprietà diventi privata, così che vi sia l'inventive a migliorare). Sulla terra vennero fatti degli investimenti di capitale fisso e circolante per coltivare nuove specie extraeuropee e per migliorarne le rese. Gli agricoltori diventano agricoltori-imprenditori, e combinando terra, capitale e lavoro salariato, svolsero il quarto ruolo di fattore produttivo. Nel 1700 ci fu l'avvento del capitalismo agrario e poi proto-industriale, che derivò sia dall'allocazione ottimale dei fattori produttivi, sia dalla distribuzione della ricchezza prodotta mediante l'incontro di domanda e offerta sul mercato aperto a tutti (mercato di libera concorrenza), reso efficiente grazie all'uso della moneta, al ricorso al credito e della pubblicazione dei prezzi quotidiani. L'offerta/domanda di risorse, merci, moneta, servizi e opportunità di lavoro non fece altro che stimare la produzione e negli imprenditori accrebbe il desiderio di arricchirsi e migliorare il proprio status. · Organizzazione sociale. Oltre ai rapporti di parentela, genere e età, con qualche attenuazione rispetto al passato, che conservarono a lungo il ruolo di strutture fondanti, le società tecnologiche si articolare in classi, ceti, partiti politici, sindacati, gruppi professionali, movimenti, associazioni volontarie, club e altre forme di associazione basate su interessi e ideali condivisi. Il perno attorno al quale ruota gran parte delle relazioni sociali tra singoli e gruppo è il binomio produzione-consumo. Lo status cessa di essere ascrittivo (che si acquisisce con la nascita) ma diventa acquisitivo, quindi soggetto a miglioramenti o peggioramenti con il tempo. Un altro carattere distintivo è dato dalla coesistenza di molteplicità di élite tra di loro in perenne contrasto. · Mentalità collettive. Nonostante rimangono molte credenze ereditate dalle società tradizionali, nelle società tecnologiche prevalgono conoscenze e opinioni fondate sulla razionalità, ossia l'inclinazione a considerare vero solo quanto è provato dalla ricerca scientifica e dall'esperienza. Il mondo della produzione di beni e servizi è sottoposto a continui aggiustamenti e mutamenti e vi è una crescente esigenza d'istruzione (gli studi diventano un potente fattore di promozione sociale, al fine di arrivare a svolgere professioni apprezzate e ricompensate con prestigio, potere e ricchezza). Infine in queste società vi è libertà di pensiero, che implica anche la possibilità di confutare e mettere in discussione quanto si crede vero (di conseguenza, le società tradizionali sono considerate più stabili e rassicuranti). Il carattere più appariscente dell'organizzazione economica delle campagne europee (400-800), a parte i casi di Olanda e Inghilterra, è il dominio delle attività rurali (lo possiamo vedere sia considerando la mole della popolazione che viveva in campagna, sia andando a vedere i volumi di ricchezza che annualmente erano prodotti in cereali, legumi frutti e ortaggi e così via). Molte delle fasi lavorative si svolgevano in campagna, dove, nei mesi invernali, ci si occupava di filatura e tessitura per la famiglia e per i mercati committenti. Le medie e le piccole imprese contadine sfruttavano intensamente i terreni, mentre nei latifondi e nelle tenute si faceva largo uso di manodopera salariata e di animali da lavoro. Ciascun nucleo familiare mirava a disporre ogni anno delle scorte indispensabili sia per nutrire le persone, sia per investire le sementi nel ciclo agrario futuro. Questo comportamento aveva due conseguenze: - Dalla metà ai 3/4 dei prodotti annuali dei medi poderi erano consumati e investiti in natura (autoconsumo e auto investimento) dai produttori stessi. Persino i salari corrisposti agli operai agricoli erano liquidati in generi di prima necessità; - Vi era una gracilità strutturale del mercato, perché la maggior parte dei piccoli e medi produttori non coltivava la terra con l'obiettivo di vendere almeno una parte dei raccolti. La vendita di prodotti agricoli era casuale e imprevedibile, per la ragione che l'offerta di vettovaglie riguardava solo scorte eccedenti rispetto ai fabbisogni domestici dei produttori che casualmente diventavano merce. Nelle regioni dei grandi latifondi, era normale invece disporre di eccedenze da vendere, sicché gli scambi di mercato con moneta svolgevano un ruolo tutt'altro che marginale nella distribuzione della ricchezza prodotta. Analogamente, nelle regioni centro- occidentali d'Europa, dove la natura dei terreni e le condizioni meteo climatichi garantivano rese maggiori, le carestie erano rarissime. Anche nelle aziende rurali di piccole e medie dimensioni, le vettovaglie eccedenti rispetto a quelle destinate all'autoconsumo e all'auto investimenti erano offerte sul mercato più vicino in cambio di moneta. Nell'Europa centro-meridionale invece (Portogallo, Spagna, mezzogiorno francese, Italia, Balcani e Grecia), i rendimenti dei cereali e dei legumi erano bassi e soprattutto oscillavano da un anno con l'altro. Questo impediva perfino ai latifondisti di prevedere le loro future eccedenze e i relativi prezzi. Questo riduceva i contadini produttori al ruolo altrettanto imprevedibile di venditori o di compratori secondo le circostanze.
1.3 Interazioni e interdipendenze
In prospettiva storica, le relazioni economiche fanno parte di un macroinsieme di relazioni sociali e culturali riconducibili ad almeno quattro differenti sotto insieme interdipendenti tra di loro: ambiente, popolazione, istituzioni politiche e giuridiche e gerarchie sociali. 1) L'ambiente è il campo di studio delle scienze naturali e della geografia che si interessano degli influssi esercitati dalla natura sulle comunità umane e delle trasformazioni che in vario modo gli uomini apportano alla natura. Tra i geografi di fine 800 prese l'idea che certe condizioni ambientali implicassero determinate soluzioni sociali ed economiche, così da ricondurre i diversi gradi di sviluppo delle società ai prevalere dei fattori naturali sulle culture degli uomini. Quando però si accertò che popolazioni diverse, stanziate in ambienti analoghi, avevano elaborato soluzioni differenti per risolvere il 3 di 67 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: yostina-nakhnukh (yostina.nakhnoukh01@icatt.it)