Istituzioni di Diritto Privato: concetti introduttivi e situazioni giuridiche
Documento sulle Istituzioni di Diritto Privato, che offre una panoramica dei concetti introduttivi, delle situazioni e dei fatti giuridici. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, esamina il diritto soggettivo, gli atti illeciti e leciti, le persone fisiche e giuridiche, beni, proprietà e possesso, e la classificazione degli atti giuridici.
Ver más49 páginas
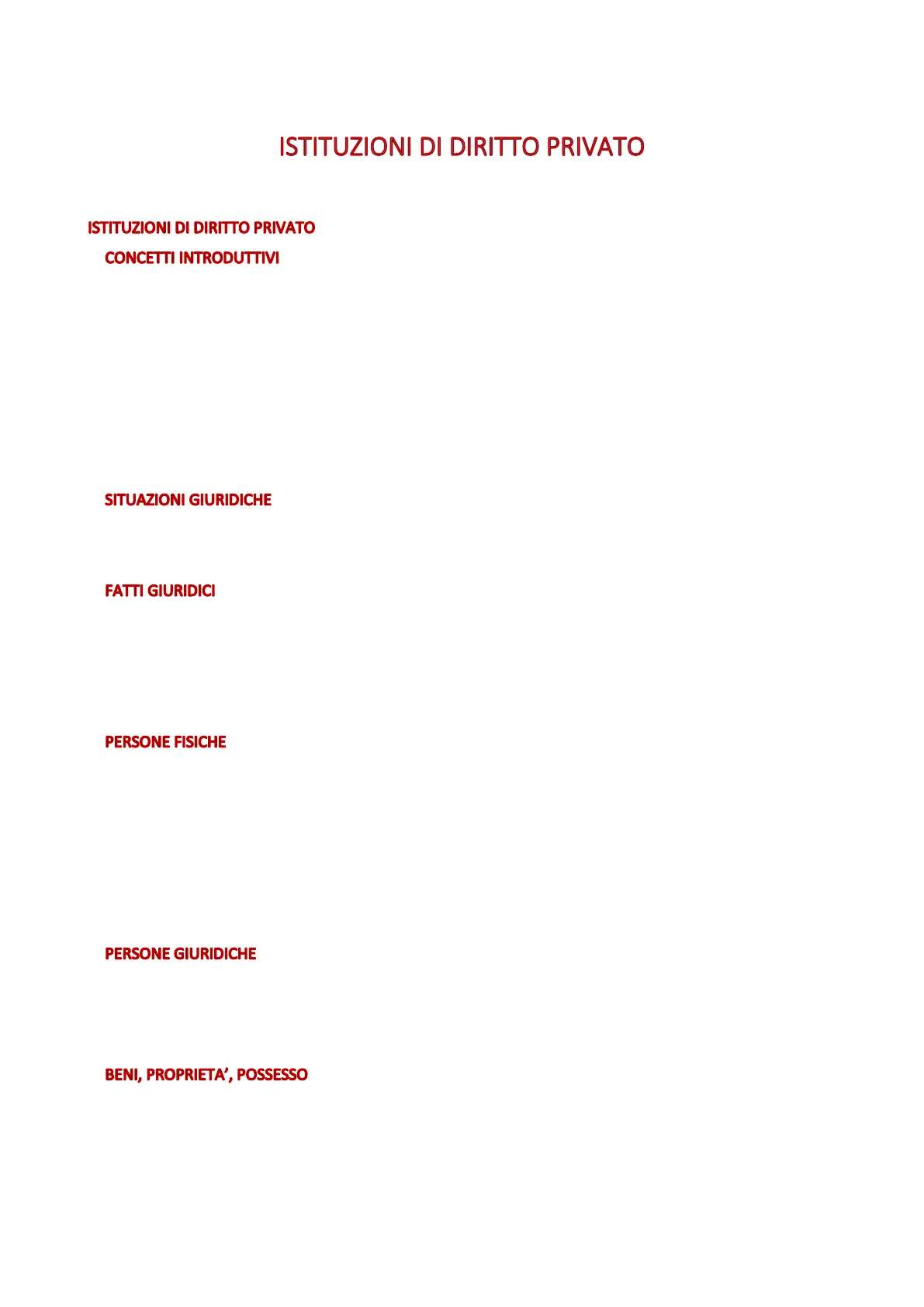
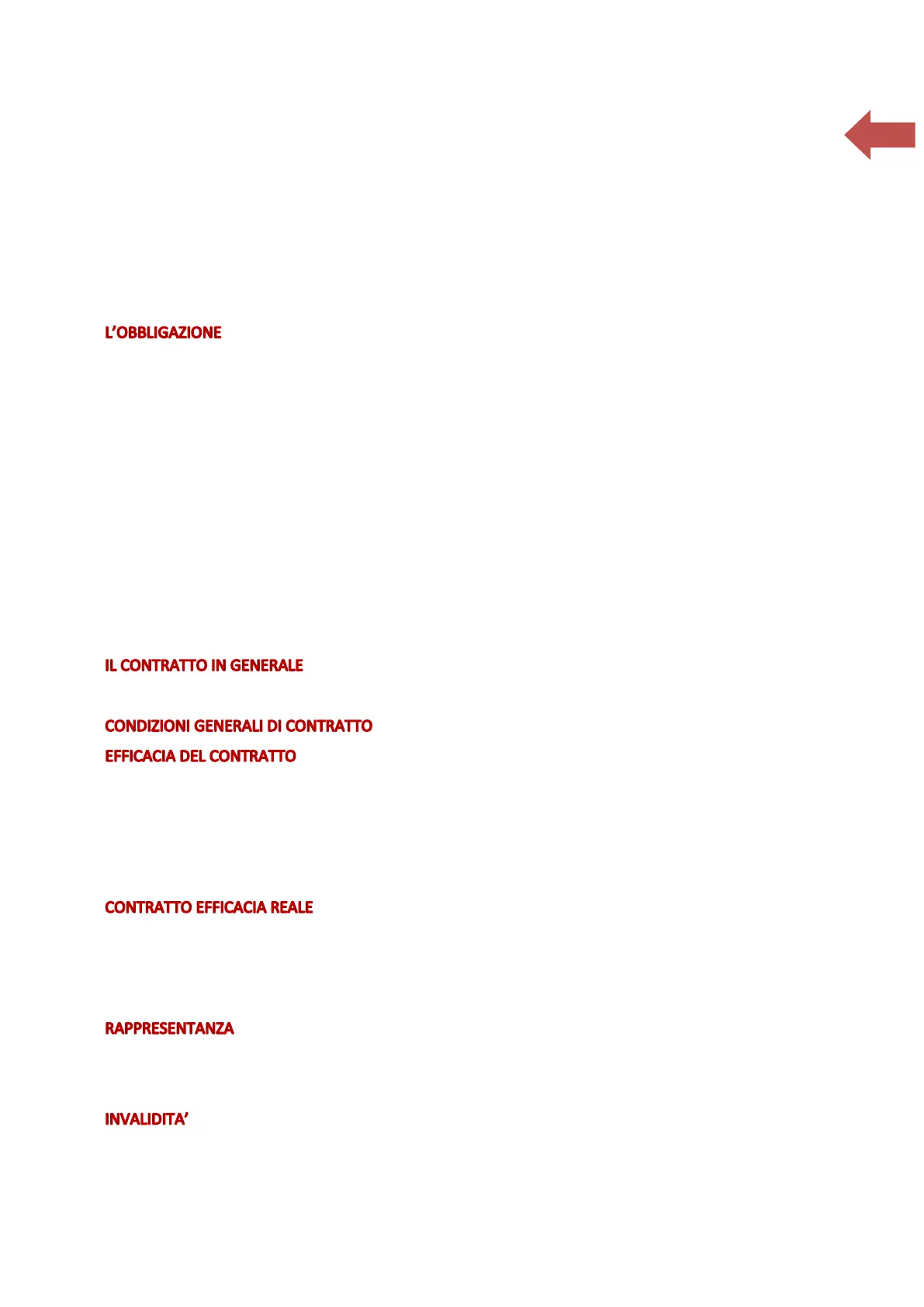
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Sommario
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
1
CONCETTI INTRODUTTIVI
4
LA COSTITUZIONE
4
FONTI DEL DIRITTO EUROPEO
5
LEGGE ORDINARIA E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
6
L'APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
6
L'INTERPRETAZIONE
7
LA CODIFICAZIONE
7
STRUTTURA DEL CODICE CIVILE (1942)
8
SITUAZIONI GIURIDICHE
9
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
9
IL DIRITTO SOGGETTIVO
9
FATTI GIURIDICI
10
ATTO ILLECITO
10
ATTI GIURIDICI LECITI
10
CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI
11
LA RAPPRESENTANZA
12
PERSONE FISICHE
13
I SOGGETTI DI DIRITTO
13
LA CAPACITA' GIURIDICA
13
CAPACITA' DI AGIRE
13
INCAPACITA' LEGALE
14
INCAPACITA' NATURALE O DI FATTO
15
I DIRITTI DELLA PERSONALITA'
15
PERSONE GIURIDICHE
16
PERSONE GIURICHE E SOGGETTI COLLETTIVI
16
SOGGETTI COLLETTIVI NON RICONOSCIUTI
17
BENI, PROPRIETA', POSSESSO
18
BENI
18
DIRITTO DI PROPRIETA'
18
DIRITTI REALI LIMITATI
19
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA'
20
LE PERSONE GIURIDICHE
16AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI REALI
20
LA COMUNIONE
21
IL CONDOMINIO DEGLI EDIFICI
21
LA MULTIPROPRIETA'
21
IL POSSESSO
22
GLI EFFETTI DEL POSSESSO
22
AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO
23
L'OBBLIGAZIONE
24
IL CONCETTO E LE FONTI
24
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
25
RAPPORTO OBBLIGATORIO
25
ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE
26
LA GARANZIA PATRIMONIALE
26
INADEMPIMENTO
27
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
28
MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO
28
LA SUCCESSIONE NEL CREDITO
30
30
IL CONTRATTO IN GENERALE
31
REQUISITI DEL CONTRATTO
31
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
34
35
REGOLA FONDAMENTALE SULL'EFFICACIA DEL CONTRATTO
35
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
35
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
35
EFFICACIA DEL CONTRATTO RISPETTO A TERZI
36
CONTRATTO EFFICACIA REALE
36
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
36
EFFETTI DEL CONTRATTO
37
CONFLITTO TRA PIU' ACQUIRENTI
37
RAPPRESENTANZA
38
PATOLOGIE DELLA RAPPRESENTANZA
38
MANDATO
38
INVALIDITA'
39
CAUSE DI NULLITA' (art. 1418)
39
CAUSE DI ANNULLABILITA'
39
2
MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
EFFICACIA DEL CONTRATTOOPERATIVITA'
40
3
RISOLUZIONE
41
CAUSE DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
41
RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA (art. 1467 ss.)
41
RISOLUZIONE PER PRESUPPOSOSIZIONE
41
I CONTRATTI
42
CONTRATTI DI ALIENAZIONE
42
CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE
43
CONTRATTI DI PRESTAZIONI D'OPERA O DI SERVIZI
44
LA DONAZIONE
45
FATTI ILLECITI
46
ILLECITO CIVILE- RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE (artt. 2043-2059)
46
- DANNO INGIUSTO
46
- NESSO DI CAUSALITA'
47
- IMPUTABILITA' - art. 2046
47
- COLPEVOLEZZA
47
RESPONSABILITA' OGGETTIVA
47
RESPONSABILITA' INDIRETTA
48
ONERE DELLA PROVA
48
DANNO RISARCIBILE
48
DANNO BIOLOGICO
49
PRESCRIZIONE E DECADENZA
494
CONCETTI INTRODUTTIVI
La parola "diritto" può avere due significati diversi a seconda che la si intenda in modo oggettivo o soggettivo. Nel primo caso, si intendono le regole che governano la condotta degli individui (es. diritto penale), mentre nel secondo caso si intende il potere riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse (es. diritto di proprietà su un bene, diritto che mi sia ripagato un debito). Il diritto privato riguarda norme che regolano i rapporti tra i cittadini e i rapporti tra lo Stato e i cittadini quando lo Stato non agisce in posizione di supremazia. Il diritto pubblico, invece, riguarda norme che regolano la struttura e il funzionamento dell'apparato statale e i rapporti tra Stato e cittadini quando lo Stato agisce in posizione di supremazia. Questi due tipi di diritto rappresentano due grandi sottoinsiemi che comportano diversità di principi, linguaggi, tecniche operative e si distinguono in particolar modo per i soggetti (privati vs enti pubblici), per gli interessi (particolari vs generali) e per la struttura (parità vs supremazia). La caratteristica delle regole giuridiche è che queste non hanno carattere né descrittivo né assertivo ma PRESCRITTIVO (sono cioè dei precetti che esprimono dei comandi) e sono dotate del carattere della COERCIVITA' (hanno il potere di costringere con la forza). Esse hanno anche un carattere GENERALE (non si rivolgono a un soggetto ma a una serie di soggetti) ed ASTRATTO (riguardano una serie ipotetica di casi e di fatti) ma, nel momento in cui sono applicate, possono essere tradotte in comandi PARTICOLARI E CONCRETI. L'ORDINAMENTO GIURIDICO si definisce come un universo di regole di diritto, che formano un insieme unitario ed ordinato perché prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all'organizzazione di un gruppo sociale. Si dicono FONTI del diritto tutti gli atti e i fatti da cui si originano norme giuridiche. Si possono distinguere le fonti di produzione, ovvero i procedimenti attraverso i quali in una determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica (es. decreto legge, legge, decreto legislativo), e le fonti di cognizione, ovvero i contenitori, quindi i documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formatesi attraverso le fonti di produzione (es. Costituzione, i codici). Il primo libro delle "disposizioni preliminari sulla legge in generale" del codice civile tratta delle fonti, ma non è completo poiché è del 1942 e perciò non teneva conto della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea. Il primo articolo di questo libro include come fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Occorre, però, tenere conto anche della Costituzione e della normativa dell'Unione Europea. Di conseguenza, le fonti del diritto privato sono:
- La costituzione e le leggi costituzionali
- Il trattato dell'Unione Europea e la legislazione comunitaria
- La legge
- I regolamenti
- Gli usi
LA COSTITUZIONE
La costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e può essere definita anche come "fonte sulle fonti" in quanto definisce come fare le leggi, ovvero disciplina i processi di produzione delle fonti. È una costituzione rigida, cioè modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso rispetto alla legislazione ordinaria (tutto ciò perché memori dell'esperienza del fascismo). Il procedimento per modificare la legge costituzionale è regolato dall'art. 138 della costituzione e afferma che sono necessarie due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, approvate dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (se approvata ci può essere la richiesta di un referendum costituzionale) e5 un eventuale referendum popolare se nella seconda votazione la legge non è stata approvata dai due terzi dei componenti delle Camere. Ci sono, però, dei limiti alla revisione costituzionale che può essere un limite espresso, ovvero l'art. 139 che afferma che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, oppure limiti impliciti come, ad esempio, il principio di unità nazionale, di eguaglianza, sovranità popolare e i diritti fondamentali. Oltre alle regole che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'apparato statale, la Costituzione contiene anche i principi fondamentali del diritto privato: -> Art. 2 - diritti inviolabili dell'uomo -> Art. 3 - principio di eguaglianza -> Art. 29 - famiglia -> Art. 30 - filiazione -> Art. 32 - diritto alla salute -> Art. 41 - libertà di iniziativa economica -> Art. 42 - proprietà privata I principi costituzionali sono rilevanti sia come criterio interpretativo di altre norme, sia come norme di immediata applicazione. 1
FONTI DEL DIRITTO EUROPEO
- TRATTATI COSTITUTIVI della Comunità europea e dell'Unione Europea: trattato di Roma (1957) con cui nasce la Comunità europea; trattato di Maastricht (1992) con cui nasce l'Unione Europea e il trattato di Lisbona (2007) in cui viene approvata e diviene vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
- REGOLAMENTI: possono essere emanati solo nelle materie previste dai Trattati, hanno immediata efficacia e prevalgono sulla legge interna
- DIRETTIVE: sono precedute da una serie di "considerando" a cui poi seguono gli articoli veri e propri. Si tratta di prescrizioni rivolte agli Stati membri, cioè contengono i principi che il legislatore dello Stato membro deve adeguarsi, e devono essere recepite per divenire efficaci.
L'unica eccezione riguarda le direttive self-executing: se la direttiva non è stata recepita in tempo dallo Stato ma è chiara e applicabile nei casi del singolo, allora può essere usata dai singoli anche se non è stata recepita in tempo dallo Stato. Il mancato recepimento entro i termini comporta una sanzione pecuniaria, per questo l'Italia ha introdotto la legge comunitaria secondo la quale il Governo presenta al Parlamento una serie di compiti che deve svolgere per recepire tutte le direttive in tempo e evitare, in questo modo, la sanzione. La direttiva, inoltre, può essere vaga se l'UE tende all'armonizzazione minima e quindi ha una maggiore possibilità di interpretazione oppure non vaga se l'UE tende all'armonizzazione massima e non è interpretabile 1 *gradi di giudizio: 1. tribunale 2. corte costituzionale: valuta la legittimità della legge (se durante un giudizio un avvocato o il giudice ha un dubbio costituzionale, il giudice (a quo) rimette il giudizio alla corte costituzionale, la quale può emettere sentenze interpretative (di accoglimento o di rigetto) con cui indica il modo di interpretare la legge affinché sia costituzionale 3. cassazione (giudice di legittimità): valuta se le leggi sono state applicate correttamente nei giudizi I primi due tipi di giudice sono definiti anche "giudici di merito"6
LEGGE ORDINARIA E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
- LEGGE ORDINARIA: secondo la procedura descritta dagli artt. 70 ss. Costituzione La potestà legislativa è attribuita in determinate materie anche alle Regioni. Secondo l'art. 117 della Costituzione, per alcune materie tale attribuzione è esclusiva, per altre concorrente
- ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: anche il governo può legiferare in due casi:
- DECRETO LEGGE (art. 77 Costituzione): solo in caso di condizioni di necessità e urgenza e ha una durata è di 60 giorni, entro i quali le Camere devono convertirlo in legge altrimenti decade perdendo gli effetti ex tunc (fin dall'inizio)
- DECRETO LEGISLATIVO (art. 76 Costituzione): il Parlamento può delegare la funzione legislativa al Governo a patto che ci sia una legge delega nella quale sono determinati i principi e criteri direttivi (non è, dunque, necessario che venga convertito in legge)
In caso di ANTINOMIE NORMATIVE (ovvero conflitti tra norme), l'ordinamento ha previsto degli strumenti per la loro soluzione: -> Criterio CRONOLOGICO: regola la successione delle fonti nel tempo (vale la più recente). La sua applicazione comporta l'abrogazione della fonte più vecchia -> Criterio GERARCHICO: regola i rapporti tra fonti di diverso rango -> Criterio della COMPETENZA: regola i rapporti tra fonti abilitate ad incidere su materie diverse
L'APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
La norma descrive una fattispecie astratta che nel momento in cui è applicata diviene particolare e concreta. Le norme giuridiche, infatti, non sono destinate a rimanere dei documenti cartacei, affermazioni teoriche di principi o di declamazioni retoriche, ma da generali ed astratte sono destinate a diventare comandi particolari e concrete. Il giudice è colui che opera questa trasformazione tramite una SENTENZA (ovvero la decisione del giudice che, esaminato il caso concreto, interpreta le norme e le applica). Il diritto in action o legal process si compone di tre momenti agganciati l'uno all'altro in un processo dinamico: 1. Legislazione (le fonti) 2. Giurisprudenza (insieme delle decisioni dei giudici 3. Dottrina (la letteratura specialistica) Non sempre il percorso parte dalle fonti; molto spesso nuove regole sono create dalla giurisprudenza, illustrate e razionalizzate dalla dottrina e trovano solo in un secondo momento un riconoscimento legislativo. 2 2 Il nostro sistema è un sistema di CIVIL LAW: abbiamo fonti scritte e il giudice decide basandosi su quelle fonti perché è soggetto solo alla legge Nei sistemi di COMMON LAW, invece, ci si basa sul precedente vincolante, ovvero una decisione già presa/avvenuta in passato in caso analogo, da cui si ricava una "regola" che possa valere per ogni caso simile