Diritto Privato: diritti reali, proprietà e possesso
Documento di Marika Vallelunga su Diritto Privato: diritti reali, proprietà e possesso. Il Pdf, un riassunto di Diritto per l'Università, esplora i diritti reali, la proprietà e le azioni a tutela del possesso, con un focus su usucapione e diritti reali minori.
Mostra di più22 pagine
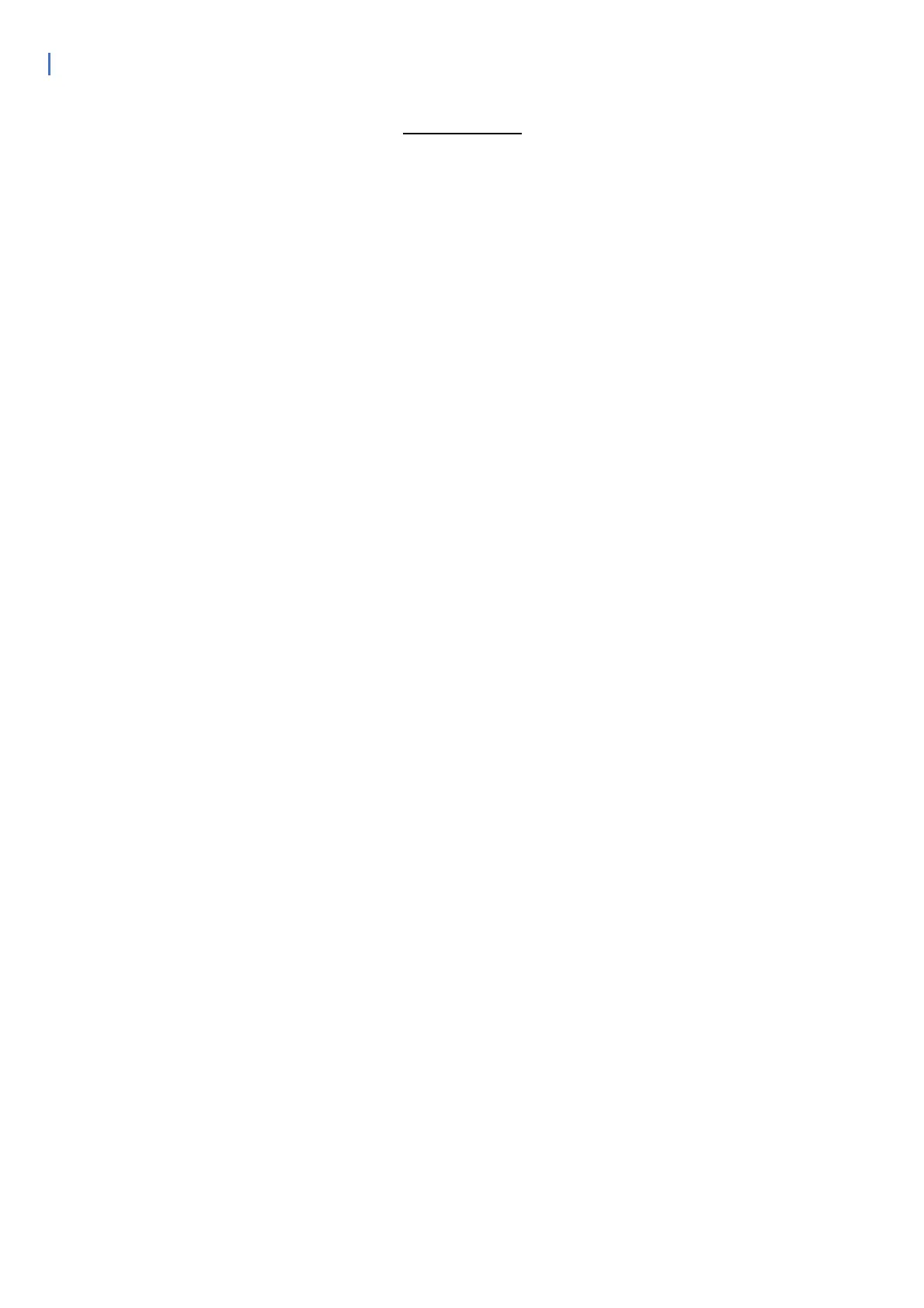
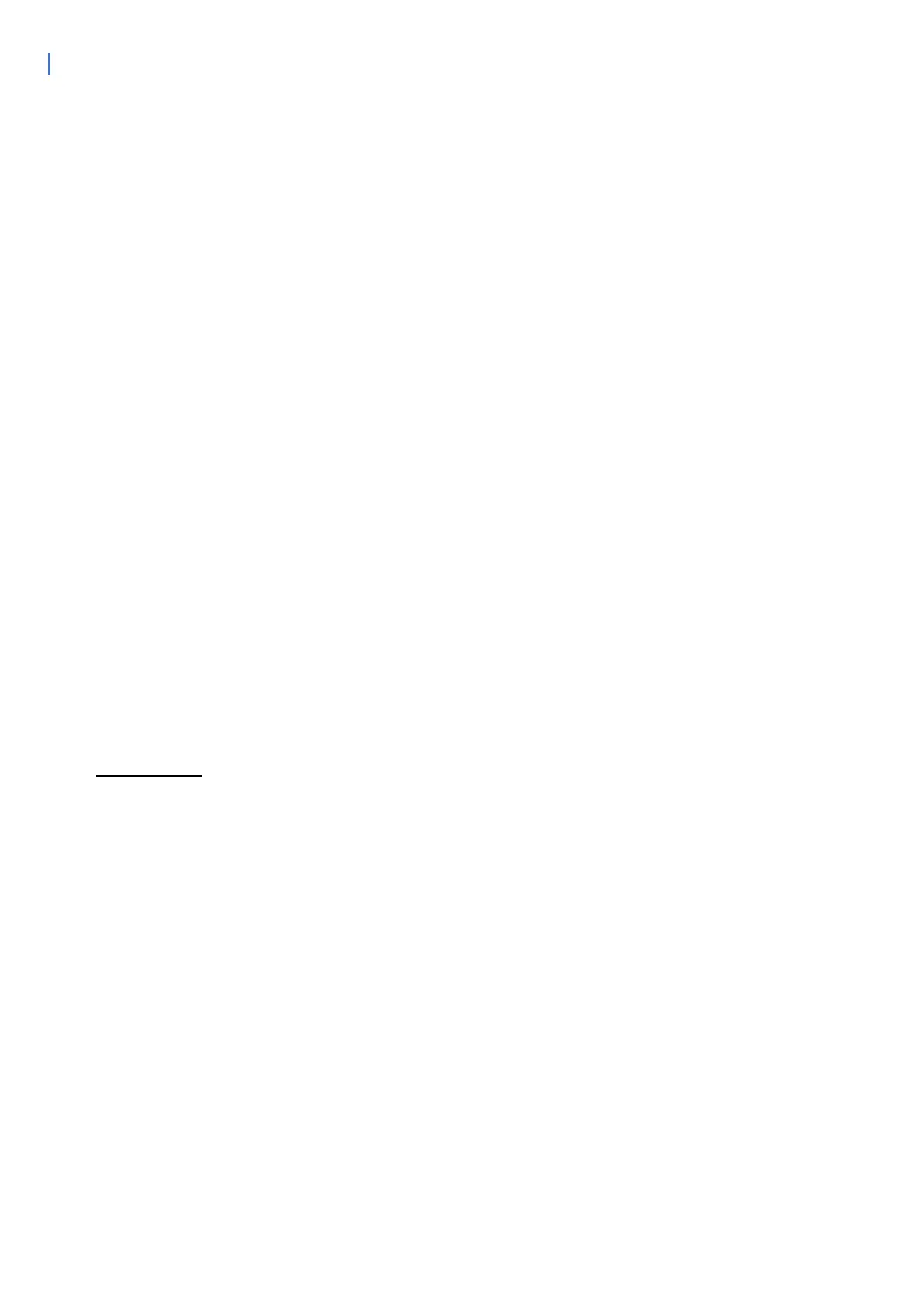
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
I Diritti Reali
I diritti reali sono diritti assoluti. La caratteristica di tali diritti è quella di conferire al titolare poteri e facoltà da esplicarsi sui beni. Il diritto reale per antonomasia è la proprietà, ma vi sono altri diritti reali minori che si distinguono in.
- Diritti reali di godimento > conferiscono una facoltà di godimento più o meno ampia su una cosa altrui. Essi sono: superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediale)
- Diritti reali di garanzia > non sono finalizzati a conferire al titolare il godimento di un bene, come invece fanno la proprietà e i diritti reali di godimento, ma conferiscono un rafforzamento della sua possibilità di ottenere il soddisfacimento di un suo credito. Essi sono: pegno e ipoteca.
Esistono anche i diritti personali di godimento che, però, non sono dei diritti reali, ma sono dei diritti relativi, che attribuiscono al titolare la pretesa di soddisfarsi su quel bene. Alcuni esempi di diritti personali di godimento sono: il diritto del conduttore, il diritto del comodatario, ecc. La caratteristica della proprietà e degli altri diritti reali è quella che attribuire al titolare la facoltà innanzitutto di godere di quel bene. Noi siamo soliti definire il diritto d'autore, il diritto di marchio, ecc. come proprietà intellettuali, anche se in realtà non si tratta di una vera e propria proprietà, perché tali diritti accordano all'ideatore o a chi ha acquistato il diritto, prevalentemente il diritto di sfruttamento economico, cioè si prende atto del fatto che questi beni immateriali hanno quasi esclusivamente un valore di scambio, ma non hanno un valore d'uso.
Valore di Scambio e Valore d'Uso
Il valore di scambio si ha quando l'utilità che il bene immateriale è in grado di fornire consiste nella remunerazione ottenuta dalla cessione del diritto di sfruttamento economico a terzi oppure dalla possibilità concessa a terzi di poter sfruttare quell'opera dell'ingegno. Il valore d'uso è tipico dei beni corporali, ed è l'attitudine ad appagare i bisogni individuali. I beni corporali oltre al valore d'uso hanno anche un valore di scambio perché anche i beni corporali possono essere ceduti a terzi. La proprietà tradizionale riguarda soltanto quei beni che esprimono tanto un valore di scambio o quanto un valore d'uso, ovvero i beni corporali. Mentre i beni incorporali hanno una forma di appartenenza che però non può definirsi proprietà. Il denaro non è un bene perché non esprime un valore d'uso, ma esprime solo un valore di scambio. Dunque, è sbagliato utilizzare la formula "proprietà del denaro" ma sarebbe più opportuno utilizzare la formula "titolarità del denaro". La titolarità del denaro è una forma di appartenenza massima ma non si può chiamare proprietà perché non c'è l'elemento del godimento. Il denaro è: mezzo di scambio, strumento di pagamento, riserva di valore.
La Proprietà
La proprietà è il diritto reale per antonomasia. La proprietà è regolata dall'art 832 cc, il quale definisce la proprietà come il diritto che attribuisce al titolare, cioè il proprietario, la facoltà di godere e il potere di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. La facoltà di godere fa riferimento al fatto che il proprietario può godere dei beni traendone le utilità coerenti con la loro natura. Il potere di disporre fa riferimento al fatto che il proprietario può anche 50Diritto Privato (Prof.Piraino) - Riassunto realizzato da MARIKA VALLELUNGA. disporre di quel bene, alienando la proprietà del bene a terzi o costituendo su di esso diritti reali, e ciò consente la circolazione dei beni. La pienezza della proprietà fa riferimento al fatto che al proprietario, a differenza del titolare di altri diritti reali, è attribuita la generalità delle forme di godimento e di disposizione che quel particolare bene consente. La pienezza si attenua quando il proprietario concede il diritto di godimento a terzi, comprimendo temporaneamente il proprio diritto. La pienezza si estende anche in senso verticale, cioè si estende anche a ciò che si trova sopra e sotto il bene oggetto di diritto. L'esclusività della proprietà è legata alla circostanza che nel nostro ordinamento giuridico i soggetti possono essere titolari di un bene per l'intero uno per volta; dunque, non è possibile che vi siano contemporaneamente più titolari per l'intero. Fenomeni di titolarità contestuale su uno stesso bene sono ammessi ma solo se i soggetti sono contitolari dello stesso bene non per l'intero, ma pro quota (COMUNIONE).
Caratteri del Diritto di Proprietà
I caratteri del diritto di proprietà sono:
- IMPRESCRITTIBILITA': il diritto di proprietà non si perde con il mancato esercizio di esso.
- PERPETUITA': l'acquisto del diritto di proprietà su un bene immobile non può avere un termine prestabilito.
- ELASTICITA': il diritto di proprietà si comprime in presenza di un diritto reale minore e si ri-espande nel momento in cui il diritto reale minore cessa.
Limiti della Proprietà
Come emerge dall'art 832 cc, vi sono dei limiti della proprietà, che possono essere distinti in due categorie:
- Limiti interni > sono limiti alla proprietà nell'interesse dell'altrui proprietà (es: rapporti di vicinato). Questi vengono chiamati anche limiti tradizionali.
- Limiti esterni > sono limiti alla proprietà funzionali a garantire il perseguimento di interessi generali.
Limiti Interni della Proprietà
I LIMITI INTERNI della proprietà nell'interessa dell'altrui proprietà sono:
- DIVIETO DI ATTI EMULATIVI: sono regolati dall'art 833 cc, il quale stabilisce che il proprietario non può compiere atti, i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o di recare molestie ad altri. La nostra giurisprudenza è ancora legata ad un'interpretazione molto liberale dell'art 833 cc, secondo la quale l'atto è emulativo soltanto se animato dall'intento di nuocere, cioè se si tratta di DOLO. Questa interpretazione però rende molto difficile la prova di un atto emulativo, perché provare il dolo è molto complesso, in quanto si tratta di uno stato soggettivo che appartiene alla sfera interiore del soggetto. La prova può essere resa soltanto tramite presunzione o tramite una confessione dell'autore. Un giurista molto importante, cioè Ugo Natali, ha proposto un'interpretazione che rende più facilmente applicabile l'art 833 cc, che però non è ancora stata accolta. Egli ha proposto di intendere che un atto è emulativo quando l'atto di esercizio della proprietà non reca alcuna utilità al titolare che lo compie mentre produce un danno significativo ad un altro proprietario, oppure quando produce un'utilità per il proprietario che lo compie che è di gran lunga inferiore rispetto al danno che reca ad un terzo. Questa interpretazione non è ancora stata accolta e quindi non basterebbe provare tutto ciò, ma si dovrebbe anche dimostrare l'intenzionelità del titolare, cioè l'intento specifico di nuocere. Il rimedio nei confronti degli atti emulativi è quello di poterne vietare il compimento oppure poterne chiedere la rimozione, o comunque sia chiedere il risarcimento del danno.
- DIVIETO DI IMMISSIONI: le immissioni sono regolate nell'ambito della proprietà fondiaria dall'art 844
cc, il quale stabilisce che le immissioni sono le propagazioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori, gli
51Diritto Privato (Prof.Piraino) - Riassunto realizzato da MARIKA VALLELUNGA.
scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se superano la normale tollerabilità,
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Le immissioni che si collocano entro il limite della
normale tollerabilità sono ammesse e non possono essere vietate, mentre quelle che superano il limite
della normale tollerabilità sono illecite. Il parametro della normale tollerabilità è una norma
indeterminata e spetterà al giudice stabilire, caso per caso, dove questo limite si collochi. Il legislatore
fissa un criterio aggiuntivo che può essere adoperato, cioè quello della natura dei luoghi. Il rimedio al
superamento del limite della normale tollerabilità è l'azione inibitoria. Inoltre, il giudice, pur avendo
constatato il superamento del limite della normale tollerabilità, è legittimato a ricorrere ad un rimedio
differente rispetto all'azione inibitoria, che consiste nel risarcimento del danno. La ratio di questa
norma (art 844 cc) è la protezione della proprietà individuale, ma negli anni è stata impiegata anche per
ragioni differenti rispetto alla sua ratio. Infatti, negli anni la giurisprudenza se ne è servita:
- in primo luogo, per tutelare la salute perché in molti casi gli atti di immissione sono propagazioni che potrebbero recare danno alla salute individuale;
- in secondo luogo, per la salvaguardia dell'ambiente, condannando gli autori di attività nocive per l'ambiente ad interrompere tale attività o a compiere il risarcimento del danno.
Si tratta di usi strumentali, perché l'art 844 cc non mira a tutelare la salute o l'ambiente, ma mira alla protezione della proprietà individuale.
Proprietà Fondiaria
La proprietà fondiaria è regolata dagli artt. 840 e seguenti del Codice civile. L'art 840 cc enuncia una caratteristica della proprietà che si chiama PRINCIPIO DI ESTENSIONE VERTICALE, secondo il quale il proprietario del suolo è anche proprietario di tutto ciò che si trova al di sopra o al di sotto del suolo. Art 841 cc: Il proprietario ha il diritto di chiudere il fondo, cioè di recintarlo a seconda però delle regole dettate dal Comune di riferimento. Art 842 cc: Il proprietario del fondo, anche qualora lo abbia chiuso, non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia. Il proprietario può sempre opporsi a chi non è munito di licenza. Art 843 cc: Il proprietario del fondo deve, inoltre, permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso del vicino dovesse provocare un danno al proprietario che deve consentire l'accesso, sarà dovuta un'indennità. Il proprietario deve inoltre permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo dalla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.
Ius Aedificandi e Attività Edilizia
Tra le facoltà che la proprietà Fondiaria conferisce al proprietario vi è anche quella di poter costruire. La facoltà di costruire si chiama IUS AEDIFICANDI. Lo ius aedificandi è stato nel corso degli anni disciplinato nel tentativo di regolarlo e di garantire diversi obiettivi di ordine generale. Il primo obiettivo di ordine generale è quello di evitare un'eccessiva consumazione del territorio, che si verifica laddove l'attività edificatoria dovesse essere lasciata alla piena libertà dei proprietari. Spetta ai comuni il compito di suddividere in aree il territorio comunale procedendo a quella che viene chiamata "zonizzazione". Ciascuna zona ha una sua destinazione: ci sono zone destinate ad attività agricole, zone destinate ad attività industriali, zone edificabili destinate ad attività commerciali o residenziali, ecc. Lo strumento attraverso il quale il comune svolge questa suddivisione in zone viene chiamato piano regolatore, il quale è un atto amministrativo che divide il territorio nazionale in zone edificabili e non edificabili. Il testo unico sull'edilizia (DPR 6 giugno 2001) individua diverse categorie di attività edilizia:
- attività edilizia libera, cioè eseguita senza alcun titolo abilitativo;
- attività edilizia subordinata ad una comunicazione di inizio lavori;
- attività edilizia subordinata al permesso di costruire; 52