Le Norme di Diritto Internazionale e l'Unione Europea nel Diritto Italiano
Documento di Università sul rapporto tra diritto italiano, internazionale e dell'Unione Europea. Il Pdf esplora gli articoli costituzionali pertinenti, i meccanismi di adattamento delle norme internazionali e il principio del primato del diritto comunitario, utile per lo studio del Diritto.
Mostra di più9 pagine
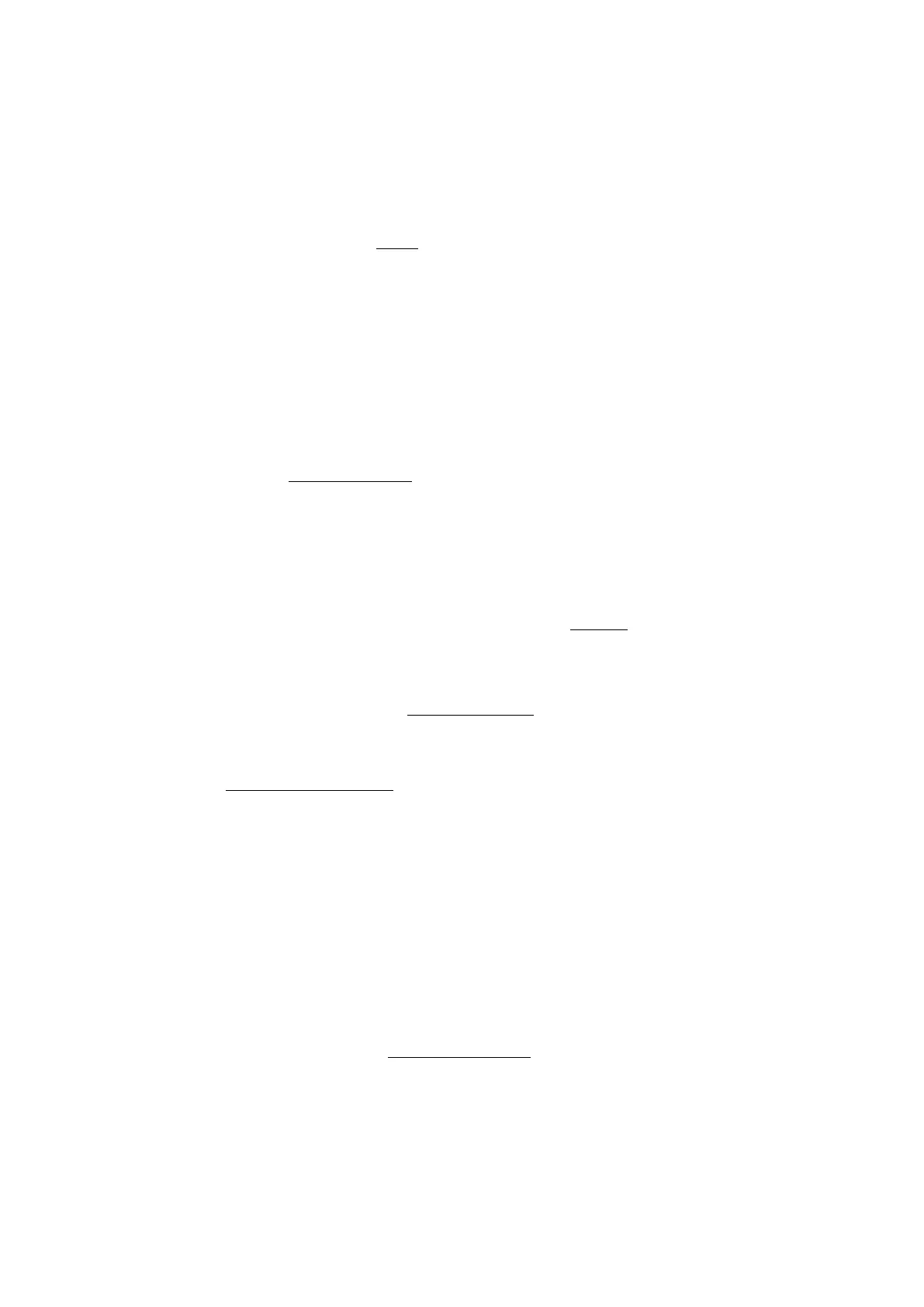
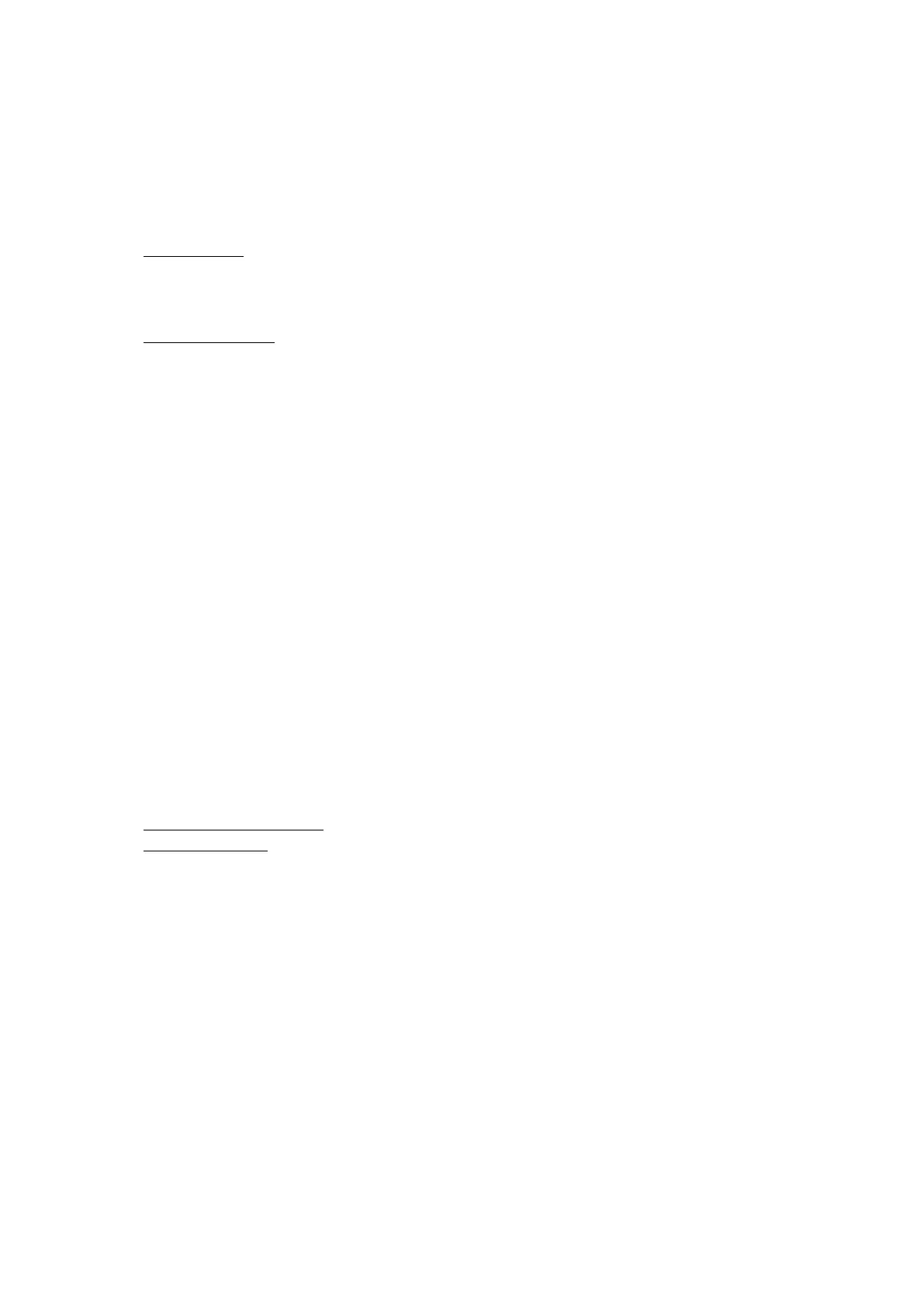
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Le norme di diritto internazionale e l'Unione Europea
La Costituzione Italiana si caratterizza come una Costituzione attenta ai rapporti internazionali e per questo le fonti riconosciute all'interno del nostro ordinamento sono anche prodotte da ordinamenti esterni. Le norme costituzionali sono qualificabili dunque come fonti sulla produzione, rispetto alle fonti del diritto internazionale, definibili invece come fonti di produzione. La Costituzione italiana si qualifica come aperta verso la comunità internazionale: Art. 10, comma 1: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" Ciò comporta una possibile cessione di sovranità da parte dello Stato nei confronti di organizzazione sovranazionali e in generale verso la comunità internazionale: Art. 11: "si consente, a condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo" Nel consentire limitazioni di sovranità ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, viene a dimostrarsi l'apertura quantitativa e organizzativa, non essendo specificate né l'entità di tale limitazione e né le organizzazioni internazionali rispetto alle quali tali cessioni possono avvenire: questa apertura è cioè connotata dal principio pacifista, rafforzato dallo stesso comma 1 dell'Art.11, dove si afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Corte cost., sent. n. 238/2014: "la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona". A questa apertura alle organizzazioni internazionali si oppone poi una chiusura sulla forza di attribuire ai trattati internazionali, che non può essere maggiore rispetto alla legge che li recepisce.
Diritto interno e internazionale
Da un punto di vista generale, infatti, il sistema delle relazioni tra diritto interno (inteso come insieme di regole prodotte dagli organi dello Stato) e diritto internazionale (inteso come insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati) si basa sul modello dualistico, cioè essi sono collocati su piani paralleli, e la sovranità è incardinata nello Stato e può essere solo limitata da altre organizzazioni. L'Art. 10 prevede l'adattamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, stabilendo che: "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". E' così che automaticamente e in maniera continua, vengono immesse nell'ordinamento italiano fonti di provenienza extrastatuale, senza che sia necessaria una manifestazione di volontà da parte dello Stato Italiano. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute si riferiscono alle consuetudini di diritto internazionale (generalmente riconosciute come vincolanti dagli Stati appartenenti a una comunità internazionale), caratterizzate da comportamenti uniformi tenuti dagli Stati, accompagnati dalla convinzione della vincolatività dei comportamenti tenuti (opinio iuris). Si ritiene che esse abbiano forza costituzionale, cioè queste norme consuetudinarie vengono immesse nel nostro ordinamento ed acquisiscono la forza della fonte che le immette; le leggi italiane che eventualmente contrastassero con tali norme sarebbero incostituzionali (essendo violato l'Art. 10). Le consuetudini costituzionali incontrano il solo limite dei principi fondamentali posti dalla stessa Costituzione.
Adattamento speciale e trattati internazionali
Oltre all' adattamento automatico vi è poi l'adattamento speciale, tramite il quale si immettono nell'ordinamento norme di diritto internazionale pattizzio, cioè trattati internazionali: si tratta di accordi, di natura negoziale, tra due o più Stati diretti a regolare una determinata sfera di rapporti relativi a questi ultimi. Le fasi per la conclusione di un trattato si distinguono nella negoziazione (effettuata da organi dello Stato incaricati), nella firma (sempre da parte di organi dello Stato a ciò incaricati, ma non ancora vincolante per lo Stato firmatario), nella ratifica da parte dell'organo costituzionalmente competente. La competenza a ratificare i trattati internazionali è attribuita dalla Costituzione al Presidente della Repubblica (Art. 87) previalegge di autorizzazione del Parlamento (necessaria allorquando il trattato sia di natura politica o comporti variazioni del territorio nazionale o modificazione di leggi). Una volta concluso, il trattato deve acquisire effetto nell'ordinamento interno, ma le modalità dell'adattamento speciale possono variare in base al trattato: si distinguono dunque trattati:
- Self-executing, che contengono norme chiare e per questo applicabili senza l'ulteriore intervento di una fonte interna di una fonte interna di recepimento; In questo caso l'adattamento avviene tramite l'ordine di esecuzione, che consiste in un semplice rinvio al contenuto di un trattato.
- Non self-executing, prevedono obblighi da raggiungere per lo Stato firmatario e dunque necessitano di atti di esecuzione e di implementazione. Per essere attuati occorrono norme di diritto interno, cioè è lo Stato a scegliere la fonte attraverso la quale eseguire i trattati.
Potestà legislativa e obblighi internazionali
L'Art. 117 ha previsto che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Sentenze Gemelle n.348 e n.349 del 2007: di conseguenza la Corte Costituzionale ribadisce che la legge italiana che contrasti con la legge di ratifica di un trattato internazionale è incostituzionale per contrasto con l'Art.117 della Costituzione. Corte cost. n. 311 del 2009: "l'art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare l'espressione 'obblighi internazionali' in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l'art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost."
Principi dell'Art. 11 della Costituzione
L'Art.11 della Costituzione "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo" esprime 2 principi:
- Principio internazionalista
- principio pacifista, che si estrinseca attraverso la valorizzazione delle organizzazioni internazionali rispetto alle quali lo Stato consente limitazioni di Sovranità: in conseguenza dell'adesione al Trattato Europeo, l'Italia ha quindi ceduto quote della propria sovranità all'ordinamento europeo. Tale cessione ha effetti rilevanti sul sistema delle fonti attraverso il primato del diritto europeo, principio che postula la superiorità delle fonti europee rispetto alle fonti interne.
Il Trattato sull'Unione Europea
Il Trattato che ha dato origine all'Unione Europea (UE) è un trattato internazionale molto particolare: esso differisce infatti dagli altri normali trattati internazionali che si basano sul principio della cooperazione (essendo il loro compito solo quello di facilitare la collaborazione tra gli Stati membri appartenenti all'organizzazione), poiché il Trattato prevede che l'organizzazione possa emanare norme che hanno effetto giuridico all'interno degli Stati membri, si verifica dunque una reale cessione di sovranità da parte degli Stati a vantaggio dell'Unione Europea, sono previste istituzioni che hanno la funzione di controllare la corretta applicazione delle norme comunitarie negli Stati membri e sono previste procedure decisionali per l'adozione delle norme non basate sul principio dell'unanimità. Le radici dell'Unione Europea si ritrovano in ragioni di omogeneità culturale e nella necessità politica di contrapporre un terzo blocco tra il blocco sovietico e gli Stati Uniti.
Origini e sviluppo dell'Unione Europea
Nell'aprile del 1951 fu firmato a Parigi il Trattato istitutivo della Comunità Europea e del Carbone e dell'Acciaio (CECA) tra 6 paesi europei, Francia-Germania-Italia-Belgio-Olada-Lussemburgo, finalizzato alla istituzione di un mercato comune del carbone e dell'acciaio appunto, vietando pratiche che limitassero la concorrenza, nonché qualsiasi forma di discriminazione basata sulla nazionalità. Tuttavia 'istituzione della CECA comportò conseguenze negative, poiché il processo di decolonizzazione gravò sui rapporti tra Francia e Inghilterra. Il 25 marzo 1957 furono firmati a Roma:
- il trattato della Comunità Economica Europea (CEE), finalizzato a realizzare un'unione doganale ed economica, poi politica, per cui si costruisse un mercato unico attraverso la garanzia delle libertà di circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi e dei capitali (le 4 libertà);
- il trattato della Comunità Europea dell'Energia Atomica (EUROATOM), finalizzato a utilizzare l'energia atomica a scopi pacifisti.
Trattato di Maastricht e struttura a pilastri
Sempre nell'ottica di poter giungere ad una progressiva integrazione politica e monetaria, nel 1985 la Commissione pubblicò un libro bianco nel quale erano analizzati gli ostacoli che impedivano la formazione di un grande mercato unico europeo, senza barriere. Nel dicembre del 1991 furono allora gettate le basi per la revisione del Trattato, che fu definita Trattato di Maastricht: fu modificato il Trattato della CEE (rinominato Comunità Europea TCE)e ne fu aggiunto il Trattato sull'Unione Europea (TUE). Il TUE ha dato vita ad una struttura a 3 pilastri:
- costituito dalle comunità preesistenti CEE, CECA, EURATOM
- costituito dalla politica estera e dalla sicurezza comune
- costituito dalla cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale
Rafforzamento e principi dell'Unione Europea
Come rafforzamento del Trattato di Maastricht fu istituita la cittadinanza europea e furono pure rafforzati i poteri del Parlamento Europeo (che esercita poteri di controllo). Il nuovo Trattato si fonda sul principio di sussidiarietà, per cui i poteri appartenenti ad un determinato livello devono occuparsi soltanto delle materie che non possono essere trattate in maniera soddisfacente al livello inferiore: ciò significa che per le materie di non esclusiva competenza comunitaria, le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini (autorità locali o regionali), e solo quando ciò non è realizzabile possono essere adottate a livello europeo. Frattanto il numero degli stati membri dell'Unione Europea raddoppiava, passando da 6 a 15, con l'adesione di Inghilterra-Irlanda-Danimarca-Grecia-Spagna-Portogallo-Austria-Finlandia-Svezia. Occorreva dunque che si adeguasse il meccanismo di funzionamento dell'Unione Europea ad un aumentato numero di Stati: l'obiettivo era quello di modificare ancora il Trattato attribuendogli una funzione costituzionale, in modo che gli atti principali avrebbero dovuto chiamarsi leggi e leggi quadro europee, la rappresentanza esterna dell'Unione avrebbe dovuto essere affidata ad un ministro degli Esteri, doveva essere tratteggiata un'identità comune, doveva essere ricompresa dentro la Costituzione Europea la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione. Il nuovo trattato avrebbe avuto 448 articoli, divisi in 4 parti:
- principi
- carta dei diritti fondamentali dell'unione
- norme sulle politiche ed il funzionamento dell'Unione
- disposizioni generali sulle procedure di modifica e di entrata in vigore del Trattato