La frontiera interna: dal fascismo alle migrazioni internazionali
Documento da Sapienza - Università di Roma su La frontiera interna. Il problema dell'altro dal fascismo alle migrazioni internazionali. Il Pdf esplora il concetto di "frontiera interna" e l'alterità, analizzando il periodo dal fascismo alle migrazioni internazionali attraverso la semiotica, con riferimenti a Lotman e Greimas.
Ver más67 páginas

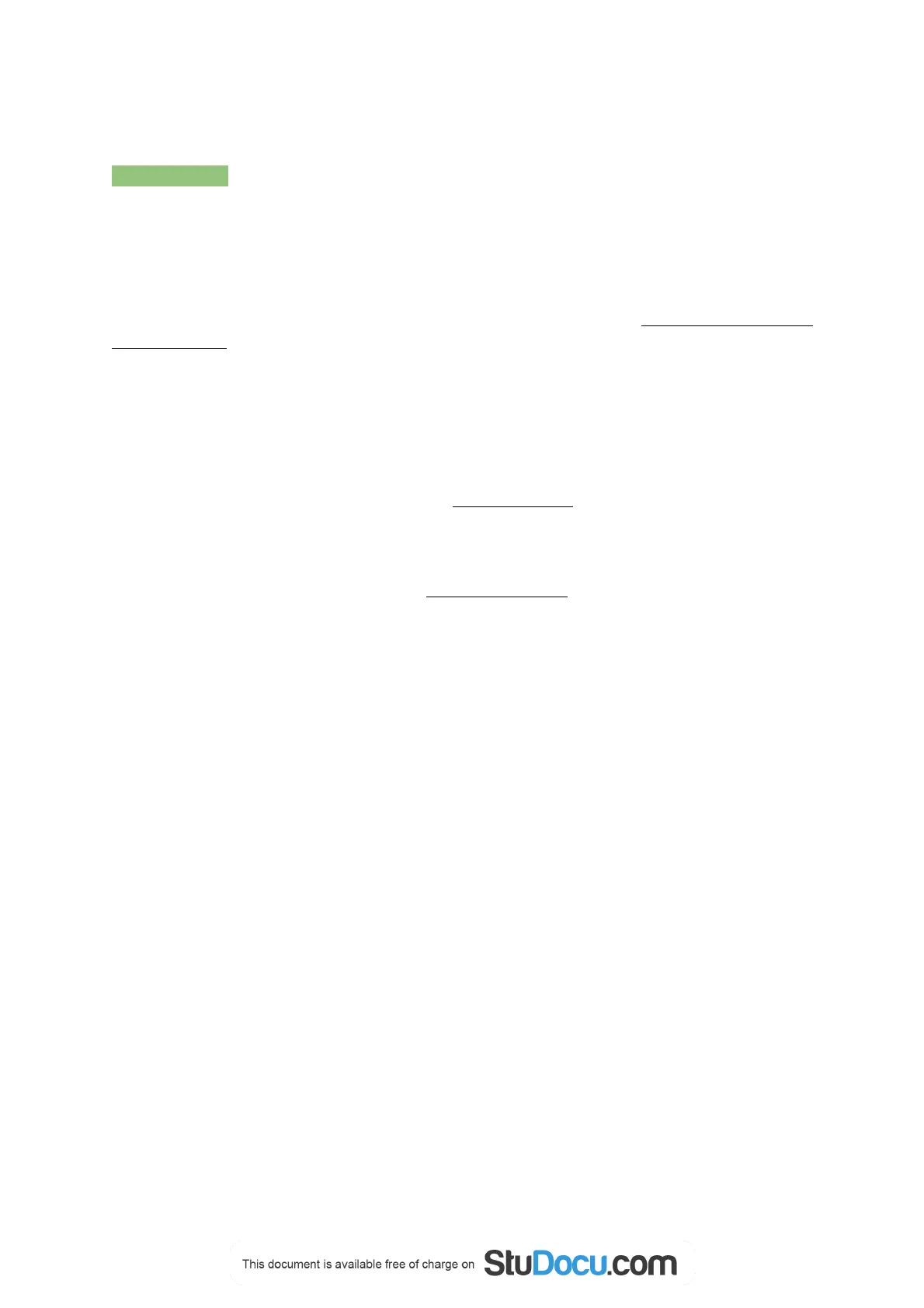
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
StuDocu.com
La frontiera interna. Il problema dell'altro dal fascismo alle migrazioni internazionali - Cervelli Semiotica I (Sapienza - Università di Roma) StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Lilian Ozarenschi (bontakun1q84@gmail.com)LA FRONTIERA INTERNA
CAPITOLO 1
L'identità e i processi di autodescrizione della cultura
Lotman sostiene che ogni cultura ha bisogno di un corrispettivo esterno (extrasemiotico) rispetto al quale differenziarsi e che essa interpreta questa alterità come una sua copia enantiomorfa, cioè come il proprio rovesciamento regolato, o come ciò che non ha alcuna organizzazione. Ma l'aspetto più interessante è che quando un'alterità pronta ad assumere questa funzione relazionale manca, la cultura la inventa, interpretando le strutture organizzate fuori dalla propria semiosfera come "non-strutture", caotiche e amorfe. Per Lotman la cultura si costituisce producendo massa amorfa, attraverso la destrutturazione dell'altro (già semiotizzato).
- Inversione del processo di formatività linguistica delineato da Hjelmslev per cui un linguaggio si produce attraverso la messa in forma di una materia amorfa, massa inarticolata conoscibile solo come sostanza formata.
Il pensiero di Lotman permette alla semiotica di pensare la nascita della cultura come un processo di produzione dell'alterità come differenza regolata. La riflessione di Lotman ha messo in evidenza due forme di alterità: la prima (tipica dei processi di "costruzione dell'altro" del medioevo russo) in cui il rapporto fra cultura ed extracultura si concretizza in un rovesciamento completo. Le due culture si relazionano come opposte: l'una si presenta come l'inversione speculare dell'altra, in modo tale da presentare le stesse particolarità ma invertite. La seconda vede le strutture poste all'esterno della semiosfera come "non-strutture", pura negazione dell'ordine e della regolarità. In realtà ce n'è anche una terza (la più sfumata) che assume una posizione non più di contrario ma di "estraneo vicino". Per Lotman la cultura è contemporaneamente questo dispositivo di allontanamento e avvicinamento e insieme un dispositivo stereotipante. L'aspetto innovativo della concezione lotmaniana della cultura come autodescrizione è che questa autodescrizione è legata all'esterno della cultura, all'identificazione di qualcosa come extrasemiotica. Ma questo extrasemiotico può essere articolato e reso diverso da cultura a cultura: "ogni cultura crea il proprio sistema dei reietti" (Lotman, 1985). La cultura pertinentizza di volta in volta la propria differenza rispetto a diverse forme di alterità che vanno poi a formare il paradigma attraverso cui essa stessa si definisce. L'apparizione della cultura come materia amorfa è intimamente legata non solo ad una auto- immagine della cultura ma all'identificazione di qualcos'altro visto come diverso o come "amorfo", ossia privo di articolazione. L'apparizione di una cultura come sostanza non può avvenire che destrutturando un'altra This document is available free of charge on StuDocu.com Scaricato da Lilian Ozarenschi (bontakun1q84@gmail.com)cultura, la quale viene ad occupare la posizione di extrasemiotico. La strutturazione della cultura la destrutturazione di un'altra sono per Lotman elementi complementari di uno stesso processo. Una cultura si definisce così elaborando una concezione di extrasemiotica funzionale all'immagine di sé che adotta come sistema di autodefinizione performativa. Questa metadefinizione ha capacità di orientare delle pratiche: identifica forme di alterità di cui la cultura ha bisogno per pensarsi come una totalità coerente, organizzata e coesa.
Lo spazio culturale e il concetto di confine semiotico
Inizialmente la dinamica tra semiotico ed extrasemiotico si presentava come una semplice relazione di mutua esclusione. Il confine era considerato come una linea senza spessore, una separazione tra cultura ed extracultura definita all'interno della cultura stessa. Con la riflessione presentata ne La semiosfera questa concezione cambia. La definizione dell'extrasemiotico diventa un processo agito nell'interazione fra culture diverse o nell'azione di una cultura su un'altra. Il confine diventa dotato di un funzionamento specifico: non un concetto astratto, ma un'importante posizione funzionale e strutturale. Il confine è un meccanismo bilinguistico, che traduce le comunicazioni esterne nel linguaggio interno della semiosfera e viceversa. Si sviluppa l'idea di un confine come meccanismo che va attivato. Grazie al processo che il confine permette, l'esterno extrasemiotico diventa ciò con cui il semiotico inizia un problematico processo di "interazione nella differenza". L'inglobamento della differenza si accompagna alla possibilità rischiosa di diventare altro rispetto a sé stesso: qualora l'alterità risulti intraducibile nei linguaggi della semiosfera si può passare dalla trasformazione fino all'"esplosione", L'irruzione dell'extrasemiotico può infatti produrre momenti di "esplosione culturale", quando l'alterità che si inserisce nel sistema non può essere tradotta dai meccanismi del confine (ossia attraverso spiegazioni coerenti con l'episteme - il sapere certo - vigente) ma solo attraverso "esplosioni di metafore". L'introduzione dell'intraducibile ha una funzione opposta a quella visibile ne La semiosfera, in cui si descriveva il processo di produzione e controllo culturale dell'alterità, mentre nel momento dell'esplosione culturale l'extrasemiotico è una "nebulosa di significato" che va tradotta, resa pensabile e dicibile. Il confine cambia così radicalmente funzione e diventa il luogo di quella dialogicità fra sistema culturali diversi che rende secondo Lotman antientropico lo spazio culturale: il punto problematico in cui l'esterno diventa interno.
Figure di confine
Scaricato da Lilian Ozarenschi (bontakun1q84@gmail.com)Nei casi in cui lo spazio culturale acquista carattere territoriale, il confine assume un senso spaziale in senso proprio, e si rivela un meccanismo "cuscinetto". Lotman collega questa assunzione di carattere territoriale dello spazio culturale a particolari "figure di confine" (nel metalinguaggio di Greimas: ruoli tematici relativi a personaggi sociali). Il confine è ben rappresentato anche da figure sociali specifiche, come nella tradizione premoderna erano il boia, il mugnaio o lo stregone, la cui dimora era significativamente posta nella periferia territoriale, al confine fra mondo culturale e mondo mitologico, e che proprio in quanto appartenenti contemporaneamente a due mondi funzionavano come agenti privilegiati della traduzione. Cosa succede quando l'alterità extrasemiotica si inserisce in una semiosfera? L'ingresso degli elementi estranei passa attraverso il confine semiotico che trasforma l'informazione in un blocco di traduzione sui generis, ossia che rende l'alterità pensabile e dicibile nel sistema semantico di una cultura. Come avviene questo inserimento? Assegnandogli una posizione nella retta di differenze e nella scala assiologica (valori morali) della cultura Quale ruolo gioca il modello della cultura di riferimento? L'accento è posto sui metodi di stabilizzazione dell'identità culturale: sono centrali per Lotman i processi di autodescrizione della cultura, che si esprimono attraverso le città capitali.
La città capitale come modello di universo capitale
Per Lotman e Uspenskij lo spazio delle città capitali può costituire una sostanza dell'espressione suscettibile di esprimere l'autodefinizione della semiosfera. Lotman sottolinea come lo spazio urbano, denso di "simbolicità culturali", sia sempre "orientato", ossia costruito secondo il punto di vista di un osservatore (ideale) e al tempo stesso riferito a qualche altro insieme, concreto o astratto ("città celeste" o "città delle origini"), che ne costituisce il modello culturale. La tesi di Lotman è che Mosca e Pietroburgo esprimano due concezioni opposte dello spazio. Mosca è centripeta: organizzata per centri che circondano e tendono al Cremlino ('centro dei centi'), cioè verso l'interno. Pietroburgo è (al contrario) orientata verso il suo esterno, fuori di essa e fuori dalla stessa Russia, verso l'Europa. Il concetto di vettore di orientamento spaziale rappresenta un elemento fondamentale nella semantizzazione delle configurazioni spaziali. Potremmo definire questo concetto come l'operatore che mette in correlazione i due diversi livelli di spazialità (astratta e culturologica) presenti nella riflessione lotmaniana, permettendo una correlazione fra il modello gerarchico assiologico della cultura e "oggetti" storicamente determinati. Lotman mette l'accento non solo sullo spazio empiricamente e fisicamente dato ma sulla sua This document is available free of charge on StuDocu.com Scaricato da Lilian Ozarenschi (bontakun1q84@gmail.com)possibilità di esprimere un modello di spazio culturale. Lotman pone alla base della semiosfera un rapporto traduttivo fondamentale tra linguaggio verbale e modello strutturale dello spazio, indicando come primario non un singolo linguaggio ma la traduzione semiotica fra linguaggio verbale e modello strutturale dello spazio. "La cultura si costruisce sulla base di due linguaggi primari: uno è la lingua naturale, i secondo è il modello strutturale dello spazio. Tutta l'attività dell'essere umano come homo sapiens è legata a modelli classificatori dello spazio, alla divisione di questo in "proprio" e "altrui" e alla traduzione di vari legami sociale, religiosi, politici etc, nel linguaggio delle relazioni spaziali." Il modello strutturale dello spazio appare come una griglia di differenze semantizzabile, pronta a "esprimere" spazialmente le metadefinizioni della cultura espresse linguisticamente. Di tutto questo, l'aspetto interessante: lo spazio sembra costantemente organizzato in sotto- spazi che manifestano ognuno le opposizioni categoriali che organizzano lo spazio culturale ed il suo esterno. Dunque, non c'è mai la possibilità di arrivare a definire un elemento ontologico unitario, atomico. L'unità minima della cultura è, per Lotman, questa duplicità sempre e necessariamente relazionale. Ulteriore riflessione di Lotman: "La divisione dello spazio in "culturalizzato" e "incolto", spazio dei vivi e dei morti, sacro e profano, spazio senza pericolo e spazio che nasconde una minaccia e l'idea che ad ogni spazio corrispondono i suoi abitanti, sono una caratteristica ineliminabile della cultura. Questo tuttavia non basta. Affinché questo sistema risulti capace di compiere funzioni semiotiche, deve possedere un meccanismo di duplicazione reiterata dell'oggetto che costituisce il suo significato. Il mondo della lingua naturale forma una duplicazione del mondo-oggetto e può esso stesso duplicarsi in testo verbali e linguaggi dell'arte verbale organizzati in maniera più complessa". La traduzione intersemiotica tra spazio e linguaggio è esattamente uno dei meccanismi attraverso cui si produce la duplicazione reiterata dell'oggetto di cui parla Lotman, che non è però una semplice riproduzione del significato, ma può anche limitarsi a specifici livelli di significato. L'orientamento culturale non si riduce ad esempio a quello dello spazio costruito, ma riguarda l'inserimento al suo interno di modelli culturali circolanti già attraverso altri linguaggi (in primis quello verbale): la prospettiva lotmaniana ha sempre messo l'accento sull'impossibilità per un linguaggio isolato di accrescere la propria capacità semiotica (producendo nuova informazione). Per questo per Lotman è naturale non separare l'europeizzazione della corte zarista (in cui si adottano stili europei di comportamento quotidiano) e lo spostamento della capitale dell'impero russo con la costruzione di San Pietroburgo in stile italiano. La natura dello spazio culturale è intrinsecamente plurale, per cui esso appare intrinsecamente come una relazione dialogica e potenzialmente contraddittoria rispetto alla stessa autoimmagine della cultura. E' possibile infatti che la cultura sia attraversata al Scaricato da Lilian Ozarenschi (bontakun1q84@gmail.com)