Lo sviluppo linguistico nella seconda infanzia: teorie e acquisizione
Documento sullo sviluppo linguistico nella seconda infanzia, analizzando le teorie di Piaget, Skinner, Chomsky e Bruner. Il Pdf, utile per studenti universitari di Psicologia, esplora l'acquisizione del linguaggio, il ruolo del contesto sociale e le implicazioni dei deficit sensoriali.
Ver más8 páginas
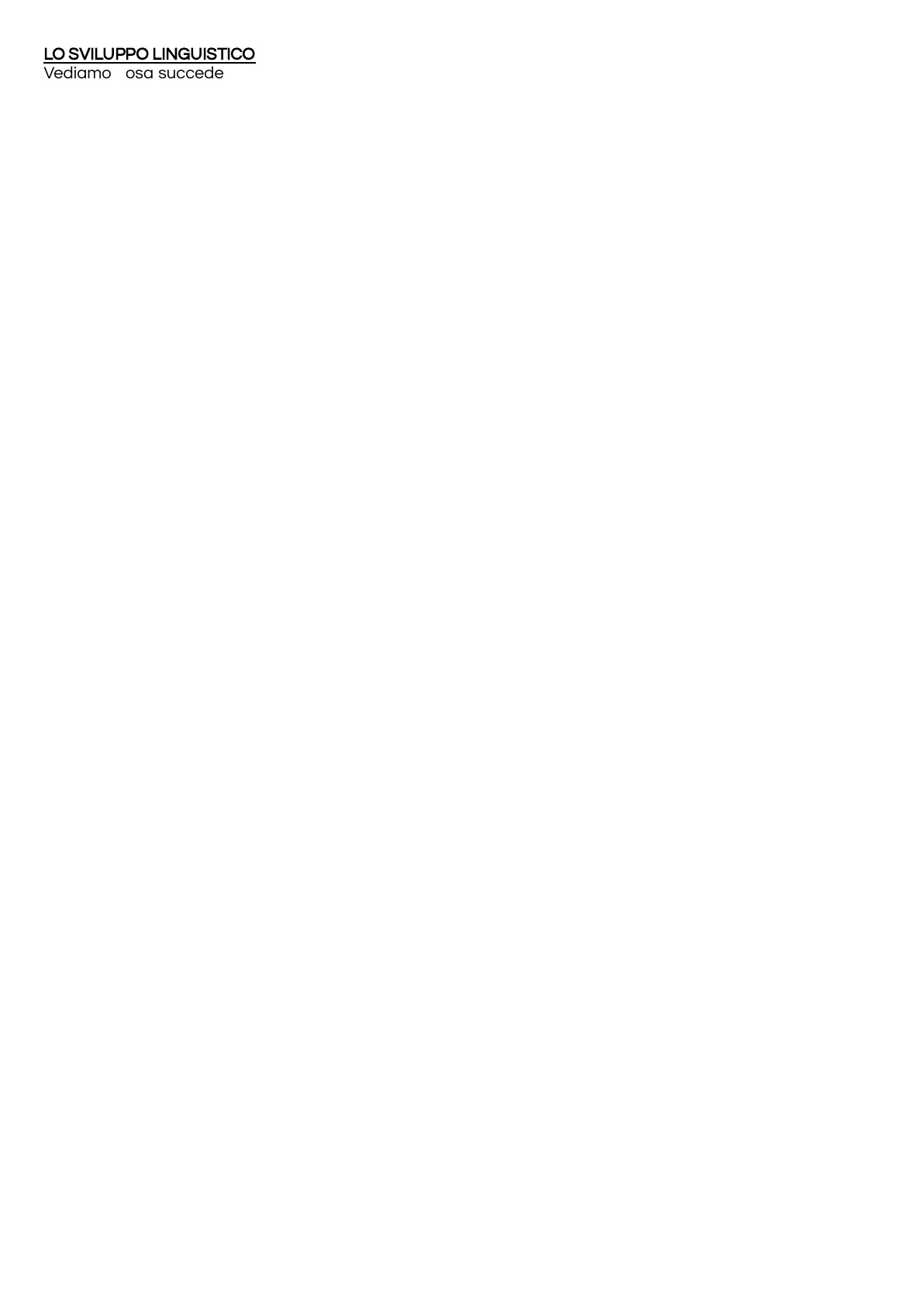
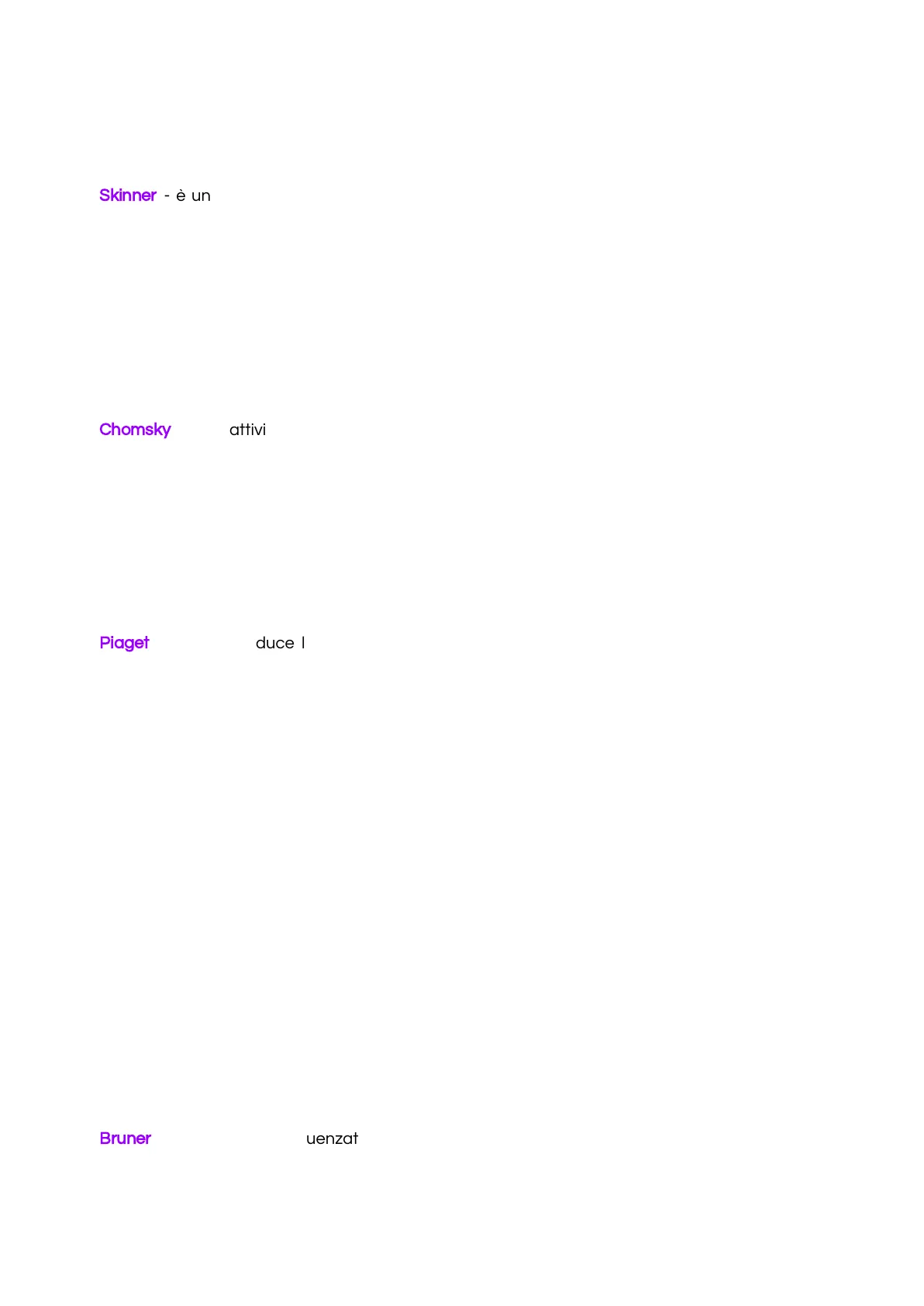
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Lo sviluppo linguistico nella seconda infanzia
Vediamo cosa succede nella seconda infanzia (stadio preoperatorio di Piaget, dai 2 anni ai 7 anni), poi il ruolo che in questo periodo hanno i simboli e i segni linguistici, vedendo quali sono le teorie che hanno permesso a teorici diversi di spiegare in maniera alternativa l'origine del linguaggio. Vedremo la relazione tra sviluppo linguistico e altri fenomeni, come l'attenzione condivisa e il gesto.
La seconda infanzia (2-6 anni)
In questo periodo avvengono, pur in modo graduale, diversi cambiamenti/passaggi che giocano un ruolo importante nello sviluppo infantile. Lo sviluppo linguistico, che può iniziare già da diversi mesi o anche da un anno, inizia a raggiungere una fase combinatoria, quindi mette insieme parole e crea delle piccole frasi, con ritmi più o meno rapidi. In generale, il bambino dai 2 anni in avanti acquisisce una indipendenza di movimento di esplorazione, nell'autoregolazione, nella capacità di separarsi dai genitori che è sempre maggiore e conosce un'accelerazione. Bisogna chiedersi se si tratta di un nuovo stadio o se siano cambiamenti qualitativi importanti.
Per quanto riguarda lo sviluppo fisico, il bambino inizia a mettere i denti da latte, con una dieta che assomiglia a quella adulta. Inizia ad avere un ritmo di crescita fisica un po' inferiore, rispetto ai primi 2 anni di vita, quindi rallenta un po' il processo di crescita. Si modificano le proporzioni del corpo, perché la testa che prima era 1/4 della massa corporea, alzando molto il baricentro intorno ai 2 anni inizia ad occupare il 16% della massa corporea. È anche un periodo di rapida crescita del cervello, che intorno ai 6 anni ha già una massa molto vicina a quella dell'adulto.
Per lo sviluppo motorio, la riduzione della massa grassa di questo periodo rende più semplici i movimenti, il baricentro che si abbassa, insieme allo sviluppo della muscolatura, rende il bambino in grado di correre, lanciare, svolgere azioni di motricità grossa o fine, anche grazie alla maggiore ordinazione sviluppata in questo periodo.
Questo passaggio, dalla prima alla seconda infanzia, secondo Piaget è al centro di un passaggio stadiale, da quello senso motorio, dove il bambino comprende il mondo solo in base alle interazioni sensomotorie che ha con l'ambiente circostante a quello preoperatorio, dove il bambino è già in grado di svolgere operazioni mentali sul mondo, le prime che impara sono quelle che passano attraverso un'attività centrale, che è quella simbolica. Questa funzione che Piaget chiama simbolico-rappresentativa rappresenta l'elemento di discontinuità centrale tra la prima e la seconda infanzia.
Il simbolo e la sua relazione
Il simbolo è qualcosa che sta al posto di qualcos'altro (può essere un oggetto, un pensiero, un suono). Questa relazione può essere di tipi diversi: più o meno stretta o che si stabilisce su uno stretto rapporto di somiglianza, cioè il bambino utilizza la banana come cornetto del telefono, ma non un sasso, perché non ci assomiglia. Più andiamo avanti e più questo rapporto di somiglianza si fa più labile.
- Simboli: oggetto/azione/pensiero usato al posto di un altro
O Relazione -> arbitraria o per somiglianza O Simbolo: tipo particolare di rappresentazione (es. ricordo è una rappresentazione, ma non simbolica), ma ruolo centrale
- Quale dei seguenti esempi rappresentano un segno/simbolo di qualche tipo? Parola, indicazione stradale, bandiera, grido di dolore, fotografia.
Se per Piaget la funzione simbolica è qualcosa di così interessante per le sue implicazioni per lo sviluppo cognitivo e linguistico, questo pone il problema di capire da dove nasce, ovvero come il bambino impara a usare un oggetto rispetto all'altro, impara a giocare facendo finta che un oggetto sia un altro, come un'immagine può rappresentare un altro oggetto, fino a che un suono può significare qualcosa. È un problema di semiotica.
De Saussure distingue significante da significato, cioè quando siamo davanti ad un segno abbiamo qualcosa che sta per qualcos'altro, il qualcosa è il significante e il qualcos'altro è il significato.
Si può distinguere tra una funzione referenziale, dove uso qualcosa per significare qualcos'altro che però è lì, quindi ad esempio uso un gesto per indicare un oggetto, e la funzione simbolica, dove il simbolo vero e proprio rappresenta qualcosa che può non esserci e che può essere non immediatamente osservabile.
Kaye parla di significanti non convenzionali (si basano sulla somiglianza, non richiedono che ci sia una convenzione, non richiedono che io sappia qualcosa, su ad esempio cosa sia una parola, io posso comprendere il significato senza essere a conoscenza della convenzione) e convenzionali (può essere slegato da un rapporto di somiglianza, devo condividere quello schema linguistico o simbolico) da una parte e di significanti indifferenziati e differenziati (non intenzionali e intenzionali) dall'altra.
Apprendimento e interpretazione dei simboli
Come impariamo a capire e a usare i simboli? Le attività, gli oggetti, i comportamenti lasciano dei segni che possono essere interpretati come segni di o simboli di. I bambini aumentano la capacità di interpretare un oggetto, un'azione come segno di qualcos'altro a concetti sempre più astratti e convenzionati.
- Significante -> un oggetto (di qualsiasi tipo) che "sta per" un altro.
- Significato -> un oggetto rappresentato da un altro es. la scopa (significante) che sta al posto del cavallo (significato) nel gioco simbolico
- Condizionamento operante -> processo che rinforza l'associazione tra uno stimolo e una risposta comportamentale
Lo sviluppo del linguaggio: teorie
Per imparare a parlare e comprendere il linguaggio altrui devo conoscere il significato delle parole e sapere come si combinano tra di loro. Queste due dimensioni le possiamo chiamare lessico e sintassi.
Teorie dello sviluppo linguistico
Come si apprende il linguaggio: 4 teorie dello sviluppo linguistiche esemplari:
- Skinner - è un comportamentista moderno, del secondo Novecento, che spiega tutto sulla base del condizionamento operante, a partire dagli addestramenti dei topi e delle colombe. Il condizionamento operante cos'è? Si basa su meccanismi di ripetizione, di associazione, ma è più complicato e ha a che fare con il rinforzo continuo e ripetuto di un comportamento desiderato. Non ci sono solo stimoli, ma si va a rinforzare il comportamento desiderato nel cane, nel topo o nel bambino. Mettono in atto dei comportamenti per addestrare i bambini e sostengono che anche quando non lo facciamo attivamente, il bambino già impara attraverso dei meccanismi di rinforzo, che io manipolo quando metto in atto questi rinforzi. Skinner distingue rinforzo positivo (agisce per addizione, come il cane che fa quello che io voglio e gli do un biscottino) e negativo (agisce per sottrazione, il cane ha un collare un po' scomodo per lui e nel momento in cui fa quello che io desidero glielo tolgo). Secondo Skinner, nel suo libro "Il comportamento verbale", i bambini imparano il linguaggio, a parlare, attraverso i continui processi di rinforzo che sono messi in atto dai genitori, nel momento in cui incoraggiano, premiano i comportamenti desiderati.
- Chomsky - è un attivista dello sviluppo del linguaggio, 1959, non è d'accordo con il condizionamento operante nell'apprendimento del linguaggio, ma ciò che è importante per lo sviluppo linguistico è imparare a mettere insieme le parole, quindi per lui la centralità dello sviluppo del linguaggio sono le regole sintattiche. Attribuisce una centralità al tema della creatività linguistica e vede il bambino come un piccolo scienziato che impara a costruire della frasi più articolate sulla base di un corpus essenziale di regole che chiama LAD (language acquisition device) e che serve/si occupa solo a questo ovvero allo sviluppo del linguaggio e che sia solo negli esseri umani. Quindi noi impariamo a parlare perché abbiamo dentro questo meccanismo innato specifico del linguaggio che ci fornisce le regole basilari della sintassi, e questo ci da la risposta del perché il meccanismo dello sviluppo linguistico una volta iniziato procede velocemente. Quindi il linguaggio per Chomsky è qualcosa che si sviluppa sulla base di un meccanismo innato, pre-determinato, quindi l'ambiente non è ciò che fa apprendere il linguaggio, ma dà dei piccoli contributi al suo sviluppo.
- Piaget - 1970, riconduce lo sviluppo linguistico al raggiungimento di obiettivi di sviluppo generali e cognitivi, ovvero quando il bambino ha raggiunto i culmini del completamento dei processi dello stadio senso-motorio e gli obiettivi evoluti di questo stadio da qui imparerà usare anche la prole come simboli e quindi il linguaggio. - vi sarà la manifestazione della capacità di rappresentazione simbolica. Lo sviluppo linguistico per Piaget è il frutto di raggiungimento di obiettivi continui, di un nuovo livello di organizzazione generale delle competenze cognitive di processi generali (quindi legato allo sviluppo cognitivo) tramutandosi in altre aree diverse e non come diceva Chomsky che era il risultato di meccanismi specifici. Tutto ciò porterà il bambino alla ricerca successiva della coesistenza di aspetti specifici (es. la sintassi) e aspetti a-aspecifici (es. la semantica) nello sviluppo linguistico.
Queste due dimensioni di Piaget e Chomsky, che da un lato è sintattica e da un altro più generico che si basa sulle funzioni simboliche che sono originariamente linguistiche, concorrono insieme per lo sviluppo linguistico.
Chomsky, Skinner e Piaget hanno teorie diverse, ma sono comuni nella ridotta attenzione al contesto sociale. Chomsky vede il bambino come una piccola linguistica, che impara attraverso un processo di sviluppo che mette al centro le sue capacità cognitive partendo da LAD di questo meccanismo innato.
L'importanza dell'interazione sociale
Vygotskij dà importanza all'interazione sociale che è centrale nello sviluppo cognitivo e linguistico. Non c'è lo sviluppo cognitivo e linguistico dopo, ma sono collegate e vanno insieme e vanno a creare delle zone di sviluppo prossimale, quindi delle abilità di apprendimento per il bambino.
Influenza su Jerome Bruner (1975a, 1975b) dove secondo lui i bambini apprendono il linguaggio nel contesto familiare delle interazioni coi care-givers.
Queste teorie si basano sue due aspetti fondamentali; il lessico (legati allo sviluppo generale, cognitivo e in termini di apprendimento sociale e rappresentazione simbolica) e la sintassi (sono specifiche del linguaggio, e la troviamo soli lì e quindi non è spiegabile così facilmente in termini extralinguistici come quello di sviluppo cognitivo), perciò hanno pesi diversi.
Quello che manca però è l'interazione con l'ambiente (Skinner è quello che dà più peso alla dimensione sociale con i caregiver, ma come sorta di addestramento e non vera e propria interazione, ma come un processo più unilaterale dove i genitori agiscono come agenti di rinforzo)
- Bruner - è stato molto influenzato da Vygotskij. Ritiene che i bambini apprendono il linguaggio nel contesto familiare delle interazioni coi caregiver. Le basi dello sviluppo linguistiche vanno ricercate nel contesto familiare. Non solo nel senso superficiale che intende Skinner che i genitori rinforzino e nemmeno nel senso che lui imita e impara per imitazione, quindi non solo i genitori insegnano ai bambini a parlare, ma qui Bruner e Vygotskij ci dicono anche che la struttura sintattica del linguaggio è già contenuta, viene appresa e si sviluppa a partire dalla forma di queste interazioni tra bambino e caregivers. Il meccanismo principale, il primo che secondo Bruner e Vygotskij gioca un ruolo decisivo è