Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, Università Cusano
Documento da Università Cusano su Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione. Il Pdf esplora lo sviluppo socio-emotivo e le relazioni affettive, con focus sulla teoria dell'attaccamento di Bowlby, le emozioni primarie e secondarie, e la moralità, per studenti universitari di Psicologia.
Mostra di più30 pagine
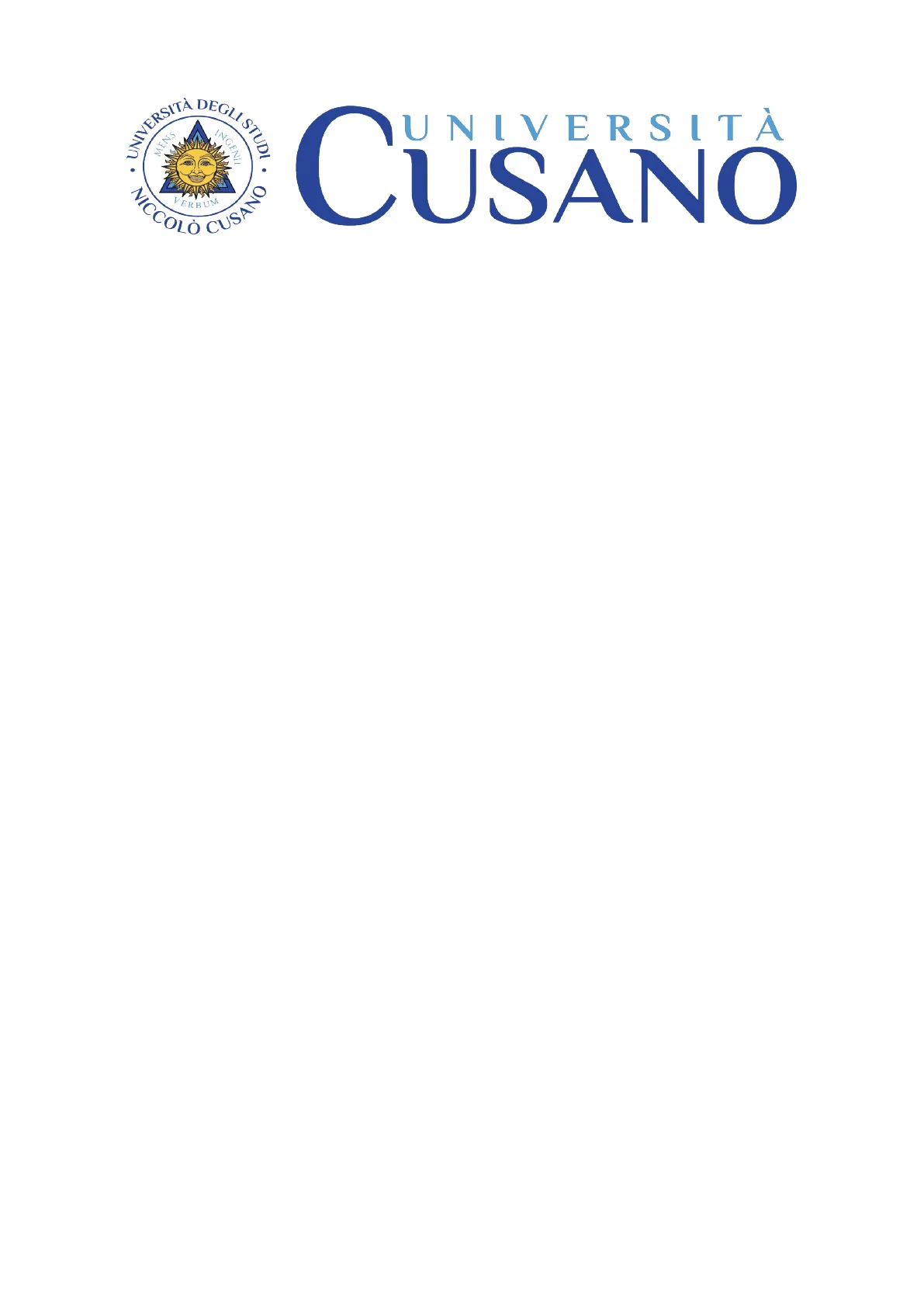

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
DISPENSE DELL'INSEGNAMENTO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
PROF. SSA
MICAELA CAPOBIANCO
RICERCATORE (Lettera B)
(art. 24 c.3-b L. 240/10)MODULO VIII
LO SVILUPPO SOCIO-EMOTIVO E LE RELAZIONI AFFETTIVE: LA TEORIA DELL'ATTACCAMENTO
Argomenti
- VIII. 1 LO SVILUPPO SOCIALE IN UNA PROSPETTIVA MULTIFATTORIALE
- VIII. 2 LA CONSAPEVOLEZZA DI SE' E RICONOSCIMENTO ALLO SPECCHIO
- VIII. 3 LO SVILUPPO DELLE EMOZIONI PRIMARIE
- VIII. 4. LE EMOZIONI SECONDARIE
- VIII. 5 I LEGAMI AFFETTIVI: LA TEORIA DELL'ATTACCAMENTO DI JOHN BOWLBY
- VIII. 6 "STRANGE SITUATION" E STILI DI ATTACCAMENTO
- VIII. 7 LA MORALITA': UN ASPETTO DELLO SVILUPPO SOCIO-EMOTIVO
VIII. 1. LO SVILUPPO SOCIALE IN UNA PROSPETTIVA MULTIFATTORIALE
Il piccolo dell'umo fin dalla nascita vive immerso nei rapporti sociali ed è a contatto con gli altri, con
le regole di comportamento prescritte dal suo gruppo di riferimento, con sistemi di norme che deve
imparare a conoscere, tipiche della cultura di appartenenza. Qualunque aspetto della vita in età
evolutiva, affettivo, emotivo, cognitivo o comportamentale e morale deve essere inserito all'interno
delle dinamiche nei contesti di vita del bambino ed è legato in modo significativo alle prime
esperienze con gli adulti caregiver, alle interazioni con i coetanei, con i fratelli, con le persone che
svolgono un ruolo educativo. La modalità di espressione delle relazioni affettive e il modo di
intendere le norme e i valori morali è strettamente legata al contesto socio-culturale del bambino. È opinione
condivisa che vi sia una stretta connessione tra il mondo delle interazioni e i processi che guidano lo
sviluppo sociale del bambino e le sue competenze morali. Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che la
letteratura scientifica ha ormai abbandonato la teoria del neonato TABULA RASA, per cui il
bambino nasce già con un bagaglio di conoscenze che corrispondono, da una parte al suo patrimonio
biologico dall'altro alle esperienze sensoriali e percettive avute nella vita intrauterina. Già durante lo
sviluppo embrionale e fetale, il piccolo dell'uomo inizia ad elaborare e memorizzare diversi stimoli
che lo aiuteranno ad affrontare la vita extrauterina.
Il termine sviluppo sociale, che sostituisce socializzazione, viene impiegato per rendere chiaro che
il neonato è un essere sociale fin da subito, ma diventa sempre più consapevole e competente
grazie a processi bidirezionali di interazione, tra caratteristiche individuali e caratteristiche del
contesto socio-culturale ed emotivo in cui è immerso fin dall'inizio. Lo spostamento di accento dalla
funzione di modellamento dell'adulto ad una funzione di mediatore o di interlocutore
nell'organizzare competenze e capacità, significa concepire l'individuo come dotato di risorse
proprie, di predisposizioni che lo collegano al mondo circostante. In una prospettiva multifattoriale e
complessa dello sviluppo sociale ed emotivo acquistano importanza sia i prerequisiti biologici sia i
comportamenti sociali che il bambino produce spontaneamente e con cui influenza l'adulto, sia le
relazioni affettive, sia i processi mentali che lo guidano nel produrre azioni e nel valutare fatti e
persone. La dimensione sociale costituisce una chiave di interpretazione
TRASVERSALE dello
sviluppo, una prospettiva dalla quale osservare l'emergere delle competenze affettive, emotive e
relazionali, più che un settore di studio con precisi confini. Schaffer afferma che l'ambito di studio
dello sviluppo sociale riguarda essenzialmente «il modo in cui i bambini interagiscono con gli
altri», vale a dire gli«schemi di comportamento, i sentimenti, gli atteggiamenti e i concetti
manifestati dai bambini in relazione alle altre persone e al modo in cui questi diversi aspetti variano
durante la crescita» (Schaffer 1996)
La capacità di rapportarsi agli altri è strettamente legata alla capacità di inferire, comprendere e
interpretare gli stati mentali altrui. Quando il bambino acquisisce la comprensione di sé e degli altri,la coscienza di possedere un'identità separata dalle altre persone dalle quali può differenziarsi,
sicuramente raggiunge un passaggio fondamentale dal punto di vista sociale ed emotivo. Va da
sé che lo sviluppo della teoria della mente, cioè la comprensione degli stati psicologici e del
comportamento altrui, è un processo che interagisce con lo sviluppo socio-emotivo e si
costruiscono parallelamente (vedi modulo teoria della mente)
VIII. 2. LA CONSAPEVOLEZZA DI SE' E RICONOSCIMENTO ALLO SPECCHIO
Come anche descritto da Piaget nella teoria stadiale, il bambino raggiunge una rappresentazione
stabile di se stesso, come immagine mentale che ha delle caratteristiche peculiari e stabili, solo
dai 18 mesi circa, o meglio tra i 18 e i 24 mesi, proprio perché raggiunge una intelligenza
cosiddetta simbolica che permette al bambino di mantenere in memoria elementi del mondo
fisico e sociale. Ha una intelligenza basata sull'astrazione. In questo periodo, infatti, il bambino
manifesta il GIOCO SIMBOLICO o di FINZIONE, è in grado di utilizzare un oggetto al posto
di un altro (usa una banana e fa finta di telefonare), imita il comportamento dei genitori, fingendo
di scrivere, leggere o di pulire. Inoltre si osserva una
IMITAZIONE in differita, ossia,
mantenendo in memoria sequenze di azioni osservate, può riprodurle in un secondo momento in
modo contestualizzato. E', quindi, una riproduzione di azioni recuperati alla mente in un secondo
momento e non in modo contingente, come può essere con l'imitazione immediata. La
rappresentazione mentale di sé stesso determina una aspettativa relativamente alla possibile
riproduzione di se stesso in foto, nei video o allo specchio. Se questa rappresentazione in foto o
allo specchio non corrispondesse con la propria percezione di sé si avverrebbe una "violazione
dell'aspettativa" e quindi la reazione dovrebbe essere di sorpresa, di non riconoscimento della
propria immagine.
Sul tema della consapevolezza di sé, (Lewis 1990) riprendendo la classica distinzione tra Io e
Me introdotta da James [1882] in ambito filosofico, distingue tra un Sé esistenziale, inteso come
la componente implicita del Sé che organizza l'esperienza, e un Sé categorico, la componente
esplicita del Sé che deriva dall'autoconsapevolezza. Ipotizza uno sviluppo graduale del Sé
esistenziale nel primo anno di vita e ritene che la comparsa di un Sé categorico coincida, intorno
ai 2 anni, con l'autoriconoscimento, e con la capacità di utilizzare alcune semplici categorie
esteriori quali il genere, l'età, il colore dei capelli. In che modo osservando il comportamento del bambino
dai 16 mesi circa possiamo individuare la presenza o meno di una consapevolezza di sé? Infatti, come in tutti i
domini dello sviluppo, anche la comparsa della consapevolezza di sé si presenta in modo ampiamente
variabile tra i bambini all'interno di una finestra che dai 15 ai 24 mesi. Gli indicatori a cui si può far riferimento
per comprendere se un bambino ha raggiunto la consapevolezza mentale di sé riguardano comportamenti
verbali e non verbali all'interno dello sviluppo comunicativo-linguistico. Come discusso nel modulo delleabilità comunicativo-linguistiche, intono ai 18 mesi compaiono nel lessico del bambino forme nominali e,
successivamente, pronominali per riferirsi a se stesso e agli altri. Ad esempio si chiede al bambino come si
chiama e lui/lei risponde con il proprio nome o prenome. In generale fa riferimento a sé utilizzando il nome o il
prenome. Successivamente nel repertorio lessicale compaiono i pronomi e il bambino utilizza parole come
"io", "mio", "tu". Intorno ai 18 mesi compare anche il gesto deittico dell'INDICAZIONE DI PERSONA
quando il bambino si riferisce a se stesso indicandosi mantenendo lo sguardo sulla stessa linea di quello
dell'adulto. L'udo dell'indicazione di persona è un ulteriore indice di presenza della consapevolezza di sé
anche quando il bambino non ha ancora un lessico ricco e non utilizza i pronomi. Un altro aspetto tipico da
osservare nel bambino è il riferimento alle sue diverse parti del corpo. Un bambino che ha raggiunto la
consapevolezza di sé, infatti, è in grado di rispondere alle domande su dove si trovano il suo naso, le sue
braccia, i suoi capelli etc, mostrandoli all'adulto in modo chiaro. L'uso dell'indicazione e la discriminazione
delle sue parti del corpo sono aspetti relativi al comportamento non verbale che denotano la presenza
dell'autoriconoscimento.
Lewis e Brooks-Gunn (1979) hanno usato un paradigma di ricerca denominato ROUGE TEST o
PROVA ALLO SPECCHIO, già impiegato con gli scimpanzé (Gallup 1970) e divenuto ormai
standard, che consiste nell'applicare una macchia rossa sul naso del bambino senza che egli se ne
accorga e nel controllare come reagisce alla sua immagine allo specchio. Se il bambino, alla
vista casuale dell'immagine allo specchio, tocca il proprio naso e cerca di cancellare la macchia su
se stesso, vuol dire che è consapevole non solo che il viso nello specchio è suo, ma anche che la
macchia viola lo schema mentalmente rappresentato che si è costruito del proprio viso.
Mentre tra i 9 e i 12 mesi, pur guardando con interesse la propria immagine allo specchio, i
bambini non si toccano il naso oppure cercano di cancellare la macchia sullo specchio non attribuendola a loro
stessi, tra i 15 e i 18 mesi cominciano a farlo in una percentuale oscillante tra il 19 e il 25% e,
tra i 21 e i 24 mesi, portano la mano al proprio naso nella gran parte dei casi.
La consapevolezza di sé, in breve, comincia ad apparire intorno ai 15 mesi circa (tra i bambini in cui
compare più precocemente) e accomuna gran parte dei bambini di età compresa tra i 21 e i 24 mesi.
Questa abilità, verificata ulteriormente non solo dal vivo ma anche attraverso l'uso di filmati e fotografie che
escludono la presenza di segnali contingenti, legati alle circostanze o a situazioni specifiche, conferma che, intorno
al secondo anno di vita, l'autoriconoscimento avviene in base a segnali legati alla percezione stabile della
propria identità fisica. Per fare ciò il bambino deve avere una INTELLIGENZA RAPPRESENTATIVA.