Epiteli sensoriali: tatto, gusto e olfatto, ghiandole esocrine
Documento da Università su epiteli sensoriali: tatto, gusto, olfatto e ghiandole esocrine. Il Pdf, un utile strumento per lo studio della Biologia a livello universitario, esplora le strutture recettoriali e le modalità di secrezione ghiandolare, arricchito da immagini esplicative.
Ver más14 páginas
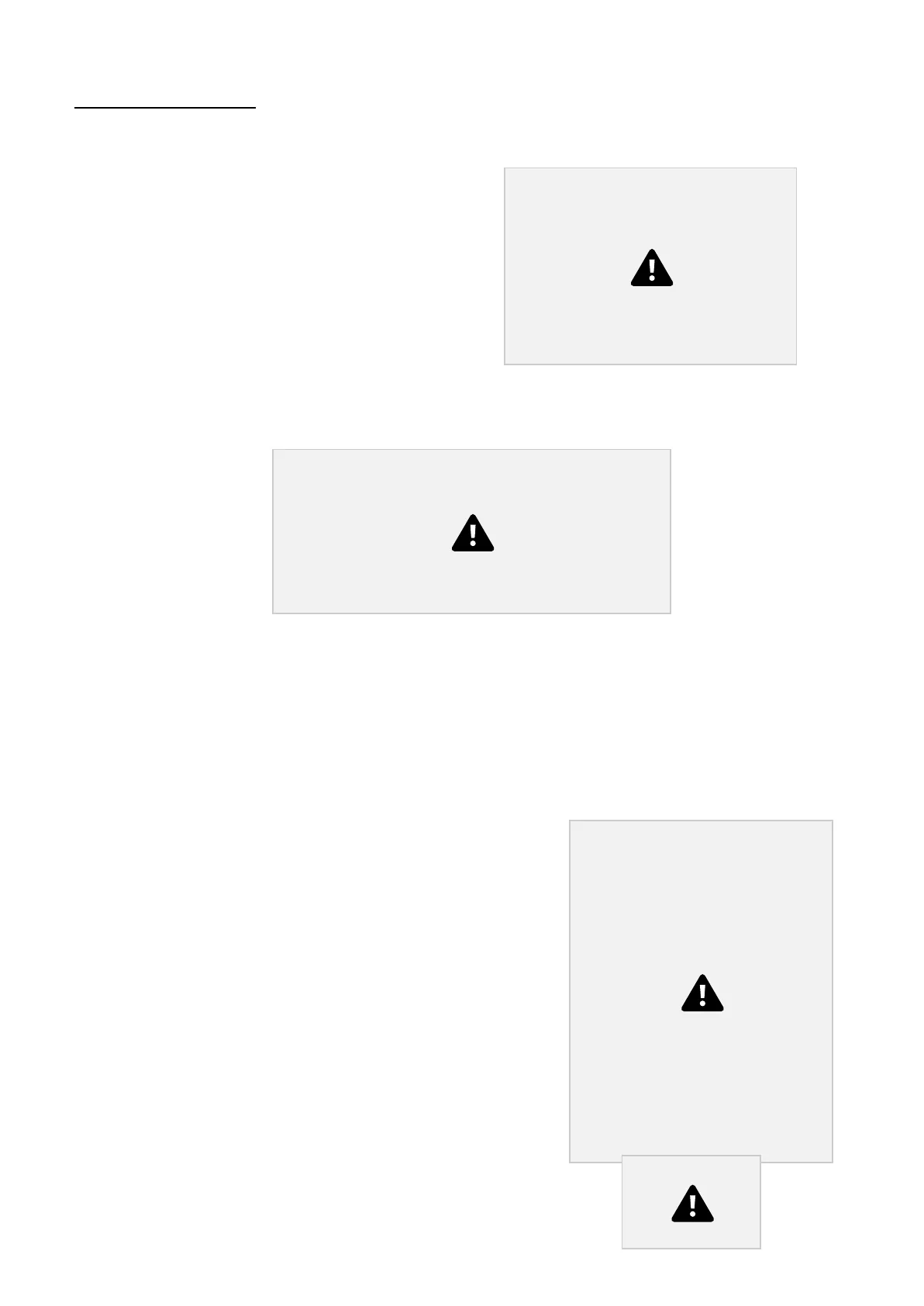
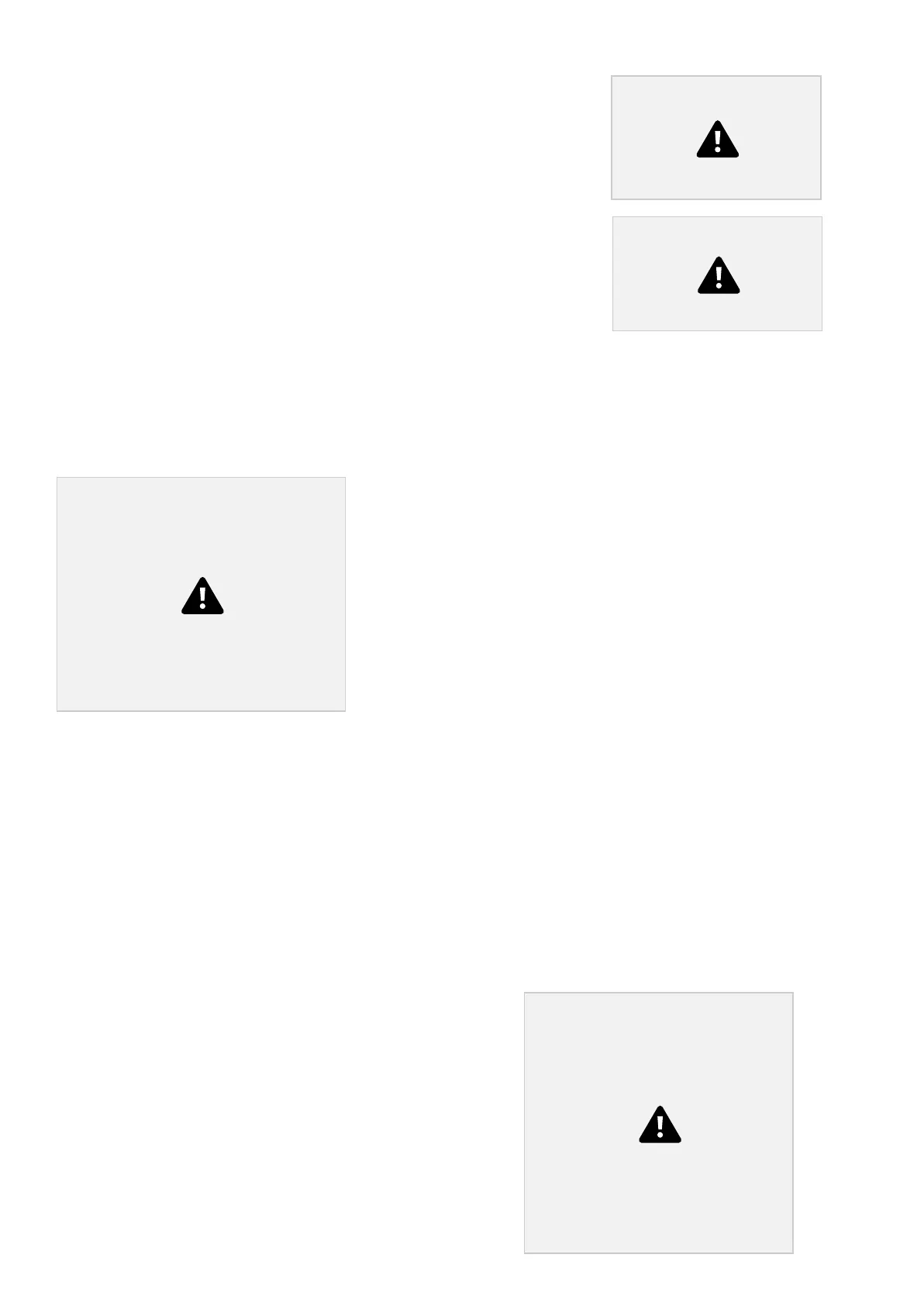
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Epiteli Sensoriali
Il Tatto
La sensorialità del tatto non è assicurata solo dalle cellule di Merkel, ci sono dei sistemi che stanno sotto, nel derma (connettivo), che svolgono questa funzione. Alcuni sono vicino all'epidermide, come i corpuscoli di Meissner. Altri sono sempre più in profondità, come i corpuscoli di Ruffini e di Pacini. Più sono in profondità, quindi lontani dal punto in cui si deve ! raccogliere l'input, più sono deputati a sentire un tatto grossolano, mentre più sono in superficie, come le cellule di Merkel, più sono in grado di comunicare quello che è un tatto molto fine. Ci sono anche delle terminazioni nervose libere, che non si associano alle cellule sensoriali, ma che entrano nell'epidermide per sentire ad esempio il dolore o il cambio di temperatura. 12 !
Nella figura si vede come le cellule sono a contatto con i fasci nervosi che poi arrivano al midollo spinale (il quale raccoglie sia i fasci afferenti che efferenti). Dall'epidermide quindi si ha comunicazione con il sistema nervoso centrale. Gli elementi sensoriali sono sempre di natura epiteliale ma non sono solo quelli tattili. Ci sono anche gli altri sensi:
- il gusto, l'olfatto, la vista e l'udito;
Il Gusto
Il gusto viene percepito a livello della lingua, nelle papille gustative. Esse hanno delle cellule sensoriali che riconoscono cinque diversi tipi di gusti (dolce, salato, acido, amaro e umami che corrisponde al glutammato, quindi al "saporito") e sono dei chemiocettori. Devono avere dei recettori o dei sistemi di captazione di molecole solubili disciolte nella saliva. Quindi anche queste cellule possiedono una membrana apicale con delle specializzazioni di membrana, arricchite da sistemi di trasporto e di recezione per queste molecole per massimizzare la funzione. Esistono diversi tipi di papille. La maggior parte sono deputate alla chemiorecezione e quindi sono chemiocettori. Esistono anche le papille filiformi, che si chiamano così per la forma allungata e sono prive della capacità di chemiorecezione ma hanno la sola capacità di recepire il movimento, hanno funzione tattile e quindi sono meccanocettori. Le altre papille gustative vere e proprie si dividono a seconda della forma in:
- Circumvallate: hanno un avvallamento laterale in cui troviamo, sotto ! !l'epitelio, strutture a forma di bulbo che sembrano andare a sfociare nel lume;
- Fungiformi: a forma di fungo, strutture con un avvallamento laterale e una parte che protrude. Sono raccolte in solo alcuni punti della superficie con funzione sensoriale;
! !
- Foliate: strutture a tulipano. Le cellule si associano sfociando in una sorta di poro ed esprimono i microvilli per massimizzare la capacità di sentire gli elementi del gusto (PAG. 15, LEZIONE 4, SBOBINA SECONDO ANNO).
! Ciò che conta per ognuna di queste strutture anatomiche è che all'interno di ognuna di esse, che fanno stazionare la saliva nello spazio laterale, ci sono i calici gustativi, che possiedono le cellule epiteliali sensoriali. Hanno forma a tulipano fatto di "petali", i quali corrispondono alle cellule. Alcune le cellule sono lunghe e arrivano al polo in cui arriva la saliva e hanno la membrana apicale ricca di microvilli per avere la massima capacità di raccogliere la molecola disciolta nella saliva che dà il gusto. Poi ci sono le cellule di supporto che danno il turnover in basso ma il tutto deve essere agganciato ad una fibra nervosa che comunichi ciò che la cellula ha sentito. I calici gustativi sono facilmente riconoscibili ma non si capisce cosa sentono, per cui c'era l'ipotesi che certi tipi di gusti si sentissero solo in determinate aree della lingua ma questa teoria non è stata confermata. C'è chi dice che in un calice gustativo, indipendentemente da quella che è la papilla che prendiamo in considerazione, ci sono tante cellule con i microvilli che sono diverse tra loro e possono essere in grado ognuna di esse di sentire qualcosa di diverso. Quindi ad esempio sono in grado di percepire il salato, ovvero il cloruro di sodio e quindi ci sarà la capacità di recepire il sodio, per il dolce, ovvero lo zucchero, ci sarà il trasportatore di glucosio, ecc ...
L'Olfatto
L'olfatto è simile al gusto ma la differenza fondamentale è che le molecole captate non sono in un fluido ma nell'aria. La similitudine è che le cellule (colorate in giallo) hanno una parte apicale con una specializzazione di membrana che si chiama ciglia. La sua funzione è avere i recettori per le molecole odorose. Queste cellule non finiscono appoggiate su una fibra nervosa ma sono loro stesse a continuare e a entrare a far parte del bulbo olfattivo. Quindi in realtà sono dei neuroni. Sono cellule epiteliali con origine neuronale. Sono dei neuroni bipolari che però hanno un vantaggio che li rende simili agli epiteli, ovvero ricambiano. Per cui, ad esempio, chi ha avuto il !COVID e ha avuto per un certo periodo l'incapacità di sentire gli odori, poi gli è tornata, grazie alla rigenerazione di queste cellule. Anche per l'udito ci sono cellule con le ciglia che devono sentire, non causare, il movimento di un fluido.
L'Udito
Nell'orecchio ci sono due parti che hanno molto in comune nel loro modo di funzionare, ma in realtà servono a due cose molto diverse: l'orecchio interno (nell'immagine) comprende un'area che si chiama coclea, di cui si nota la forma a Figura 45.6 Struttura e funzione dell'orecchio umano. La structura dell'orecchio ursino à mostrata nel successivi ingresdimenti the me illusrano ke parti funzionali pla e a d). Le onde sonore che pususo soraverso il canale vurimulase producono vibrazioni della membrana chiocciola, e una zona fatta da (la Santra ovali). Questa sinsine cura delle onde di persone sol Buido che si trons poi canali vestibolari e del timpano della corles. canali semicircolari. Queste @wwwwwwwpig\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\ \ due parti sono connesse ma hanno funzione diversa:
- la coclea e il fluido che scorre in questa struttura cava sono deputati al senso dell'udito;
- i tre canali semicircolari (zona collocata più in alto) sono deputati alla sensazione di equilibrio, di cui assicurano la percezione insieme al cervelletto.
In entrambi i casi è presente una struttura ossea, in particolare nella coclea è cava e circondata da tessuto osseo e al centro scorrono dei fluidi che vanno a bagnare e movimentare delle ciglia presenti sulle cellule ciliate, le quali risentono del movimento del fluido. Il sistema che movimenta è quello che prevede i tre ossicini: martello, incudine e staffa, che si muovono quando le onde sonore arrivano al timpano e da lì si crea un movimento a certe lunghezze d'onda che dall'aria viene trasmesso a un liquido. Il liquido che scorre nella coclea va a spostare le ciglia, ossia la parte apicale di cellule connesse con dei sistemi nervosi (nervo acustico), che agiscono come abbiano visto nel caso del tatto, come bottoni sinaptici. Una situazione analoga, ossia di flusso e movimento, è presente anche nell'apparato deputato all'equilibrio, in cui i tre canali circolari si presentano in una zona a forma di ampolla, nella quale ci sono cellule con delle ciglia che risentono di un movimento creato, anche in questo caso, dal fluido. Infatti, i canali sono tre perché risentono della posizione del capo Figura 45.10 La strumasa dei canali sereicircolari. La poisione dri rurali semicircolari in soluzione al resto dell'orecchio insenso. e. Lingredients di una reclow anpolice nel piano di uno dei canali semicircolori cana il giogamento della cupola. 1 Ampula - Gokuks di supporti - Novo acustico Finestra ovale Murillo Codes- Finestra notanda Tuba di Bankochie- oul corpo Fiuso del'ondirty rispetto ai tre assi cartesiani (x, y, z), inoltre sono disposti a 90° l'uno rispetto all'altro per rappresentare i tre vettori. Il fluido in questo caso è più denso rispetto a quello che scorre nella coclea, poiché al suo interno sono presenti in sospensione delle particelle chiamate otoliti, deputati proprio a dare una certa densità; quando Inibizione ++ Eccitazione Stareaciglia Celula cillatasi spostano in maniera non fisiologica causano le vertigini (in questo caso vengono rimessi al loro posto dall'otorino o dall'osteopata tramite movimentazioni del capo affinché si possa riavere una sensazione di equilibrio corretta). Sia le cellule della coclea sia quelle dell'apparato vestibolare espongono sulla membrana apicale estroflessioni di ciglia disposte a gradoni, in maniera crescente, così da risentire del flusso in base alla sua lunghezza d'onda. Muratori, Sedrati, Summer ISTOLOGIA (Maraldi) Lezione 5 31/10/2024 1 Questo movimento delle ciglia è una modificazione meccanica della cellula e si riflette al suo interno con entrata e uscita di ioni messaggeri e va a cadere, essere tradotto, verso la membrana basale dove prende contatto con una fibra nervosa.
La Vista
La vista è un tipo di ricezione che si basa sulla captazione dei fotoni e questa ricezione avviene in una zona dell'occhio posteriore, retrostante. Guardando l'immagine, la luce entra e va a sbattere sul fondo dell'occhio in cui trovano radunati vari strati cellulari sovrapposti. Alcuni di questi strati sono fatti di cellule che recepiscono gli input; gli altri fanno da mediatori che comunicano a scala fino al nervo ottico. Nell'ultimo strato in fondo, che combacia con una zona di nome coroide, si trovano i coni e i bastoncelli: due tipologie cellulari deputate rispettivamente a ricevere i colori e l'intensità della luce; inoltre hanno in comune tra loro similitudini nel corpo cellulare:
- Nucleo;
- Zona basale, che deve prendere contatto con i neuroni per la ricezione;
- Strozzatura che porta alla zona apicale.
Bastoncello Ciglio di connessione Terminale sinaptico Segmento interno Segmento estemo Nucleo Mitocondid Dischi di pigmenti Cono Figura 45.18 Bastoncelli e coni. Il segmento più esterno contenente i pigmenti di ciascuna di queste cellule è separato dal resto della cellula da una sezione in cui è ospitato solo uno stretto canale, il ciglio di connessione. orizzontale Cellula Assoni amacrina al nervo ottico Luce Cellula Cellula Cono gangliare bipolare Coroide Bastoncelo Figura 45.20 La struttura della retina. Nota che i bastoncelli ed i coni si trovano nella parte posteriore della retina. La luce passa attraverso altri quattro tipi di cellule (gangliari, amacrine, bipolari ed orizzontali) nella retina prima di raggiungere bastoncelli e comi. Una volta attivati i fotorecettori, esi stimolano le cellule bipolari, che a loro volta stimolano le cellule gangliari. Il flusso dell'informazione nella retina risulta così opposto alla direzione della luce. La zona apicale nei bastoncelli è più estesa e allungata, mentre è a cuneo nel caso dei coni. Tale zona (in arancione nell'immagine sopra) è formata da segmenti esterni: tante membrane che si ripiegano e susseguono come dei dischi impilati. Servono perché in quella zona vanno a posizionarsi le componenti sensibili (gli elementi recettoriali) all'energia della luce. La professoressa sottolinea che la componente biochimica non verrà approfondita. L'informazione recepita viene poi comunicata a dei neuroni e a cellule bipolari sottostanti che sono posti in strati di diverso tipo, in tanti intermedi, fino a giungere al nervo ottico.