Emostasi e coagulopatie emorragiche ereditarie: emofilia e von Willebrand
Documento universitario sull'emostasi e le coagulopatie emorragiche ereditarie. Il Pdf esplora il sistema emostatico, le sue fasi e il ruolo dell'endotelio, concentrandosi poi su emofilia A e B e malattia di von Willebrand, con dettagli su caratteristiche cliniche e diagnosi.
Ver más21 páginas
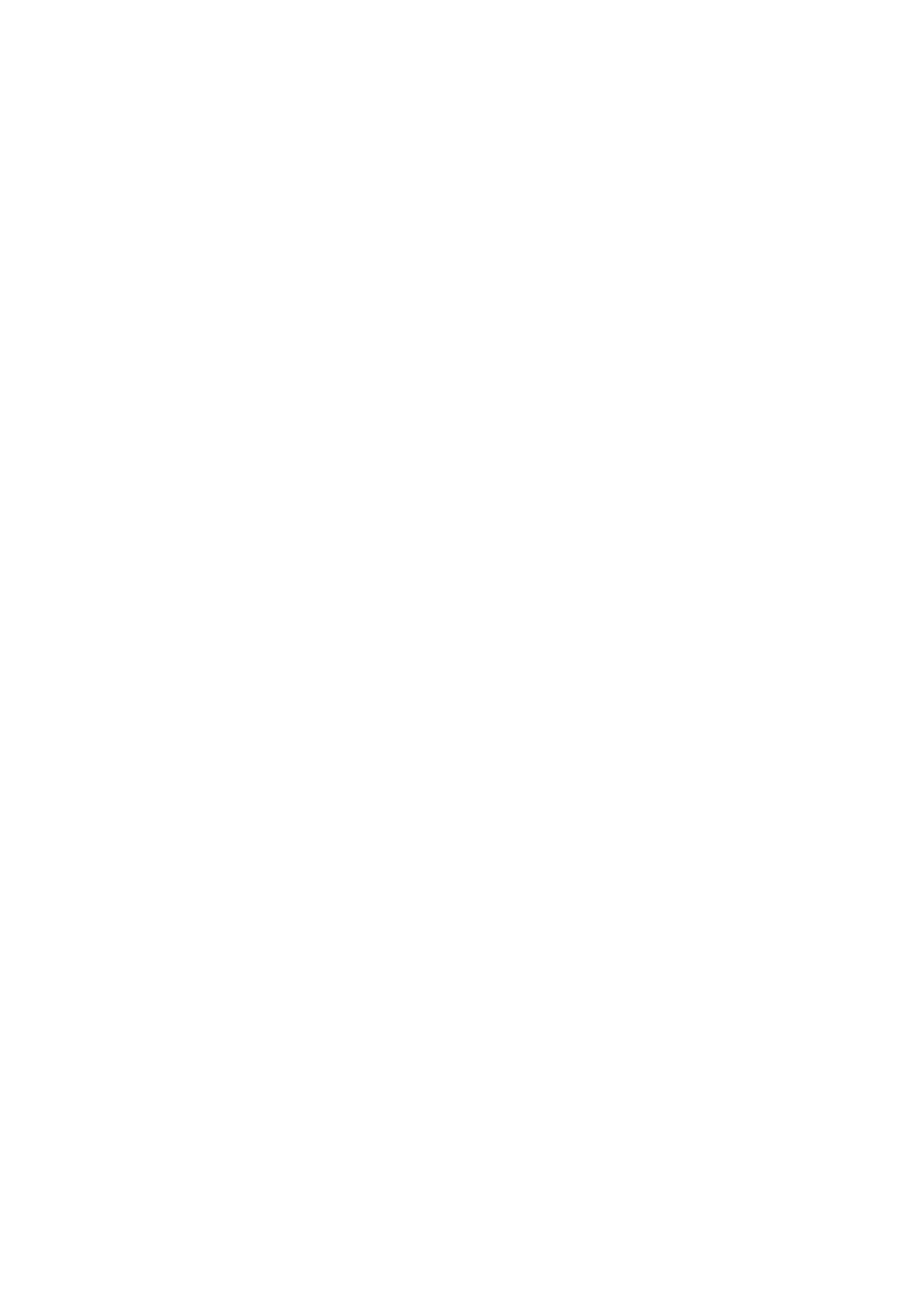

Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Lezione e Argomento
Lezione nº 21 patologia II 20/05/21 Sbobinatore: Giuseppe Arpinelli Docente: Laura Conti Argomento: Emostasi
Sistema Emostatico
La funzione del sistema emostatico è molto importante; serve per prevenire la perdita di sangue, per fermare emorragie, ma al contempo la sua funzione è quella di mantenere il sangue in uno stato fluido per prevenire la trombosi. È uno dei sistemi fisiologici principali e più complessi e anche più antichi ad essersi sviluppato. Alla normale funzionalità del sistema concorrono cellule e proteine plasmatiche che si attivano di volta in volta in una reazione a cascata, subendo l'azione di diversi inibitori. Il sistema emostatico non interviene solo nelle situazioni fisiopatologiche, quali le emorragie e gli eventi trombotici, ma interviene anche in maniera importante nei processi di flogosi e nei processi neoplastici.
Il paziente neoplastico ha come complicanza importante l'evento trombotico, che si presenta nelle autopsie nel 50% dei casi esaminati.
La funzione è di proteggere l'integrità dell'albero vascolare e di limitare le perdite ematiche in sede di lesione.
L'emostasi è regolata per essere attiva localmente e puntualmente nella sede in cui si è verificata la lesione, evitando così una coagulazione massiva.
Chiaramente tutte quelle che sono le alterazioni congenite e acquisite della coagulazione possono comportare da una parte disordini emorragici, se riguardano i fattori della cascata coagulativa, e dall'altra disordini trombotici, se riguardano invece gli inibitori fisiologici della coagulazione.
È un processo che può avvenire spontaneamente e viene suddiviso in 4 fasi.
- Fase vascolare
- Fase piastrinica
- Fase coagulativa
- Fase fibrinolitica
Fase Vascolare
Si attiva immediatamente per evitare la perdita di sangue con la vasocostrizione che avviene mediante la contrazione delle cellule muscolari lisce. Interviene anche il riflesso neurovegetativo vaso motore dei nerva vasorum e contemporaneamente le cellule endoteliali, che avranno un ruolo fondamentale nel processo di regolazione dell'emostasi, secernono endoteline e sostanze vasocostrittrici.
Emostasi Primaria
È costituita dal processo di formazione di un primo tappo emostatico instabile, detto trombo bianco, grazie all'adesione e all'aggregazione delle piastrine in corrispondenza della sede della lesione vascolare.
Emostasi Secondaria
Dobbiamo rendere stabile questo coagulo e quindi abbiamo l'attivazione del sistema della coagulazione che porta alla stabilizzazione del tappo emostatico con le trame di fibrina; successivamente avviene la retrazione del tappo emostatico e la deposizione dei leucociti con l'inizio del processo infiammatorio e la riparazione del danno vascolare.
Fase Fibrinolitica
Una volta che il danno vascolare è riparato avviene la dissoluzione del coagulo ad opera di un enzima plasmatico inattivo, il plasminogeno che convertito in plasmina determina la digestione dei filamenti di fibrina in frammenti solubili.
Ruolo dell'Endotelio
L'endotelio ha un ruolo importantissimo nel modulare la risposta del sistema coagulativo. Questo perché fisiologicamente il nostro endotelio ha funzione anticoagulante e antiaggregante che si manifesta in assoluto con l'espressione degli eparan-solfati, attivatori dell'antitrombina III e del sistema proteina C e proteina S, e con il meccanismo fibrinolitico in quanto produce il t-PA.
Le cellule intatte, non attivate quindi, esprimono un'attività anti aggregante, anticoagulante e fibrinolitica. Quando c'è un danno invece l'endotelio esprime le proprietà pro-coagulanti che si manifestano con l'attivazione del processo emostatico. C'è sempre una sorta di equilibrio fra l'attività anticoagulante e quella pro-coagulante dell'endotelio.
Ma in primis la funzione più importante che esso svolge è quella anti-aggregante, in quanto le cellule endoteliali e le piastrine hanno le stesse cariche negative e quindi si respingono. Grazie all'espressione di una glicoproteina, la trombomodulina, abbiamo l'espressione e l'attivazione dell'importante complesso proteina C e S. Allo stesso tempo ha un'attività fibrinolitica, in quanto produce il t-PA, l'attivatore tissutale del plasminogeno che favorisce la fibrinolisi.
Quando c'è un danno l'endotelio esprime proprietà pro-coagulanti; a questo punto le piastrine aderiscono alla matrice extra-cellulare aderendo quindi al collagene sottostante. Processo che viene favorito dal legame al fattore von Willebrand (vWF) che è prodotto dalle cellule endoteliali. Ogni volta che c'è un danno le cellule endoteliali producono il Tissue factor che è il principale attivatore della cascata coagulativa. Contemporaneamente le cellule endoteliali secernono invece il PAI-1 che è l'inibitore dell'attivatore tissutale del plasminogeno. Non hanno dunque solo attività procoagulante ma anche antifibrinolitica facendo sì che il coagulo rimanga più a lungo.
Emostasi Primaria: Le Piastrine
Le piastrine sono frammenti citoplasmatici, privi di nucleo, di una cellula midollare progenitrice, il megacariocita. La piastrinopoiesi è regolata dalla trombopoietina, prodotta principalmente dal fegato, che induce la produzione e la maturazione delle piastrine agendo anche a livello dei precursori e quindi a livello midollare. Anche l'IL-11 possiede un'attività trombopoietica. La produzione delle piastrine può aumentare notevolmente, anche di 7-8 volte, in seguito all'attivazione del sistema emostatico o alla stimolazione del midollo a causa di una piastrinopenia periferica indotta dalla distruzione delle piastrine. Le piastrine più giovani appena immesse in circolo sono più grandi di quelle mature ma man mano che maturano diventano sempre più piccole. Quindi quando abbiamo una riduzione delle piastrine periferiche, che individuiamo con una conta, dobbiamo pensare sempre se questa sia dovuta ad una distruzione periferica oppure ad un danno midollare. Nel caso di distruzione periferica, quando il midollo è capace di produrle, le piastrine in circolo saranno di grandi dimensioni, indice di corretto funzionamento del midollo.
Nel caso in cui in pronto soccorso dovesse arrivare un bambino con una piastrinopenia importante e le piastrine in circolo dovessero essere piccole, questa potrebbe essere la prima sintomatologia clinica per una leucemia o un danno midollare importante.
Le piastrine sopravvivono circa 10-12 giorni (emivita di 5/6 giorni), e questo è proprio il motivo per cui quando si deve intervenire nei pazienti sotto terapia antiaggregante con l'aspirina, questa deve essere sospesa una settimana prima per far si che tutte le piastrine in circolo eliminino l'effetto antiaggregante. Successivamente queste vengono sequestrate dalla milza e dal fegato dove vengono distrutte. I pazienti con trombocitopenia idiopatica autoimmune, in cui si ha una distruzione delle piastrine dovuta ad anticorpi, venivano splenectomizzati dopo conferma tramite scintigrafia splenica proprio per togliere l'organo in cui venivano distrutte le piastrine. Molto spesso questi pazienti presentavano un epato-splenomegalia.
È importantissimo considerare che ci possono essere alcune volte nelle conte piastriniche delle pseudo-trombocitopenie, che in realtà non si accompagnano mai ad un quadro clinico emorragico. Osservando lo stesso campione al microscopio si vede come le piastrine siano presenti ma sottoforma di aggregati piastrinici.
Questo è il classico quadro della pseudo-trombocitopenia da EDTA, dove il calcio presente nell'anticoagulante della provetta dell'emocromo fa sì che ci sia l'aggregazione.
Quindi è opportuno valutare, in assenza di un quadro emorragico, lo striscio di sangue del campione per vedere se si è di fronte ad una pseudo trombocitopenia.
Pseudotrombocitopenia da E.D.T.A.
Le piastrine durante il processo di formazione del coagulo cambiano la loro morfologia, perdendo la forma rotondeggiante ed emettendo gli pseudopodi. In seguito al danno vascolare le piastrine vengono esposte al sotto endotelio, quindi al collageno e alle altre componenti della matrice (fibronectina, proteoglicani e glicoproteine) venendo in questo modo attivate.
La risposta della piastrina è dovuta ad un intervento coordinato della membrana, del citoscheletro e dei granuli. Una volta attivate le piastrine cambiano la loro forma, emettono gli pseudopodi rilasciando in circolo tutte le sostanze contenute all'interno dei loro granuli densi che stimolano l'aggregazione piastrinica (trombossano etc .. ), mediante i canalicoli che permettono la comunicazione con l'esterno.
Le piastrine possiedono una membrana plasmatica rivestita all'esterno da polisaccaridi e glicoproteine, quest'ultime faciliteranno tutti i processi di adesione e aggregazione piastrinica.
Le piastrine contengono tre tipi di granuli; i lisosomi, i granuli densi e i granuli alpha, in particolare in questi ultimi ci sono tutte le sostanze attivanti le piastrine (fattore V, fvWF, fibrinogeno, trombospondina) che verranno messe in circolo una volta che si avrà l'attivazione delle piastrine.
Fasi della Risposta Piastrinica
- Adesione al sotto endotelio grazie al fattore Von willebrand (vWF)
- Attivazione con cambiamento della morfologia e degranulazione
- Aggregazione
- Formazione del tappo piastrinico, che dovrà poi essere stabilizzato
Adesione Piastrinica
- l'endotelio e le piastrine si respingono a causa delle cariche negative
- il danno espone il collageno sottoendoteliale che lega la glicoproteina GpIa. Allo stesso tempo il vWF, legato alla GpIb, aderisce alla matrice.
Cambiamento di Forma delle Piastrine
Quando le piastrine cambiano la loro forma il fattore piastrinico III (PF3), una fosfatidil-serina che nella piastrina a riposo è situato sul versante interno, viene ad essere esposto sulla superficie esterna con attività procoagulante. Le piastrine rappresentano il substrato dove avviene poi l'attivazione della coagulazione.
Adesione e Rottura dell'Endotelio
L'endotelio integro e la superficie piastrinica si respingono in virtù delle loro cariche negative La rottura dell'endotelio espone il collageno sottoendoteliale che lega la Gpla. la Gpib si lega al vWF, a sua volta adeso al collageno
Membrane basale lesione endotelio Piastrino GpIa Piastrina = collageno - fattore di Von Willebrand (multimero)
Cambiamento di Forma e Degranulazione
cambiamento di forma In seguito all'adesione le piastrine attivano meccanismi di trasduzione che determinano il cambiamento d forma e la degranulazione.
degranulazione . Fase reversibile · Fase irreversibile