Capitolo 1: Concetti chiave della comunicazione e della memoria
Documento di Università sulla comunicazione e la memoria. Il Pdf esplora i concetti chiave della comunicazione, dai modelli matematici e semiotici agli atti linguistici e alle massime conversazionali, analizzando i diversi tipi di memoria e i modelli di memoria semantica. Il documento è utile per lo studio della Psicologia.
Ver más25 páginas
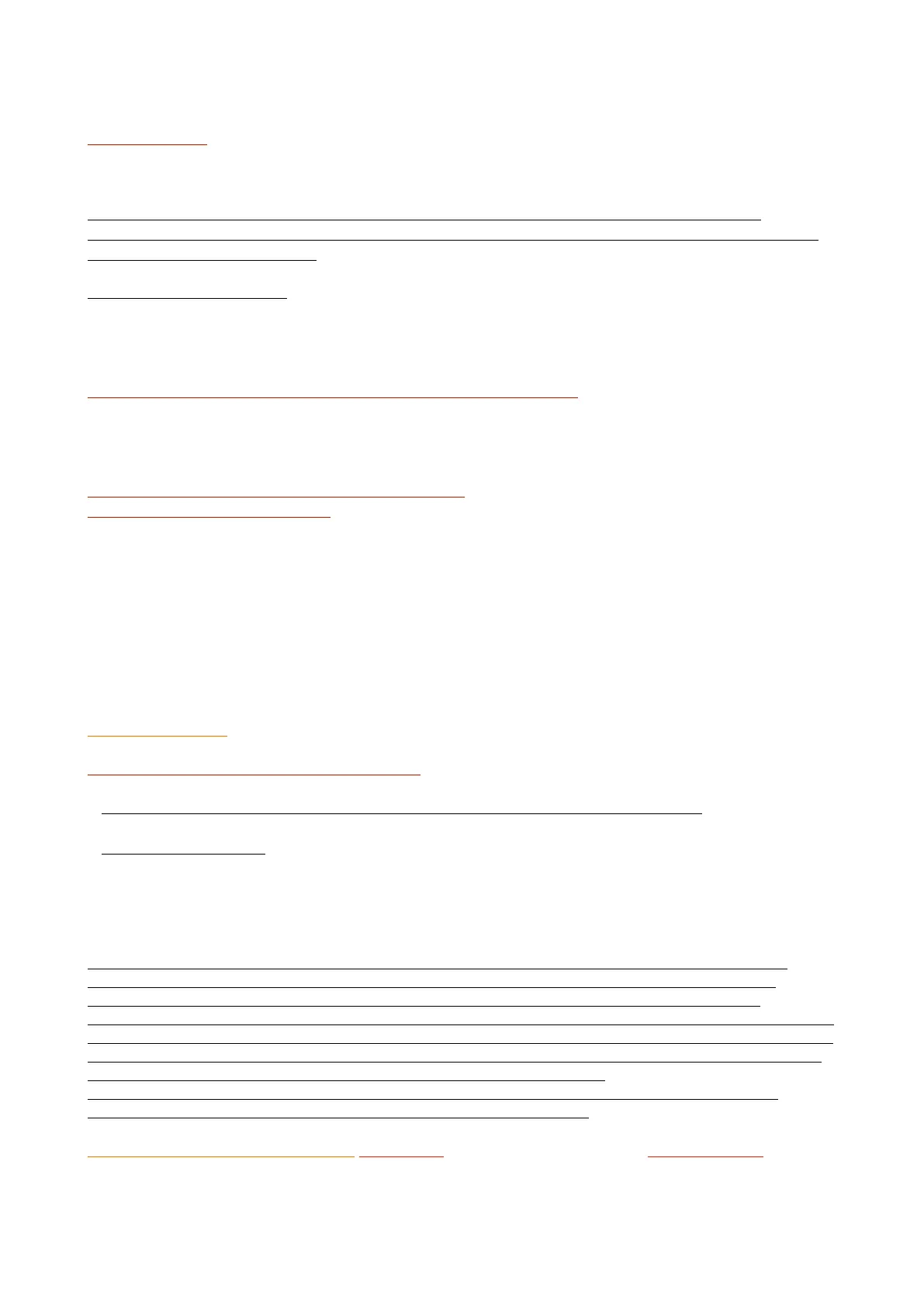
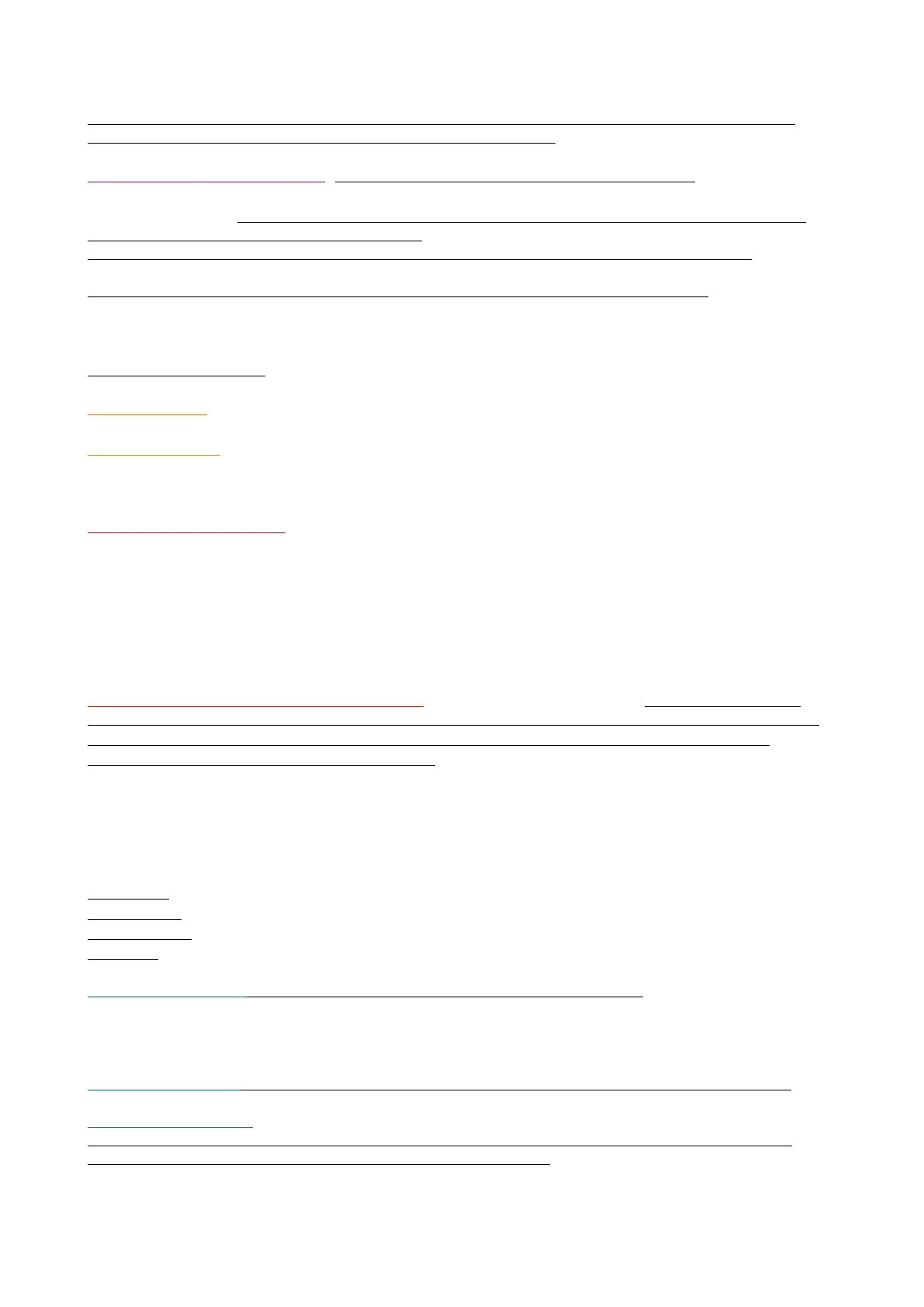
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Comunicazione e Interazione
Capitolo 1 COMUNICARE è interagire con altri, non necessariamente per trasmettere un messaggio specifico. Ogni gesto comunica, anche involontariamente. La comunicazione implica un osservatore o un ascoltatore. La comunicazione è un processo interpersonale e sociale che consente lo scambio di informazioni e la creazione di significati condivisi. Avviene in un ambiente sociale e implica la condivisione tra partecipanti.
Sistemi di Comunicazione
- Suoni significativi
- Segni e significati (es. cinese)
- Regole e convenzioni (es. grammatica)
Distinzione tra Comunicazione e Comportamento
- Comportamento: qualsiasi azione motoria percepibile.
- Comunicazione: scambio interattivo osservabile con intenzionalità e consapevolezza, che condivide significati attraverso sistemi simbolici e convenzionali.
Concetti di Base della Comunicazione
Approccio Matematico alla Comunicazione
(APPROCCIO MATEMATICO): - Modello basilare definito nel 1949. - Considera la comunicazione come una semplice trasmissione di informazioni da un mittente a un ricevente. - La fonte crea e trasmette un messaggio codificato, che passa attraverso un canale. - Il ricevente decodifica il messaggio per il destinatario
Limiti del Modello Matematico
Limiti del modello: - MODELLO LINEARE UNIDIREZIONALE. · Creato per spiegare sistemi di comunicazione come radio, telegrafo e telefono, il modello originale non includeva il feedback e non era adatto alla comunicazione faccia a faccia. Il modello contenitore si concentra sul messaggio come unità di comunicazione, trascurando intenzionalità e contesto.
L'Approccio Semiotico
L'APPROCCIO SEMIOTICO: Studia come i significati vengono creati e interpretati attraverso segni come linguaggio, immagini e gesti. La comunicazione avviene tramite la significazione, ovvero la capacità di generare significati attraverso codici e sistemi. L'approccio semiotico si concentra sulla creazione di significati attraverso i simboli, piuttosto che sulla semplice trasmissione del messaggio. Il triangolo semiotico illustra la relazione tra segno, significato e referenza. Il simbolo rappresenta un concetto o un'idea, la referenza è l'elemento reale a cui si riferisce il simbolo e il significato è la relazione tra segno e referenza. L'intenzionelità, ovvero l'azione compiuta in modo deliberato, è fondamentale nella costruzione del significato nella comunicazione interpersonale. Per raggiungere un obiettivo, la comunicazione è lo scambio intenzionale di un messaggio, mentre l'informazione è la trasmissione involontaria di un segnale.
Intenzionalità e Contesto nella Semiotica
Esistono due livelli di intenzionalità: informativa (condividere informazioni) e comunicativa (coinvolgere il destinatario). Il contesto influenza l'interpretazione, riducendo l'ambiguità e permettendo di dedurre informazioni implicite. Gli indizi contestuali, come la deissi (spaziale, temporale, personale), forniscono riferimenti diretti alla situazione.Le presupposizioni sono informazioni implicite, condivise e date per scontate. Le implicature conversazionali si riferiscono alla differenza tra ciò che viene detto e ciò che viene inteso, richiedendo conoscenze pregresse e condivise. La relazione tra gli interlocutori è fondamentale per comprendere i messaggi impliciti.
L'Approccio Pragmatico
L'APPROCCIO PRAGMATICO: studia la comunicazione umana in tre settori: sintassi (relazioni tra segni), semantica (significato dei segni) e pragmatica (uso dei significati). LA PRAGMATICA :si concentra sull'influenza del contesto sull'interpretazione del significato e sull'uso pratico del linguaggio come azione. Importanza di relazione tra segni e chi li interpreta: si parla di soggetti che comunicano. Processi impliciti della comunicazione: trovare il significato al di là del messaggio.
Teoria degli Atti Linguistici di Austin
LA TEORIA DEGLI ATTI LINGUISTICI DI AUSTIN: "COMUNICARE EQUIVALE AD AGIRE".
Tipi di Atti Linguistici
- Atti locutori: atti di dire qualcosa (ciò che il parlante dice, azioni che si compiono per il solo fatto di parlare).
- Atti illocutori: atti nel dire qualcosa (intenzioni comunicative del parlante).
- Atti perlocutori: atti con il dire qualcosa (gli effetti che la comunicazione produce sull'interlocutore).
Forza degli Atti Linguistici
Forza degli atti linguistici: ogni atto linguistico può essere modulato, sul piano pragmatico, con più o meno forza. - Atti locutori: ciò che si dice può essere rinforzato con il tono. - Atti illocutori: ciò che si fa nel dire può essere modulato con la scelta delle parole (devi/ potresti). - Atti perlocutori: possono ottenere diversi effetti sull'interlocutore (a seconda del contesto/ credenze/stato d'animo di entrambi/motivazioni).
Massime Conversazionali di Grice
MASSIME CONVERSAZIONALI DI GRICE: principio di cooperazione: accordo di base tra i partecipanti, implicito, di cooperazione per dare il proprio contributo allo scambio comunicativo. - Stabilisce le regole implicite che guidano la comunicazione efficace, sottolineando l'importanza della cooperazione reciproca. - "Dai il tuo contributo al momento opportuno, così com'è richiesto dagli scopi e dall'orientamento della conversazione in cui si è impegnati".
Le Quattro Massime Conversazionali
4 MASSIME CONVERSAZIONALI DI GRICE: 1. Qualità. 2. Quantità. 3. Relazione. 4. Modo.
Massima di Quantità
Massima di quantità: da un contributo tanto informativo quanto richiesto. - Il messaggio deve soddisfare la richiesta di info in modo adeguato agli scopi della conversazione. - Non dare un contributo meno o più informativo del necessario.
Massima di Qualità
Massima di qualità: non dire ciò che credi falso; non dire ciò per cui non hai prove adeguate.
Massima di Relazione
Massima di relazione: Dare informazioni pertinenti con la comunicazione in corso. Il messaggio deve essere chiaro, conciso e ordinato, evitando espressioni oscure e ambiguità.
Assiomi della Comunicazione di Watzlawick
WATZLAWICK AFFERMA che tutto è comunicazione, con il linguaggio che influenza comportamenti e relazioni. LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE, BASATA SU 5 ASSIOMI, sintetizza le regole della comunicazione in 2: 1) tutto è comunicazione, verbale o non verbale; 2) ogni comportamento è comunicazione e ogni atto comunicativo è un comportamento.
Primo Assioma: Impossibilità di Non Comunicare
L'assioma 1: afferma che non si può non comunicare, poiché ogni comportamento in presenza di altri è comunicazione, indipendentemente dalla consapevolezza o intenzionalità.
Secondo Assioma: Contenuto e Relazione
L'assioma 2 : afferma che ogni comunicazione veicola sia contenuto che relazione, con il contenuto interpretato nella relazione. La relazione fornisce una chiave di lettura del contenuto.
Terzo Assioma: Punteggiatura della Comunicazione
L'assioma 3: afferma che la natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti. La punteggiatura rappresenta l'interpretazione della realtà o il punto di vista. Comprendere la relazione tra i partecipanti e il punto di vista di un interlocutore è fondamentale per interpretare la comunicazione. La stessa realtà comunicativa può essere letta in modi diversi a seconda della punteggiatura adottata.
Modulo Digitale e Analogico
Gli esseri umani comunicano con il modulo digitale (verbale, dettagliato, contenuto) e il modulo analogico (non verbale, immediato, relazione). A volte non combaciano, ma il canale non verbale è spesso più veritiero.
Scambi Comunicativi: Simmetrici e Complementari
Gli scambi comunicativi sono simmetrici (paritari) o complementari (riconoscimento di posizioni e interdipendenza). Alcune relazioni sono definite dal contesto socio-culturale, positive o negative a seconda della situazione.
Competenza Comunicativa
La competenza comunicativa implica la padronanza di regole formali, sintassi, pragmatica e semantica per produrre enunciati adeguati. Richiede la conoscenza dei segni e delle regole del linguaggio. È anche la capacità di capire e percepire di aver soddisfatto gli scopi in una situazione sociale. Intenzionalità, consapevolezza ed efficacia sono correlate alla competenza comunicativa. La valutazione di sé e degli altri influenza la percezione della propria capacità comunicativa.
Tipi di Competenza Comunicativa
- Competenza sintattica: capacità di produrre e comprendere frasi corrette secondo le regole grammaticali.
- Competenza semantica: capacità di associare parole a oggetti, eventi o situazioni.
- Competenza pragmatica: capacità di usare il linguaggio in modo efficace in contesti sociali. Capacità di comunicare tenendo conto del contesto.
Il Linguaggio Verbale
CAPITOLO 2: IL LINGUAGGIO VERBALE Il linguaggio verbale utilizza il linguaggio scritto e parlato, il principale sistema di scambio tra esseri umani. È una funzione cognitiva che consente di acquisire e utilizzare una o più lingue.
Aree Cerebrali del Linguaggio
Il linguaggio si riflette come funzione cognitiva distribuita in specifiche aree del cervello: - Area di Broca: articolazione e produzione del linguaggio. - Area di Wernicke: comprensione del linguaggio e attribuzione di significato. - Corteccia visiva: elaborazione delle lettere e delle parole scritte. - Corteccia motoria: articolazione. L'approccio psicolinguistico studia i meccanismi di produzione e comprensione del linguaggio.
Struttura della Lingua
LA LINGUA È un sistema di simboli combinabili secondo precise regole, che genera un numero infinito di possibili messaggi. - Fonologia: sistema dei suoni che costituiscono i linguaggi. - Semantica: significato delle parole. - Sintassi: struttura delle frasi. - Pragmatica: uso del linguaggio in contesto. La lingua è strutturata come una piramide: - Fonemi e grafemi (base). - Morfemi. Parole. - Sintagmi. - Frasi. - Testi e discorsi (punta).
Fonemi e Grafemi
I fonemi sono i suoni più piccoli di una lingua parlata. La corrispondenza tra fonemi e grafemi (unità grafica minima) varia da lingua a lingua. - Lingue trasparenti: buona corrispondenza (es. italiano, tedesco). - Lingue opache: bassa corrispondenza (es. inglese, francese). Due suoni linguistici sono fonemi diversi se sostituendo l'uno con l'altro cambia il significato delle parole. Ogni lingua ha un numero finito di fonemi, pronunciati con variazioni regionali, individuali o contestuali (allofoni).
Morfemi, Sintagmi e Frasi
Morfemi e parole si formano combinando fonemi, ma non tutte le combinazioni sono valide. I morfemi sono le unità più piccole con significato. I sintagmi sono unità minime di una catena sintattica, composti da una parte fondamentale e da modificatori. Le frasi combinano parole e sintagmi seguendo regole sintattiche, che permettono di combinare simboli per produrre significati complessi.
Teoria di Chomsky e Universali Linguistici
CHOMSKY SOSTIENE che la sintassi proietta il finito (parole, regole) nell'infinito (numero di frasi), rendendo il linguaggio uno strumento di comunicazione unico. Le lingue differiscono, ma condividono elementi in comune chiamati universali linguistici:
- Numero finito di fonemi
- Possibilità di costruire un numero infinito di parole da fonemi finiti
- Numero finito di parole in una lingua
- Relazione arbitraria tra parole e significati
- Possibilità di produrre un numero infinito di frasi in qualsiasi lingua (produttività linguistica)
Sviluppo del Linguaggio
LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO: l'acquisizione della lingua madre. Il linguaggio è un'abilità complessa, ma si impara facilmente. I bambini imparano a parlare velocemente, senza istruzione formale.
Acquisizione dei Suoni e Regole Grammaticali
Acquisire i suoni: i neonati sono predisposti ad imparare qualsiasi lingua, rispondendo a tutte le distinzioni sonore. Dopo un anno, si specializzano nei suoni della loro lingua. Acquisire le regole grammaticali: sorprendentemente, i bambini padroneggiano il linguaggio velocemente. Prima dei due anni, conoscono già molte parole. I bambini in età prescolare non imparano esplicitamente le regole grammaticali e non vengono corretti per frasi scorrette. Gli adulti correggono gli errori semantici, non grammaticali (gli insegnanti correggono la parte semantica). Di solito non facciamo caso alla struttura semantica ma non a quella grammaticale.
Teoria Innatista di Noam Chomsky
TEORIA INNATISTA DI NOAM CHOMSKY: i bambini acquisiscono inconsciamente le strutture grammaticali con poco addestramento. Chomsky immagina un meccanismo innato di acquisizione del linguaggio (LAD): un meccanismo biologico che fornisce le regole generali della grammatica comuni a tutte le lingue (TEORIA GENERATIVISTA).