Elementi di sociologia generale: riassunto del corso online dell'Università di Torino
Documento dall'Università di Torino su elementi di sociologia generale. Il Pdf, un riassunto del corso di Psicologia a livello universitario, esplora modelli di società, fonti ausiliarie della sociologia, bullismo, famiglia e sistema educativo, offrendo una panoramica chiara e strutturata.
Mostra di più34 pagine
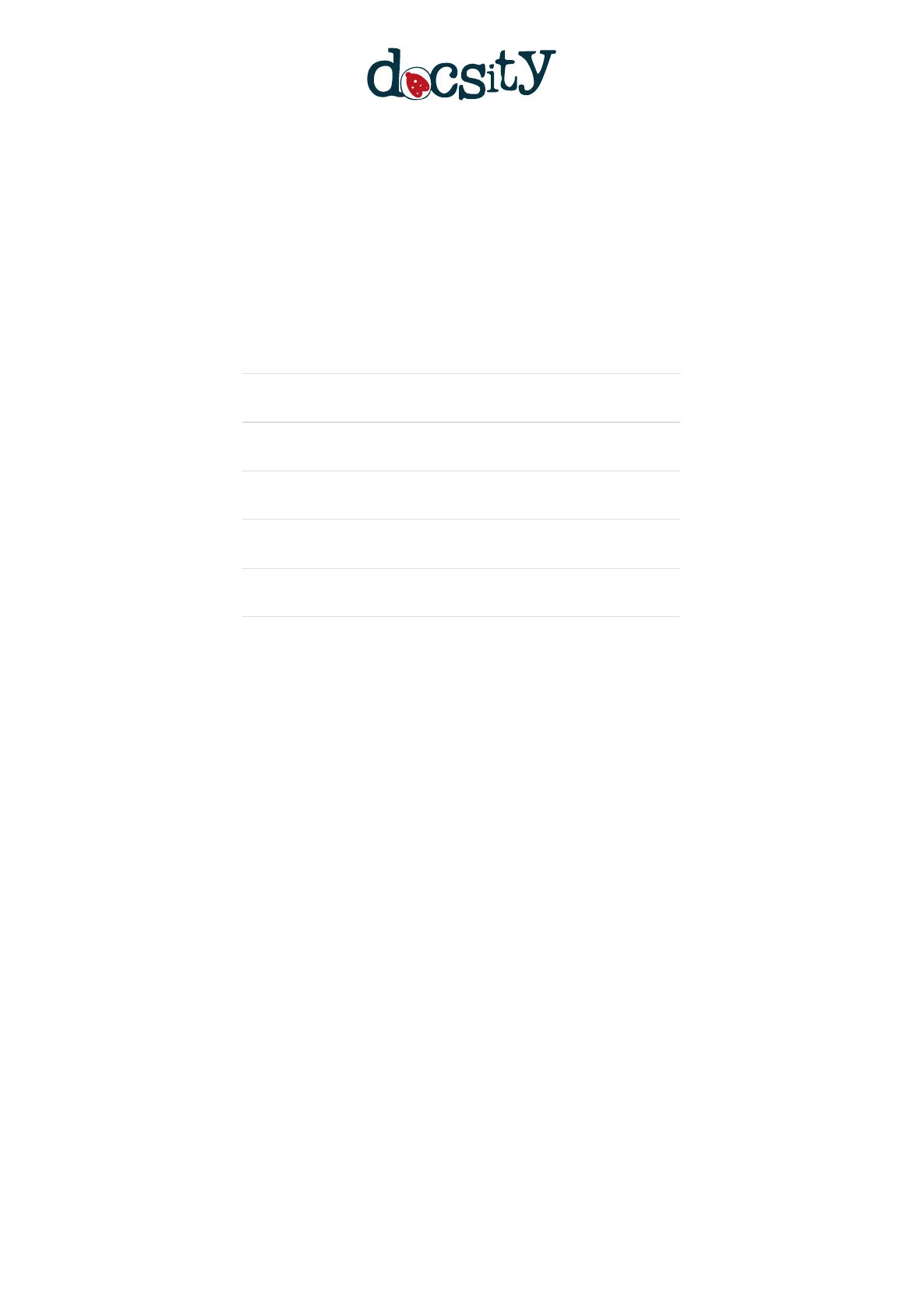
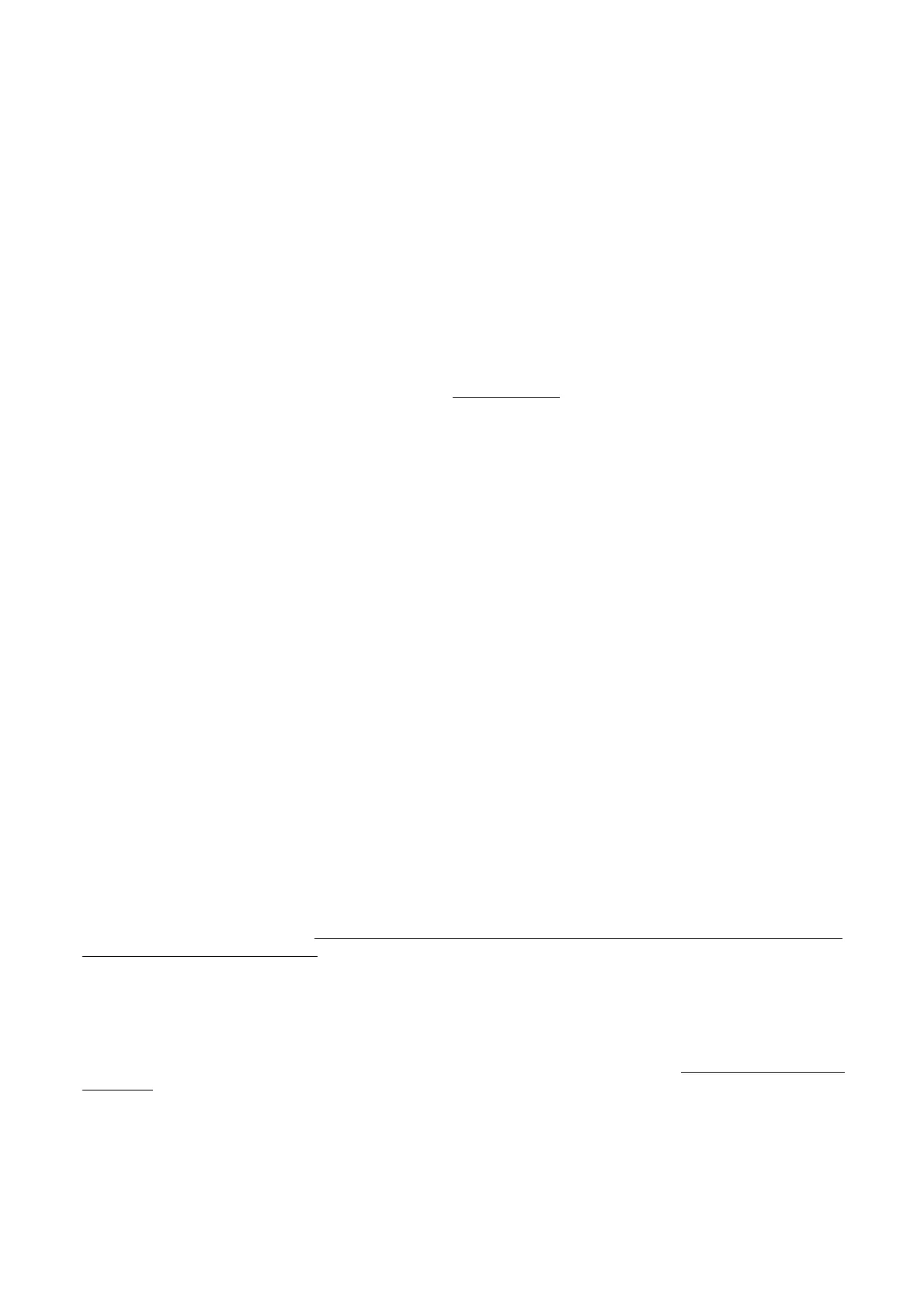
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Sociologia: Fondamenti e Fenomeni Essenziali
decsity
Elementi di sociologia
generale - riassunto del corso
online
Sociologia
Università di Torino
33 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alessia. Catalano (alessiacatalano99.ac@gmail.com)MODULO 1
Lezione 1.0.1
Definiamo "sociologia" la scienza che studia i fondamenti, i fenomeni essenziali, i processi ricorrenti di
strutturazione e destrutturazione e le manifestazioni tipiche della vita associata e le loro trasformazioni. Come ogni
altra scienza, la sociologia mira a ricondurre la varietà degli eventi particolari a un numero limitato di leggi o di
proposizioni generali, che siano collegati tra loro da schemi esplicativi o teorie più o meno ampie (Gallino, 2004b);
ciò richiede un'apposita indagine teoretica e fattuale.
L'oggetto primario dell'indagine sociologica è l'insieme dell'organizzazione sociale e la sociologia mira a produrre
conoscenze fondate, stabili e trasmissibili (ovvero riproducibili) intorno all'organizzazione sociale e alle sue varie
componenti.
L'organizzazione sociale, può essere allora definita come la configurazione dei rapporti sociali relativamente stabili
tra gli individui e tra i gruppi di in una società, e delle azioni ricorrenti che essi compiono ogni giorno allo scopo di
produrre e riprodurre, materialmente e simbolicamente, la propria esistenza.
Modelli di Società nel Pensiero Sociologico
Modelli Mentali e Rappresentazioni
Lezione 1.1.1 Modelli di Società
Nella costruzione di risposte al quesito di come sia possibile la società, il pensiero sociologico è stato orientato da
un numero limitato di grandi modelli di società.
Due note. La prima: questi modelli della società sono modelli mentali: rappresentazioni che descrivono in modo
"generale, ma al tempo stesso estremamente efficace nell'indirizzare la ricerca, la natura profonda di una
determinata società o della società in genere". Essi sono anche stati definiti come paesaggi mentali metaforici. Essi
funzionano come delle macchine ordinatrici concettuali, il cui compito è produrre intelligibilità.
Seconda osservazione. Tutti indistintamente elaboriamo o comunque utilizziamo, più o meno consapevolmente,
rappresentazioni mentali del mondo o di sue porzioni per superare indenni le difficoltà quotidiane. E tutti, a
pensarci attentamente, abbiamo più o meno profondamente radicate in mente alcune concezioni della natura di
almeno alcune parti dell'organizzazione sociale.
La Società come Organismo
La Società come Organismo "Il modello organicistico, che è stato tra i primi a emergere nel pensiero sociale,
concepisce la società come un organismo, formato da organi latamente assimilabili a quelli corporei, il quale, come
accade appunto ai corpi, cresce, acquisisce nuove capacità, conosce stati di salute e di malattia, ed è destinato
prima o poi al declino". Il modello dell'organismo accentua il carattere di totalità della società, conforme al quale la
società è un tutto alla cui impronta non sfugge nulla; ciò significa che in ogni parte della società, sia essa piccola o
grande, si ritrovano le proprietà strutturali della società intera.
La Società come Meccanismo
La Società come Meccanismo Questo modello "accentua il carattere della società come insieme di atomi individuali,
dai cui movimenti singoli, tra di essi liberamente interagenti come particelle di un gas, e da essi soltanto, derivano
le proprietà osservabili della società stessa. L'elemento prioritario su cui deve concentrarsi l'indagine sociologica,
secondo questo modello, sono gli interessi, le azioni, le motivazioni dei singoli individui.
La Società come Processo
La Società come Processo viene a collocare in primo piano la cultura e più precisamente la produzione e lo scambio
di significati che avviene nel corso d'ogni forma d'interazione sociale. Attraverso tale flusso incessante di
produzione e scambio di significati mutevoli di momento in momento, e di epoca in epoca, nel quale ha
un'importanza centrale il linguaggio, gli attori sociali costruiscono la realtà sociale, interpretano di continuo questa
loro costruzione, e via via la ridefiniscono. Se ci si colloca in un simile quadro cognitivo, funzione primaria
dell'indagine sociologica diventa la comprensione dei significati che gli attori sociali elaborano, e che attribuiscono
alle azioni proprie e altrui.
La Società come Sistema
La Società come Sistema porta a tener conto del fatto che una società deve continuamente far fronte ad alcune
fondamentali funzioni. Preminenti tra di esse sono il procurarsi risorse sufficienti in rapporto alla popolazione;
mantenere a livelli accettabili le tensioni e i conflitti interni; conservare nel tempo la propria identità sociale e
culturale; conciliare il soddisfacimento dei bisogni individuali con il perseguimento di scopi collettivi".
Il modello sistemico muove in generale dall'analisi della struttura dei fondamentali sottosistemi interni d'una
società, individuati per lo più nel sistema economico, nel sistema politico, nel sistema della riproduzione socio-
culturale, nel sistema comunitario, ivi comprese le componenti psichiche e biologiche. Insieme con l'analisi
strutturale sono studiati gli scambi materiali e simbolici che tra i sottosistemi intercorrono.
Fonti Ausiliarie della Conoscenza Sociologica
Le Fonti Ausiliarie
Lezione 1.1.2 Le fonti ausiliarie della sociologia
Il sociologo mira a produrre conoscenze fondate, stabili e trasmissibili (ovvero riproducibili) sull'organizzazione
sociale; ciò che siamo soliti chiamare conoscenze scientifiche.
Il sociologo svolge questo lavoro guidato da una specifica logica, cui diamo il nome di logica del ragionamento
sociologico e si avvale anche di fonti di conoscenza che chiamiamo ausiliarie.
Le principali fonti ausiliarie della conoscenza sociologica sono -La statistica; - La storia; - La letteratura.
Ognuna di esse costituisce fonte preziosa e insostituibile di conoscenze sull'uomo e sulla società.
La Statistica
La statistica Un sociologo si nutre della cultura del dato. È parte fondamentale del suo lavoro una riflessione critica
sulle statistiche ufficiali nazionali e internazionali, base indispensabile per impostare un ragionamento rigoroso e
fondato sui fatti.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alessia.Catalano (alessiacatalano99.ac@gmail.com)Ogni paese produce una grande quantità di statistiche ufficiali; esse confluiscono in svariati rapporti, censimenti,
rilevazioni periodiche sugli aspetti più disparati dell'organizzazione sociale. In Italia se ne occupa l'Istat, Istituto
nazionale di statistica, presente nel paese dal 1926, ente di ricerca pubblico oggi parte del Sistan, Sistema statistico
nazionale, il cui compito istituzionale è produrre e diffondere informazioni relative a condizioni sociali, economiche e
ambientali del paese. A livello dell'Unione Europea, esiste un ufficio statistico che armonizza e rende comparabili i
dati raccolti a livello delle singole nazioni: l'Eurostat. La statistica ufficiale deve essere autonoma e indipendente dal
governo, dalle influenze politiche, dalle pressioni di gruppi organizzati.
La Storia
La storia - intesa come storia narrata, il prodotto del lavoro degli storici è necessaria per cogliere lo spessore
temporale delle società. Si può dire che la storia si presenta come un immenso archivio di azioni realmente
compiute, che il sociologo deve considerare come un repertorio di azioni possibili.
La Letteratura
La letteratura La narrativa costituisce pure essa una forma di conoscenza. Funzione anticipatrice.
Teorie Sociologiche: Macro, Micro e Meso
Livelli di Analisi
Lezione 1.1.3 Teorie macro, micro e meso
Una efficace proposta di classificazione delle teorie sociologiche è quella che le distingue sulla base del livello di
analisi: macro, micro e meso. L'esigenza di una distinzione tra macrosociologia e microsociologia è emersa verso gli
anni Cinquanta del Novecento, per distinguere l'analisi sociologica di intere società o delle loro principali strutture
dallo studio di aspetti circoscritti della vita sociale.
Macrosociologia
Se immaginiamo macro e micro come estremi di un asse, possiamo dire che all'estremo macro-sociologico i
ricercatori si concentrano su temi come le strutture formali delle organizzazioni, sui rapporti tra sistemi e sotto-
sistemi sociali, sulle modificazioni formali o strutturali di tali sistemi. In generale le tematiche si riferiscono a
intervalli di tempo lunghi, a estensioni di spazio ampie, a grandi masse di persone.
Esempi: Evoluzionismo, teorie dei sistemi, economia politica (Marx), conflitto e cambiamento sociale.
Microsociologia
Possiamo dire che all'estremo micro-sociologico ci si occupa di piccoli segmenti di spazio e di piccole quantità di
persone, come accade quando si studiano le relazioni interpersonali, i rituali, gli schemi interpretativi e i simbolismi
che orientano le azioni sociali.
Esempi: Rituale dell'interazione, sé, mente e ruolo sociale, situazione e costruzione sociale della realtà, scambio
sociale.
Teorie Meso
Le teorie meso si collocano tra micro e macro. Tra di esse si collocano le teorie di rete, per esempio. In quella
prospettiva di analisi, le strutture sono modelli che si formano tra individui: si evitano così al tempo stesso la
reificazione della macrostruttura e la visione disincarnata delle interazioni micro.
La Sociologia come Scienza
Competenza Sociale e Senso Comune
1.2.1 È vera scienza?
Esiste un senso in cui tutti noi siamo sociologi. Essere nati e cresciuti in una società ci rende "competenti
socialmente" rispetto a quella medesima società; cosa di cui diveniamo facilmente consapevoli quando, per motivi
diversi, ci troviamo in una società altra, diversa da quella di nostra appartenenza (per turismo, lavoro, studio ... ). In
questo caso ci rendiamo immediatamente conto di essere almeno in parte "incompetenti", di non disporre cioè di
quel sapere utile e a volte anche indispensabile in molte circostanze della vita quotidiana.
Complessi sistemi di aspettative reciproche sono costruiti su quelle forme di sapere e da essi dipende gran parte
della nostra vita di tutti i giorni. Ognuno di noi ha una serie di idee sulla società e sui modi del suo funzionamento
(e quindi anche del suo mancato funzionamento). A questo genere di sapere sono stati dati molti nomi diversi, che
in prima approssimazione possiamo considerare sinonimi: sapere sociale comune, senso comune, competenza
sociale naturalmente acquisita. Le idee cui mettono capo sono state definite immagini sociali. Nella nostra mente si
formano sin dalla più tenera età varie rappresentazioni del mondo sociale, che interagiscono di continuo con le
immagini che ci vengono proposte da attori diversi per il tramite di svariati mezzi (articoli della stampa; lezioni
universitarie; prediche in chiesa; comizi in piazza; forum o blog dei social network; ... ). Quando siano condivise da
un numero elevato di individui le chiamiamo rappresentazioni collettive; le definiamo convenzionali quando rinviano
ad un uso condiviso. Insomma: disponiamo di un insieme di conoscenze che abbiamo accumulato in tutta la nostra
vita; una sorta di sapere sociale comune sull'organizzazione sociale, che è anche stato osservato costituire una
forma di sociologia ingenua.
Il Metodo Scientifico in Sociologia
La sociologia propone di aggiungere o di sovrapporre alle rappresentazioni personali e private, e a quelle collettive
e convenzionali, una rappresentazione pubblica, empiricamente e rigorosamente fondata della società, perché le
immagini personali, ma anche quelle collettive e convenzionali, possono essere parziali; di frequente mescolano
descrizione e valutazione; talvolta poi distorcono la realtà. Quel sapere ha dei limiti che gli derivano dalle condizioni
in cui viene formulato. La sociologia come impresa scientifica mira a produrre conoscenze con procedure che ne
garantiscono la validità. Come? Appunto, utilizzando il metodo scientifico. Il metodo scientifico consiste nel
costruire razionalmente schemi di spiegazione e di previsione dei fenomeni sociali mediante indagine controllata.
Applicando il metodo scientifico, la sociologia opera spesso, nelle nostre rappresentazioni della società, una frattura
cognitiva, una frattura tra competenza sociale naturalmente acquisita e conoscenze relative a processi e strutture
sociali scientificamente prodotte e controllate. Le immagini sociali sono così sostituite da immagini sociologiche;
quelle convenzionali da immagini alternative della società.
In questo lavoro, il sociologo si avvale di due strumenti complementari: 1) il distanziamento; 2) la comparazione
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alessia.Catalano (alessiacatalano99.ac@gmail.com)