Fisiopatologia del sistema digestivo: disturbi e malattie epatiche
Documento sulla Fisiopatologia del Sistema Digestivo, che esplora i disturbi della salivazione, masticazione e deglutizione. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Biologia, dettaglia le malattie epatiche, inclusi sintomi e indagini diagnostiche, e tratta epatiti virali, malattie tossiche, autoimmuni e metaboliche del fegato.
Mostra di più37 pagine
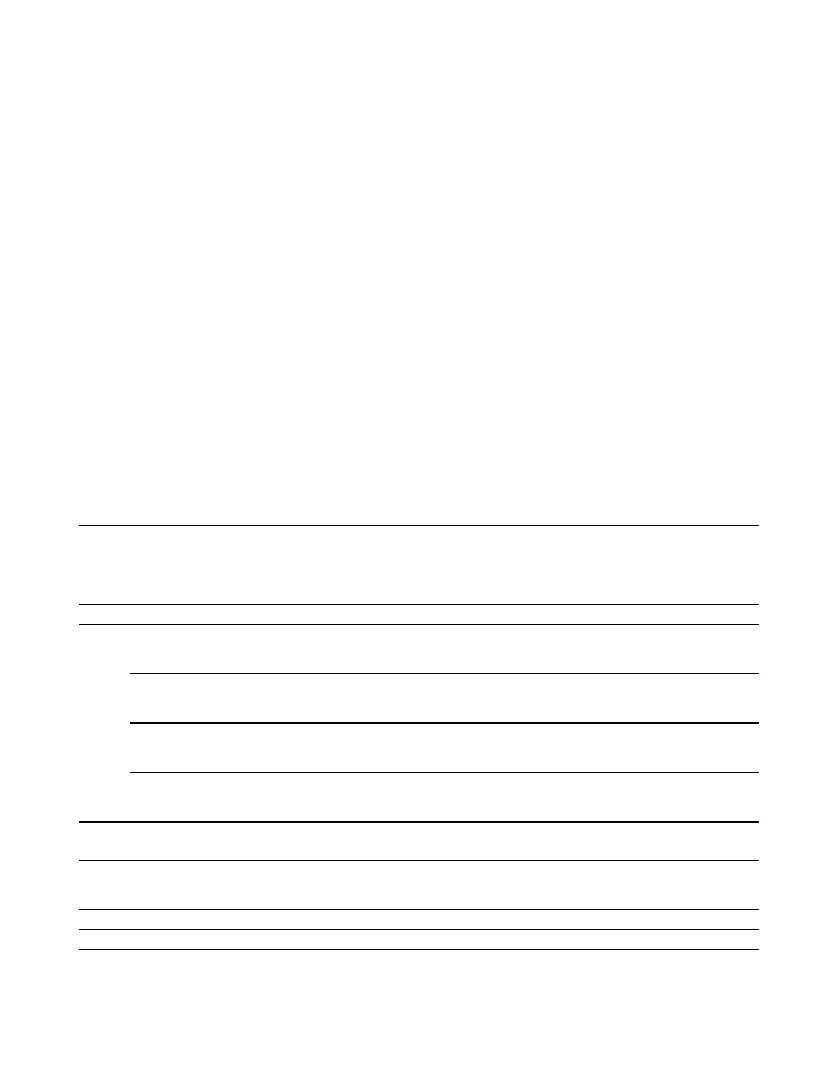
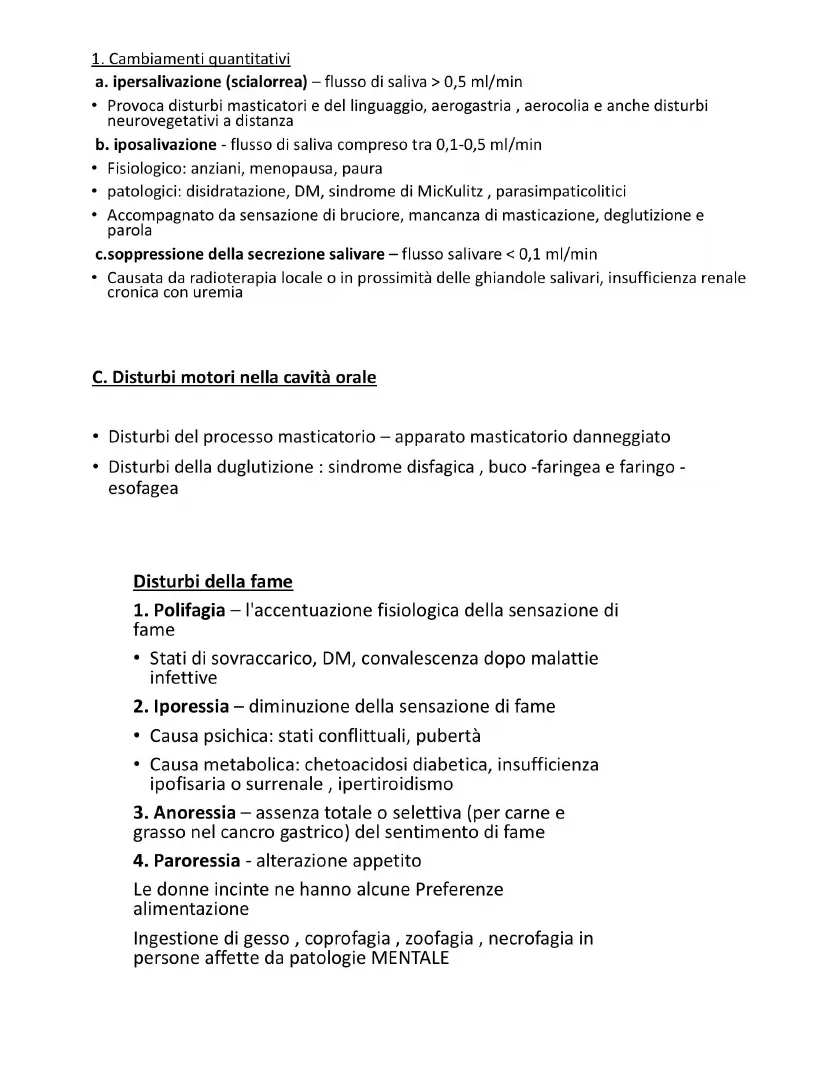
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Test broncodilatatori
- viene eseguito con sostanze che imitano l'effetto del sistema nervoso vegetativo parasimpatico - acetilcolina , metacolina o con istamina o vari allergeni;
- viene somministrato a soggetti asintomatici nei quali si sospetta una storia di asma bronchiale ;
- il test è significativo se il VEMS diminuisce di oltre il 15 - 20%, rispetto al valore ottenuto alle prime registrazioni.
Test broncodilatatori
- Provoca il rilassamento della muscolatura liscia nei passaggi bronchiali , un'azione simile a quella dei mediatori del sistema nervoso simpatico.
- vengono somministrati farmaci inalatori beta-adrenergici o parasimpatici ad azione rapida;
- viene eseguita in pazienti con sindrome ostruttiva già accertata, sia a scopo diagnostico ( evidenziando l'origine spastica dell'ostruzione ) che a scopo terapeutico (l'efficacia del farmaco );
- il test è significativo se il VEMS aumenta di oltre il 10-15% rispetto al valore ottenuto alle prime registrazioni.
Fisiopatologia del sistema digestivo
Digestione
- Processo complesso derivante dall'azione combinata di tutti i segmenti del tubo digerente e delle ghiandole annesse.
- L'efficienza del processo di digestione richiede il coordinamento permanente dell'attività motoria, secretoria e di assorbimento.
- Il malfunzionamento di una di queste attività può portare a disfunzioni nel meccanismo di digestione e rispettivamente dell'assorbimento.
Fisiopatologia della cavità orale
La cavità orale serve principalmente al processo di masticazione attraverso il quale il cibo si trasforma in una massa omogenea, molto più facilmente influenzabile dalla secrezione salivare.
A. La fisiopatologia della secrezione salivare
Il volume della secrezione salivare in 24 ore è di 1000-1500 ml, con una portata di 0,5 ml/min. I fattori che influenzano il tasso di secrezione salivare sono1. Cambiamenti quantitativi
a. ipersalivazione (scialorrea) - flusso di saliva > 0,5 ml/min
- Provoca disturbi masticatori e del linguaggio, aerogastria , aerocolia e anche disturbi neurovegetativi a distanza
b. iposalivazione - flusso di saliva compreso tra 0,1-0,5 ml/min
- Fisiologico: anziani, menopausa, paura
- patologici: disidratazione, DM, sindrome di MicKulitz , parasimpaticolitici
- Accompagnato da sensazione di bruciore, mancanza di masticazione, deglutizione e parola
c.soppressione della secrezione salivare - flusso salivare < 0,1 ml/min
- Causata da radioterapia locale o in prossimità delle ghiandole salivari, insufficienza renale cronica con uremia
C. Disturbi motori nella cavità orale
- Disturbi del processo masticatorio - apparato masticatorio danneggiato
- Disturbi della duglutizione : sindrome disfagica , buco -faringea e faringo - esofagea
Principali: grado di idratazione dell'organismo, posizione del corpo, esposizione alla luce, fumo, assunzione di farmaci.
Disturbi della fame
- Polifagia - l'accentuazione fisiologica della sensazione di fame
- Stati di sovraccarico, DM, convalescenza dopo malattie infettive
- Iporessia - diminuzione della sensazione di fame
- Causa psichica: stati conflittuali, pubertà
- Causa metabolica: chetoacidosi diabetica, insufficienza ipofisario o surrenale , ipertiroidismo
- Anoressia - assenza totale o selettiva (per carne e grasso nel cancro gastrico) del sentimento di fame
- Paroressia - alterazione appetito
Le donne incinte ne hanno alcune Preferenze alimentazione Ingestione di gesso , coprofagia , zoofagia , necrofagia in persone affette da patologie MENTALE Secondari: età, peso, gravidanza, dimensione delle ghiandole salivari, fattori psicologici -- Modifiche qualitative: modifiche del pH salivare tramite eliminazione di sostanze come: glucosio, urea, acido urico, o tramite eliminazione di virus: nel morbillo e poliomielite
II. Fisiopatologia dell'esofago
A livello dell'esofago si evidenziano:
- disturbi della motilità , sensitivosensoriali
- modifiche anatomiche.
L'attività motoria dell'esofago è la sua funzione principale, rispettivamente il trasporto del bolo alimentare dalla faringe allo stomaco. I disturbi motori esofagei possono essere localizzati:
- a livello dello sfintere esofageo superiore (SES) e dello sfintere esofago inferiore (SEI),
- a livello del corpo esofageo, compromettendo sia i muscoli striati del SES sia la muscolatura liscia.
- raramente viene compromesso il corpo esofageo nella sua interezza.
A. Disturbi motori primari della muscolatura liscia
Acalasia
- Conosciuta con il nome di megaesofago o cardiospasmo , è caratterizzata dall'insufficienza del rilassamento del SEI durante la deglutizione e dall'assenza delle onde peristaltiche propulsive del corpo esofageo. L'eziopatogenesi rimane sconosciuta, nei 2/3 degli acalasici si evidenzia una serie di auto-anticorpi antiproteina che trasporta la dopamina a livello delle cellule del plesso mioenterico. L'unione di questi anticorpi con gli antigeni della superficie del plesso può dare inizio alla sua distruzione. Inoltre si può constatare la diminuzione della concentrazione di NO( neurotrasmettitore inibitorio di SEI ) a livello di SEI e del terzo inferiore dell'esofago. La riduzione o l'assenza di NO impediscono il rilassamento di SEI.
B. Disturbi motori secondari che colpiscono la muscolatura liscia
- Collagenosi - riduzione delle onde propulsive fino alla loro scomparsa nell'esofago inferiore; esofago rigido, non animato da onde peristaltiche.
- DM- le manifestazioni compaiono soprattutto nei pazienti con neuropatia autonoma periferica.
- Alcool- nell'intossicazione acuta si osserva una diminuzione delle onde peristaltiche e della pressione nel SEI.
- Ernia gastrica transiatale- ernia di una porzione dell'esofago terminale e/o dello stomaco attraverso lo iato diaframmatico nel mediastino
- Malattia da reflusso gastroesofageo - totalità dei sintomi ( bruciore di stomaco, rigurgito, dolore retrosternale, scialorrea) causati dal reflusso gastrico nell'esofago; intervengono 3 gruppi di fattori: 1- incompetenza dei meccanismi antireflusso; 2- stimolo dei chemocettori con la comparsa del bruciore di stomaco e stimolo dei meccanorecettori responsabili del dolore; 3- riduzione dei fattori di difesa e intensificazione dell'azione dei fattori aggressivi ( HCl, pepsina, acidi biliari)
C. Cambiamenti anatomici
- Diverticoli esofagei - dilatazioni sacciformi dell'esofago, contenenti tutti i suoi strati anatomici
- Pseudodiverticoli - dilatazioni esofagee che contengono solo mucosa e sottomucosa nella loro parete, senza strato muscolare.
D. Disturbi sensoriali
- Sindrome disfagica - conseguenza di spasmo o disturbi della dinamica esofagea.
- Bruciore di stomaco - sensazione di bruciore retrosternale associata a eruttazione acida.
- Eruttazione - rumorosa eliminazione del gas dallo stomaco all'esterno.
- Rigurgito- ritorno degli alimenti dallo stomaco all'esofago, senza lo sforzo del vomito.
- Ruminazione - rigurgito ripetuto.
Esplorazione paraclinica dell'esofago
- Esame radiologico
- Radiografia normale:
- corpi estranei;
- pneumomediastino attraverso perforazioni esofagee;
- Radiografia con mezzo di contrasto (solfato di bario in sospette di fistole) evidenzia:
- la morfologia;
- la motilità dell'esofago;
Può essere :
- Radiografia standard- TC, risonanza magnetica L'endoscopia e l'ecoendoscopia esofagea consentono: visualizzazione di diversi tipi di lesioni prelievo di un frammento bioptico con successivo esame citologico ed istopatologico manovre endoscopiche terapeutiche (estrazione di corpi estranei, dilatazioni, posizionamento di stent-endoprotesi);
III.Fisiopatologia dello stomaco
A. La fisiopatologia della motilità gastrica e dell'apparato sfinteriale
- Il buon svolgimento dell'attività motoria dello stomaco richiede una coordinazione perfetta tra tono, peristalsi e attività secretoria.
- Il tono gastrico garantisce l'adattamento permanente dello stomaco al contenuto.
- La peristalsi realizza la miscelazione del bolo alimentare con il succo gastrico, la sua trasformazione insostanze chimiche e evacuazione frazionata nel duodeno.
Disturbi del tono
a. Ipotonia: lo stomaco non può mobilitare il contenuto e così gli alimenti si accumulano nella parte inferiore che si allarga; accompagnata anche da ipoperistalsi e iposecrezione gastrica che favoriscono la fermentazione degli alimenti. b. Ipertonia: accompagna alcune malattie gastriche organiche come l'ulcera e la gastrite oppure funzionali come alcune malattie extra gastriche (infiammazioni dell'appendice, colica epatobiliare, colica renale, ipertiroidismo). C. Spasmo: forma estrema di aumento del tono provocata da cause gastriche oppure extra gastriche.
Disturbi del peristaltismo
a. Iperperistaltismo: stato puramente funzionale che appare nei fumatori, nevrotici, patologie del transito pilorico; caratterizzata dalla posizione alta dello stomaco che presenta movimenti peristaltici frequenti realizzando nodi (strangolamenti) funzionali seguiti da dolore. b. Ipoperistaltismo: riscontrato solitamente nell'atonia gastrica, nella cachessia, nelle malattie infettive; nella neoplasia gastrica diffusa la peristalsi è abolita. C. Dilatazione acuta dello stomaco: sindrome determinata dall'abolizione del tono gastrico e della peristalsi; lo stomaco è flaccido, disteso dalle proprie secrezioni e da quelle che refluiscono dal duodeno.
B. Fisiopatologia della secrezione gastrica
- Ipersecrezione
- Presente anche in assenza di cibo eccitante
- Molto spesso associato a iperacidità
- L'ipersecrezione funzionale è determinata dallo stimolo delle cellule parietali come risultato dell'attivazione vagale o umorale da parte della gastrina
- L'ipersecrezione organica può essere causata da lesioni della mucosa gastrica o da un aumento del numero totale di cellule parietali
- Iposecrezione
- È prodotta da fattori che colpiscono le cellule parietali del fondo o che deprimono i meccanismi di stimolazione della secrezione e può verificarsi in:
- Patologie gastriche (gastrite, cancro gastrico)
- Patologie endocrine ( ipogonadismo, ipertiroidismo, diabete, morbo di Addison)
- Patologie generali (disidratazione, malattie infettive acute, gravidanza)
- Disturbi della secrezione di muco Nei pazienti con ulcera duodenale si ha iposecrezione, mentre in quelli con gastrite ipertrofica si ha ipersecrezione di muco
- Disturbi della secrezione di pepsina
- La secrezione del pepsinogeno è stimolata dal nervo vago e quella umorale dalla gastrina
- L'ipersecrezione e l'iperacidità sono spesso accompagnate da aumenti del pepsinogeno, ma non