Fisiopatologia endocrina: sistema, paratiroidi e metabolismo fosfo-calcico
Documento del Prof. Paolo Marzullo su fisiopatologia endocrina. Il Pdf, utile per studenti universitari di Biologia, esplora il sistema endocrino, le paratiroidi e il metabolismo fosfo-calcico, con dettagli su diagnosi e trattamento di diverse condizioni endocrine.
Mostra di più37 pagine
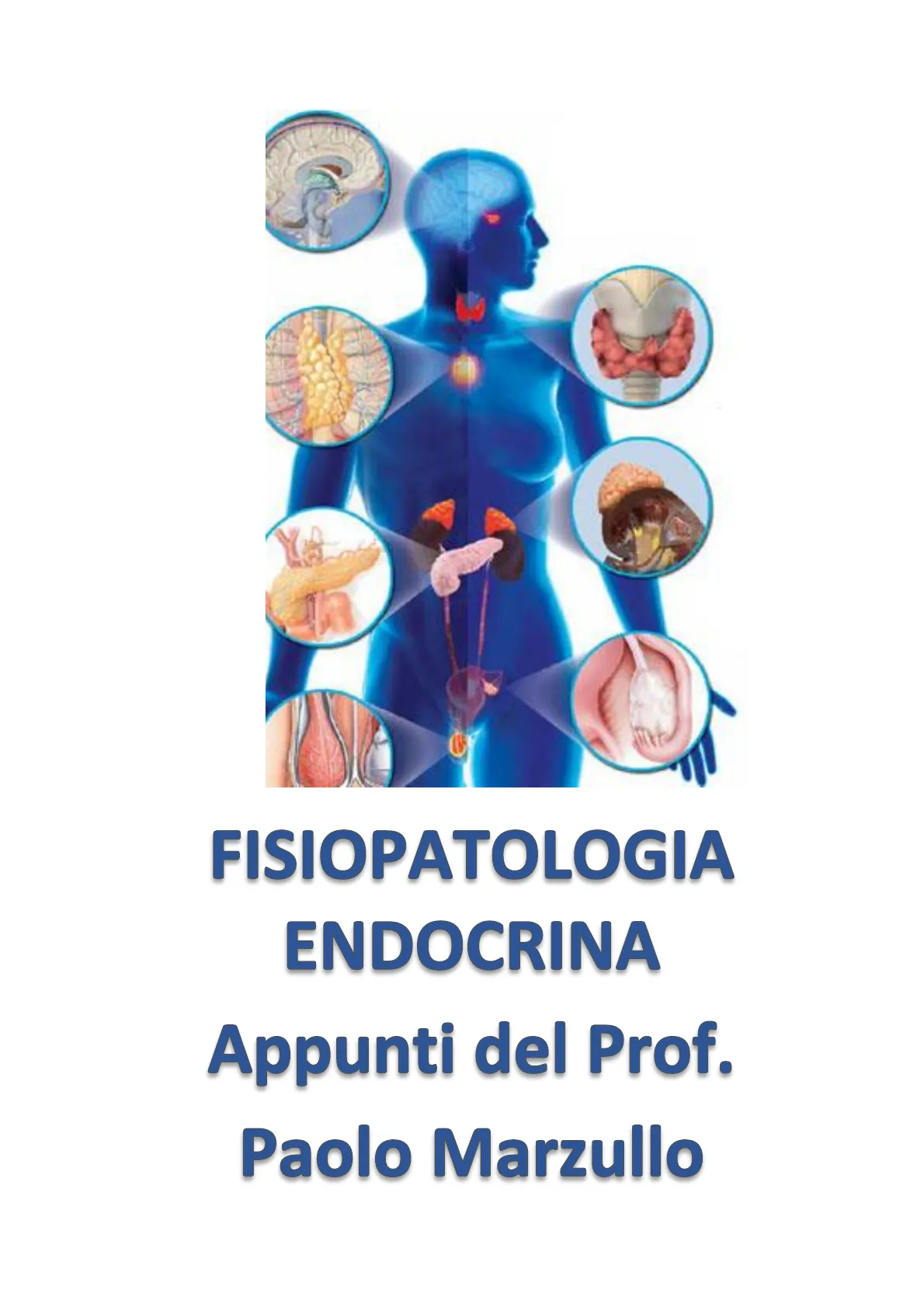
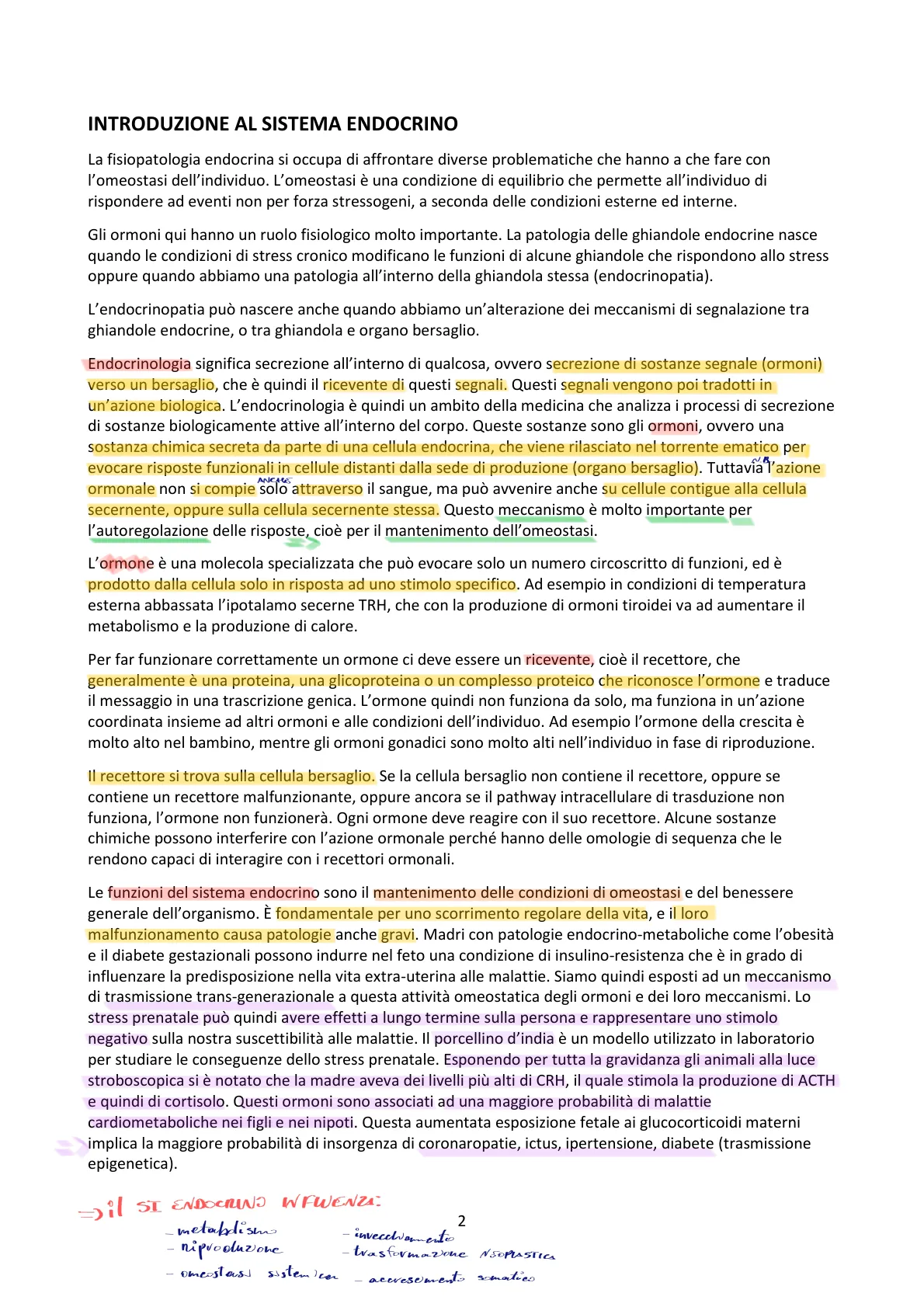
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
INTRODUZIONE AL SISTEMA ENDOCRINO
La fisiopatologia endocrina si occupa di affrontare diverse problematiche che hanno a che fare con l'omeostasi dell'individuo. L'omeostasi è una condizione di equilibrio che permette all'individuo di rispondere ad eventi non per forza stressogeni, a seconda delle condizioni esterne ed interne. Gli ormoni qui hanno un ruolo fisiologico molto importante. La patologia delle ghiandole endocrine nasce quando le condizioni di stress cronico modificano le funzioni di alcune ghiandole che rispondono allo stress oppure quando abbiamo una patologia all'interno della ghiandola stessa (endocrinopatia). L'endocrinopatia può nascere anche quando abbiamo un'alterazione dei meccanismi di segnalazione tra ghiandole endocrine, o tra ghiandola e organo bersaglio. Endocrinologia significa secrezione all'interno di qualcosa, ovvero secrezione di sostanze segnale (ormoni) verso un bersaglio, che è quindi il ricevente di questi segnali. Questi segnali vengono poi tradotti in un'azione biologica. L'endocrinologia è quindi un ambito della medicina che analizza i processi di secrezione di sostanze biologicamente attive all'interno del corpo. Queste sostanze sono gli ormoni, ovvero una sostanza chimica secreta da parte di una cellula endocrina, che viene rilasciato nel torrente ematico per evocare risposte funzionali in cellule distanti dalla sede di produzione (organo bersaglio). Tuttavia l'azione ANCHE ormonale non si compie solo attraverso il sangue, ma può avvenire anche su cellule contigue alla cellula secernente, oppure sulla cellula secernente stessa. Questo meccanismo è molto importante per l'autoregolazione delle risposte, cioè per il mantenimento dell'omeostasi. L'ormone è una molecola specializzata che può evocare solo un numero circoscritto di funzioni, ed è prodotto dalla cellula solo in risposta ad uno stimolo specifico. Ad esempio in condizioni di temperatura esterna abbassata l'ipotalamo secerne TRH, che con la produzione di ormoni tiroidei va ad aumentare il metabolismo e la produzione di calore. Per far funzionare correttamente un ormone ci deve essere un ricevente, cioè il recettore, che generalmente è una proteina, una glicoproteina o un complesso proteico che riconosce l'ormone e traduce il messaggio in una trascrizione genica. L'ormone quindi non funziona da solo, ma funziona in un'azione coordinata insieme ad altri ormoni e alle condizioni dell'individuo. Ad esempio l'ormone della crescita è molto alto nel bambino, mentre gli ormoni gonadici sono molto alti nell'individuo in fase di riproduzione. Il recettore si trova sulla cellula bersaglio. Se la cellula bersaglio non contiene il recettore, oppure se contiene un recettore malfunzionante, oppure ancora se il pathway intracellulare di trasduzione non funziona, l'ormone non funzionerà. Ogni ormone deve reagire con il suo recettore. Alcune sostanze chimiche possono interferire con l'azione ormonale perché hanno delle omologie di sequenza che le rendono capaci di interagire con i recettori ormonali. Le funzioni del sistema endocrino sono il mantenimento delle condizioni di omeostasi e del benessere generale dell'organismo. È fondamentale per uno scorrimento regolare della vita, e il loro malfunzionamento causa patologie anche gravi. Madri con patologie endocrino-metaboliche come l'obesità e il diabete gestazionali possono indurre nel feto una condizione di insulino-resistenza che è in grado di influenzare la predisposizione nella vita extra-uterina alle malattie. Siamo quindi esposti ad un meccanismo di trasmissione trans-generazionale a questa attività omeostatica degli ormoni e dei loro meccanismi. Lo stress prenatale può quindi avere effetti a lungo termine sulla persona e rappresentare uno stimolo negativo sulla nostra suscettibilità alle malattie. Il porcellino d'india è un modello utilizzato in laboratorio per studiare le conseguenze dello stress prenatale. Esponendo per tutta la gravidanza gli animali alla luce stroboscopica si è notato che la madre aveva dei livelli più alti di CRH, il quale stimola la produzione di ACTH e quindi di cortisolo. Questi ormoni sono associati ad una maggiore probabilità di malattie cardiometaboliche nei figli e nei nipoti. Questa aumentata esposizione fetale ai glucocorticoidi materni implica la maggiore probabilità di insorgenza di coronaropatie, ictus, ipertensione, diabete (trasmissione epigenetica).
- il SI ENDOCRINO INFLUENZA.
- metabolismo
- invecchiamento
- riproduzione
- trasformazione NEOPLASTICA
- omeostasi sistemica - accrescimento somatico
Il sistema endocrino regola l'omeostasi attraverso una serie di interazioni con il cervello, col sistema immunitario e col sistema cardiovascolare. Esistono ad esempio dei neurotrasmettitori, come dopamina, adrenalina e noradrenalina che sono comuni a cellule endocrine e a neuroni, comportandosi quindi sia come ormoni che come neurotrasmettitori. Esistono peraltro delle cellule con caratteristiche sia nervose che endocrine, che si chiamano cellule neuroendocrine e che sono deputate alla produzione dei neurotrasmettitori. Questi neurotrasmettitori quindi lavorano sia sul sistema nervoso, ma possono lavorare anche come ormoni sul sistema endocrino. Il sistema endocrino è organizzato con un sistema circoscritto composto dalle ghiandole endocrine (ipofisi, epifisi, timo, tiroide, paratiroidi, surreni, pancreas, gonadi) e un sistema diffuso, cioè cellule organizzate in cluster/network più o meno sparse in tutti gli organi. Ad esempio si trovano nella ghiandola mammaria, nella pelle, nell'occhio, nel polmone, nello stomaco e nell'intestino. Ad esempio nello stomaco la gastrina stimola le cellule a secernere acido cloridrico. L'intestino invece contiene le cellule L che sono deputate alla produzione di incretine, che giungono allo stomaco, al pancreas e al cervello, e regolano la prima fase della digestione, cioè l'assorbimento dei nutrienti, attraverso la secrezione di insulina. Le incretine, soprattutto il GLP1, rappresenta un ormone sul quale sono stati costruiti tra i più potenti farmaci per il diabete e l'obesità. Tutto nasce e torna all'ipotalamo. Esso contiene moltissimi nuclei, ognuno dei quali è deputato ad una funzione. I nuclei secernono dei neurofattori che controllano il sistema ormonale, la riproduzione, la temperatura, il bilancio dei liquidi, l'alimentazione, l'invecchiamento. L'organizzazione del sistema endocrino è quindi gerarchica. L'ipotalamo manda segnali e riceve i feedback che lo aiutano ad aggiustare la propria attività. L'ipotalamo produce dei fattori e manda i suoi segnali all'ipofisi. L'ipofisi anteriore è deputata alla produzione di 6 ormoni: LH, FSH (gonadotropine), ACTH, PRL, GH e TSH, ognuno dei quali andrà al proprio tessuto bersaglio. L'ipofisi posteriore invece è deputata alla - poi or cells. produzione di ossitocina e vasopressina, che servono rispettivamente alla contrazione uterina e alla regolazione dei liquidi. L'ossitocina non è soltanto responsabile della regolazione del parto, ma anche al BERSAGLIO social-bonding, cioè la capacità di stringere relazioni con gli altri. L'ossitocina regola anche l'appetito, la menopausa e l'obesità influenzano la produzione di ossitocina, tanto che viene utilizzata anche come un farmaco, ad esempio nel trattamento della depressione. L'attività ormonale può essere:
- Endocrina: l'azione sul target avviene dopo il trasporto dell'ormone per via ematica
- Autocrina: la ghiandola si autoregola con un feedback su se stessa perché presenta il recettore per l'ormone che produce
- Paracrina: l'azione di modulazione è locale, cioè su cellule vicine a sé che esprimono il recettore per l'ormone
- Neuroendocrina: l'azione sul target avviene dopo il trasporto dell'ormone tramite la via nervosa. Vengono coinvolte quindi cellule nervose che sono anche cellule endocrine. Hanno probabilmente dei geni inducibili che permettono loro di essere cellule neuroendocrine e produrre quindi neurofattori
Categorie di ormoni
Esistono 3 categorie di ormoni:
- Ormoni proteici: agiscono sulla cellula bersaglio interagendo necessariamente con un recettore di membrana poiché essi essendo proteine (idrofili) non riescono ad attraversare il doppio strato fosfolipidico. Il recettore poi traduce il messaggio nell'ambiente intracellulare
- Derivati degli amminoacidi: ad esempio tirosina ed epinefrina
- Steroidi: ad esempio cortisolo ed estradiolo che derivano dal colesterolo, permeano la membrana perché lipofili, e vanno ad incontrare il recettore all'interno della cellula o all'interno del nucleo. La gran parte degli interferenti endocrini sono lipofili, per cui riescono a penetrare nella cellula senza nessun aiuto
Precursori ormonali
I pre-pro-ormoni sono precursori ormonali, ovvero l'ormone nella sua fase precoce. Non è detto che da un unico pre-pro-ormone si abbia un solo ormone, anzi esso potrà produrre più ormoni differenti, a seconda di come viene tagliato. Ad esempio dal clivaggio del POMC (proopiomelanocortina) si ottiene l'ACTH, ma anche la beta-endorfina (importante per la nocicezione), l'alfa-MSH (neurofattore deputatato alla pigmentazione cutanea ma anche alla produzione delle melanocortine). Anche il POMC esso stesso è un neurotrasmettitore importante per recepire i messaggi di sazietà a livello dei nuclei ipotalamici. È un meccanismo di risparmio per il nostro organismo. es. La pro-insulina invece ci dà l'insulina e il peptide C. Sembra che il peptide C non abbia un ruolo, ma in realtà viene utilizzato dal medico per diagnosticare il diabete di tipo I, perché è una spia importante della capacità del pancreas di secernere insulina. Il diabete di tipo I è caratterizzato dalla distruzione delle cellule secernenti insulina, per cui dobbiamo sempre iniettare insulina dall'esterno. Se noi dosassimo l'insulina, doseremmo quella che gli abbiamo iniettato, per cui si procede dosando il peptide C. I surreni possono produrre oltre 50 diversi ormoni, i quali derivano da alcuni precursori principali. Se il flusso di sintesi non funziona bene risulta in un difetto degli ormoni finali e in un accumulo degli ormoni a monte. Alcuni ormoni hanno una secrezione pulsatile, ovvero avviene ad impulsi generati ogni 20-30 minuti nel corso della giornata. Ad esempio il GH ha dei picchi di secrezione che tendono ad aumentare durante la notte sia come ampiezza che come frequenza. Altri ormoni hanno invece un ritmo circadiano, ad esempio l'ACTH viene maggiormente secreto nel pomeriggio/sera, per poi diminuire durante la notte. Altri ormoni hanno invece un comportamento poco pulsatile e poco ritmico, poiché dipendente dalle fasi di sviluppo dell'individuo, ad esempio gli androgeni e gli estrogeni, che vengono secreti maggiormente dopo la pubertà. Un esempio di modulazione del rilascio ormonale è il ciclo ovarico, che si distingue in una fase follicolare, nella quale si sviluppa il follicolo, e una fase luteinica, nella quale ho la atresia follicolare. La prima fase è dominata dall'ormone follicolo-stimolante (FSH), mentre la seconda dall'ormone luteinizzante (LH). Nella prima fase si producono molti estrogeni, mentre nella seconda fase il corpo luteo inizierà a produrre progesterone. Il dosaggio del progesterone quindi mi dice se il ciclo è stato ovulatorio. Per poter circolare nel torrente ematico, un ormone deve essere legato ad una proteina o può circolare in forma libera. Gli ormoni tiroidei e steroidei, essendo lipofili necessitano di una proteina carrier, per cui quando vi si legano per essere trasportati nel sangue si trovano nella forma inattiva. Gli ormoni proteici invece non necessitano di un carrier, per cui nel sangue si possono trovare già nella forma attiva. Quando misuriamo nel sangue un ormone generalmente misuriamo le concentrazioni totali dell'ormone, che comprendono la componente legata alla proteina di trasporto e la componente libera. Esistono anche dosaggi specifici per l'ormone libero, ad esempio la spettrometria di massa. Il recettore fa si che l'ormone possa funzionare. Non esistono difetti globali dei recettori, per cui in genere anche se in numero molto piccolo, ma vengono sempre espressi. Tutte le volte in cui abbiamo un difetto recettoriale o post-recettoriale (difetto della trasduzione del segnale intracellulare) si innesca una resistenza ormonale. La resistenza ormonale è quindi quella situazione in cui l'ormone è presente nella giusta quantità, ma il recettore è difettoso o non funzionale e quindi l'ormone non può svolgere il suo lavoro. Nel caso di recettori di membrana la risposta è rapida e massimale quando sono occupati il 20% dei recettori. Il restante 80% è di riserva (spare receptors). Nel caso invece di recettori citosolici o nucleari la risposta è lenta (devono avere il tempo di modificare l'espressione genica) ed esiste una relazione quasi lineare tra il numero di recettori occupati e la potenza della risposta biologica.
Tipi di recettori
I principali tipi di recettori sono: