La Visione, il sistema ipotalamo-ipofisario e il sistema nervoso autonomo
Documento di Università sulla visione, il sistema ipotalamo-ipofisario e il sistema nervoso autonomo. Il Pdf di Biologia, utile per gli studenti universitari, esplora la retina, i fotorecettori, il processo di fototrasduzione e le funzioni del sistema nervoso autonomo.
Mostra di più45 pagine

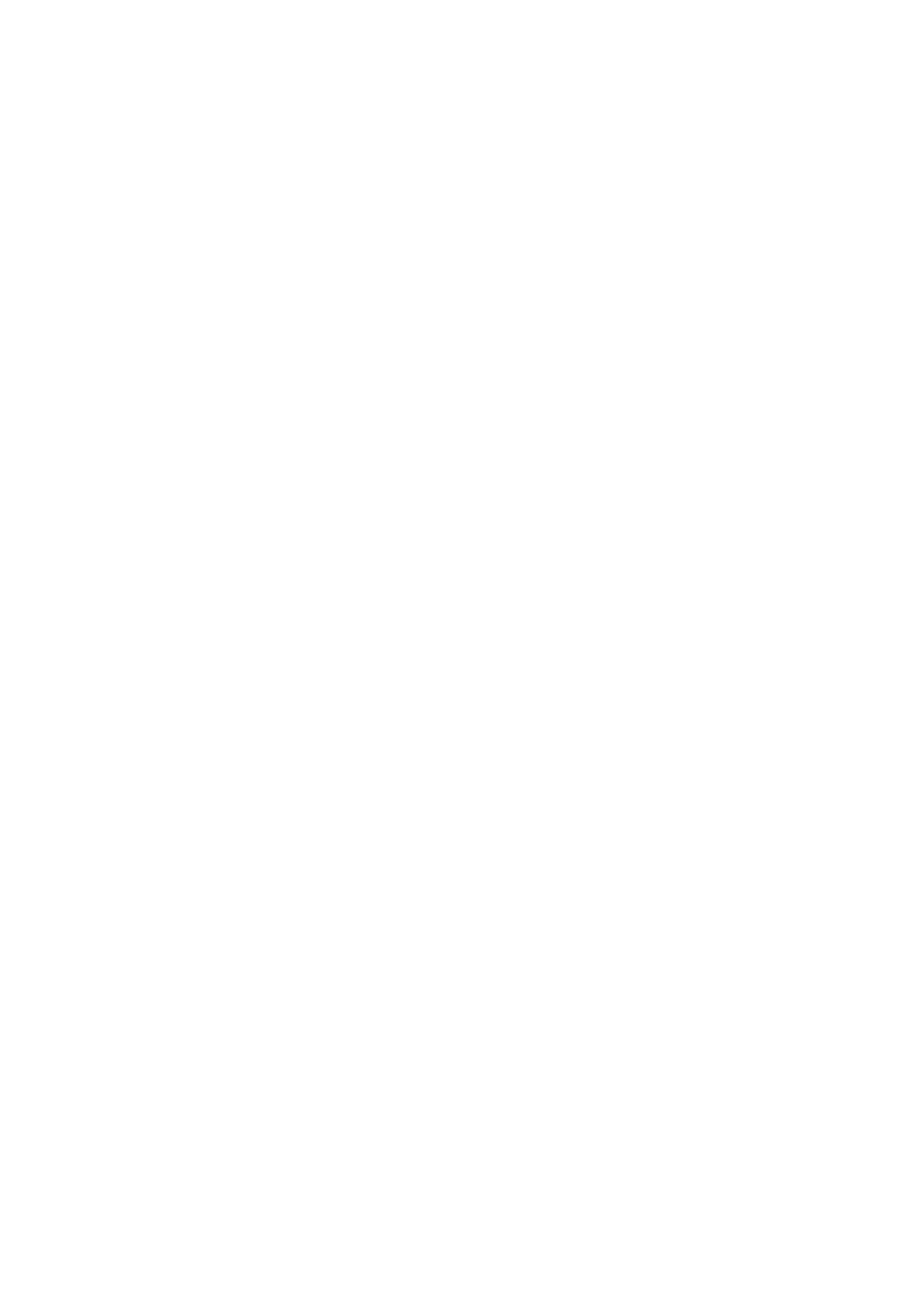
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
La Visione
1- LA VISIONE? La visione è il senso più importante per l'uomo e questo avviene tramite Il sistema visivo (occhio) che ci consente di discriminare dettagli. Nell'occhio c'è la retina che costituisce la parte fotosensibile dell'occhio e contiene un circuito neuronale il cui compito è quello di trasformare le immagini ottiche proiettate sui fotorecettori in immagini nervose utilizzabili dai centri superiori. I fotorecettori presenti sulla retina sono i coni e i bastoncelli. I coni e i bastoncelli si collegano a cellule intermedie chiamate cellule bipolari (sono le seconde cellule nell'ordine della retina). A loro volta i fotorecettori, le cellule bipolari e le cellule gangliari ( Le terze cellule o i neuroni del terzo strato ) sono connessi tra di loro trasversalmente da alcuni altri tipi di cellule che sono le cellule orizzontali e le cellule amacrine.Le cellule orizzontali e amacrine combinano tra di loro i segnali che arrivano dai fotorecettori.
Distribuzione di Coni e Bastoncelli
Dal punto di vista della distribuzione dei bastoncelli e dei coni, i coni sono maggiormente distribuiti nella fovea (retina centrale) mentre i bastoncelli sono maggiormente distribuiti nella regione della retina laterale. La fovea serve a distinguere i dettagli e i colori; è quella che ci genera la visione a colori ricca di dettagli che è quella che normalmente arriva al nostro sistema di coscienza .Ciò che deriva dalle zone periferiche invece non arriva alla coscienza. Le zone periferiche catturano le variazioni di luce e di movimento delle immagini e consentono di indirizzare l'occhio verso altri punti di riferimento. I bastoncelli sono sensibili alla luce notturna e hanno una notevole sensibilità a questa banda luminosa. Per vedere i colori si sono differenziati i coni. I pigmenti espressi dai coni differiscono dalla rodopsina dei bastoncelli. I coni, infatti, contengono pigmenti simili ma non identici alla rodopsina, detti conopsine. I coni si sono distinti in tre categorie: i coni per il blu, i coni per il verde e i coni per il rosso. Ognuno di questi coni ha una certa banda cromatica. Immaginiamo che arrivi un raggio luminoso di lunghezza di 500nm. Questo raggio luminoso genera una piccola attivazione del cono blu, una forte attivazione del cono rosso e un'attivazione ancora più forte nel cono verde. Il sistema nervoso ha imparato a livello di circuiti centrali (non della retina) a combinare il contributo di questi coni, in modo che per ogni combinazione di blu, verde e rosso si generi un colore diverso (si genera una gamma di colori diversi e di diverse tonalità). Noi distinguiamo 16.000 colori anche se abbiamo 3 tipi diversi di recettori perché il sistema è Combinatorio. La specificità del colore non viene definita dal retinale ma dall'opsina che gli sta intorno.
Processo di Fototrasduzione
COSA IL PROCESSO DI FOTOTRASDUZIONE ?(DOMANDE ESAME) LA FOTOTRASDUZIONE: rappresenta il processo mediante il quale l'energia luminosa viene convertita in segnali elettrici, poiI fotoni entrano nei dischi (dove ci sono delle molecole a 7 domini transmembrana e nel loro parete c'è il retinale ) e colpiscono una molecola che si chiama retinale a questo punto Si forma un complesso tra la molecola proteica che si chiama opsina e il retinale, Questo complesso prende il nome di rodopsina. A questo punto il fotone scarica l'energia nella catena di legami del retinale. Questi legami, una volta "energizzati" cambiano stato da forma cis a trans . A questo punto la molecola proteica dell'opsina espone un sito recettoriale per una proteina G che si chiama trasducina. Una volta che la trasducina viene attivata, libera la subunità a e la sub a va a legarsi a una fosfodiesterasi. La fosfodiesterasi demolisce il GMP ciclico producendo GMP. Alla fine di questo processo una grande quantità di GMP ciclico viene demolita. La riduzione del GMP ciclico determina una modifica del gating di un canale ionico che è il CNG (canale con in gating controllato dai nucleotidi ciclici, in particolare GMP ciclico). Quando il GMP ciclico cala a causa del processo di trasduzione questo canale si chiude e la cellella si iperpolarizza (in condizioni di buio questo canale è aperto ma nel momento in cui arriva la luce questo si chiude). Nel momento in cui il canale si chiude si è completato il processo di trasduzione del segnale.
Elaborazione del Segnale Visivo
COME AVVIENE L' ELABORAZIONE DEL SEGNALE VISIVO ? PRIMA DI STIDIARLA VEDI L'IMMAGINE - PAGINE 21 Tutti i punti luminosi vengono rilevati due volte (una volta dall'occhio di destra e una volta dall'occhio di sinistra). Questo fenomeno porta ad un'organizzazione particolare del cosiddetto chiasma ottico. Il chiasma ottico è il punto in cui le fibre del nervo ottico si incrociano parzialmente. Ciascun nervo ottico contiene gli assoni provenienti da una retina (RETINA temporale e RETINA nasale). Ciascun tratto ottico contiene gli assoni che ricevono segnali dalla metà contro-laterale del campo visivo. I tratti ottici che originano dal chiasma vanno a finire nei talami di sinistra e di destra. L'emicampo di destra va a finire sulla retina di destra e sulla retina temporale di sinistra; grazie all'operazione di incrocio parziale delle fibre del chiasma, tutto l'emispazio di destra finisce nel talamo di sinistra. Viceversa, tutto l'emispazio di sinistra finisce nel talamo di destra. Dal talamo (corpo genicolato laterale) i segnali vengono trasmessi alla corteccia. Nel talamo avvengono diversi processi di riarrangiamento dei segnali che sottoforma di potenziali d'azione vengono poi trasmessi alla corteccia. Grazie a questa relazione piuttosto immediata tra la retina e la corteccia è stato possibile utilizzare la corteccia visiva come "banco di prova" per capire come funziona la corteccia in generale. La corteccia lavora con un'organizzazione in colonne che si chiamano colonne corticali. Le colonne corticali nel caso della corteccia visiva si chiamano colonne di orientamento oculare.La corteccia visiva (oppure area 17 o V1) si trova nella regione occipitale del cervello ed è organizzata in 6 strati. Le colonne corticali sono strutture verticali cheattraversano tutti gli strati, hanno un diametro di 300 micron, contiene circa 35.000 neuroni.Se calo verticalmente un microelettrodo nella corteccia cerebrale a livelli più profondi ovunque vadano trovo una risposta sempre uguale, se invece viene calato in modo tangenziale (attraversando più colonne) la risposta cambia. Viene fatta vedere una barretta luminosa in tutte le direzioni, le colonne corticali sono sensibili a questi orientamenti e scaricano solo quando vedono un certo orientamento.Le colonne sono quindi in grado di rispondere a barrette di luce orientate in modo differente. La corteccia cerebrale (evisiva primaria) riconosce l'orientamento delle barre di luce.Andando avanti a studiare l'organizzazione di queste colonne scopriamo qualcosa di più. All'interno di questi sistemi di colonne ci sono delle bolle chiamate blob che sono responsivi al colore (sensibili al colore e non all'orientazione degli stimoli). Questo consente di combinare l'informazione relativa ai contorni con l'informazione relativa ai colori. (tutto questo fa parte della corteccia visiva primaria).L'immagine viene vista come sequenza di segmenti collegati fra loro, ciascun segmento corrisponde a una colonna nella corteccia; per formare l'immagine quindi la corteccia deve attivare tante colonne limitrofe che vedono diversi orientamenti. Nella corteccia visiva secondaria viene rimontata l'immagine a partire da punti, i neuroni mettono insieme tutti i segmenti e fanno l'immagine quindi l'elaborazione avviene a stadi. Prima si costruisce il contorno e poi all'interno viene messo il colore. Nella corteccia terziaria, l'immagine prende forma 3D e nella quaternaria subentra il movimento e così via, fino a quando si sconfina nella corteccia somatosensiorale secondaria VII dove convergono tutti i segnali di tipo visivo, somatosensoriali, auditivo. In questo modo nell'area somatosensoriale viene ricostruita la natura dell'oggetto.
Il Controllo Motorio
2- IL CONTROLLO MOTORIO? Il controllo motorio consente all'organismo di muoversi.è organizzato da:
- sistemi di controllo superiore (corteccia, gangli della base e cervelletto);
- sistemi intermedi che sono generatori centrali di pattern (tronco encefalico e midollo spinale);
- sistemi periferici che sono gli organi effettori (sistema muscolo-scheletrico)
- infine dall'ambiente torna un feedback e feedforward : sistemi di controllo superiore:
- La corteccia cerebrale (ovvero corteccia motoria) con le aree motorie è in grado controllano la decisione del movimento e il piano del movimento.
- gangli della base : che consentono di selezionare l'azione giusta .
- Cervelletto : è una regione dell'encefalo. Ha diversi compiti, principalmente, è coinvolto nell'apprendimento e nel controllo motorio.
Ruolo del Cervelletto nel Controllo Motorio
Nel controllo motorio riceve informazioni dalle aree motorie sensoriali e proietta alle aree motorie. In quanto è connesso con la corteccia motoria.In particolare quello che succede che La corteccia motoria genera dei segnali discendenti che vengono mandati al cervelletto , Dove vengono elaborati dal cervelletto e successivamente passano al ponte (tronco encefalico); dal ponte i segnali vengono inviati al midollo spinale e poi ai muscoli (periferia). Allo stesso tempo, il midollo spinale che riceve segnali dai muscoli, dalla cute ecc manda segnali ascendenti al cervelletto. Il cervelletto si trova esattamente nel punto in cui può confrontare la decisione motoria prodotta dalla corteccia con lo stato effettivo del movimento generato dai sistemi sensoriali del corpo. In sostanza, il cervelletto paragona il piano motorio che viene generato a livello della corteccia con lo stato attuale sensoriale che viene convogliato verso il sistema nervoso dai sistemi sensoriali del corpo (es sistema somatosensoriale, visivo, auditivo ecc.) Il cervelletto, paragonando questi due stati (quello proveniente dalla corteccia e quello dal sistema sensoriale) capisce se l'esecuzione motoria coincide con il piano motorio. Se questi due stati non coincidono ed è presente un errore nell'esecuzione del movimento, il cervelletto è in grado di misurare tale errore e di generare un comando motorio che lo annulli. Questa correzione, tramite dei circuiti complessi può essere inviata sia al tronco encefalico e quindi ai motoneuroni, sia a marcia indietro alla corteccia per correggere il piano motorio stesso.
Sistemi Intermedi e Motoneuroni
- sistemi intermedi che sono generatori centrali di pattern (tronco encefalico e midollo spinale); . Il tronco dell'encefalo contiene due sistemi neuronali disposti in parallelo, il sistema mediale e quello laterale i cui assoni proiettano alle reti degli interneuroni e dei motoneuroni del midollo spinale. I motoneuroni : formano la via finale comune attraverso la quale ogni stimolo motorio deve passare affinché possa avvenire la contrazione muscolare. E ci sono diversi tipi : I motoneuroni a : innervano le fibre muscolari primarie, i motoneuroni y: innervano le fibre dei fusi neuromuscolari, i motoneuroni ß: innervano (meno numerosi) entrambi i tipi di fibre. Un motoneurone a e tutte le cellule muscolari da esso innervate formano l'unità motoria. Queste unità motorie sono classificate in tre diversi tipi in base alla forza sviluppata, alla velocità di contrazione e alla resistenza alla fatica:
- Le unità motorie che si contraggono e rilasciano lentamente, durante una singola scossa, e che sono molto resistenti alla fatica sono definite di tipo S (Slow): esse dipendono in larga misura dal metabolismoossidativo e sviluppano contrazioni deboli.
- Le unità motorie che si contraggono rapidamente sono invece definite FF (fast fatiguable: rapide e facilmente affaticabili) o FR (fast fatigue-resistent: rapide e resistenti alla fatica). Le