L'arte dell'Ottocento: dinamiche artistiche e culturali del XIX secolo
Documento da Einaudi su L'arte dell'Ottocento. Il Pdf, di tipo universitario e dedicato all'Arte, riassume il libro di Federica Rovati, esplorando le scelte stilistiche, le censure politiche e le diverse correnti artistiche del XIX secolo.
Mostra di più39 pagine
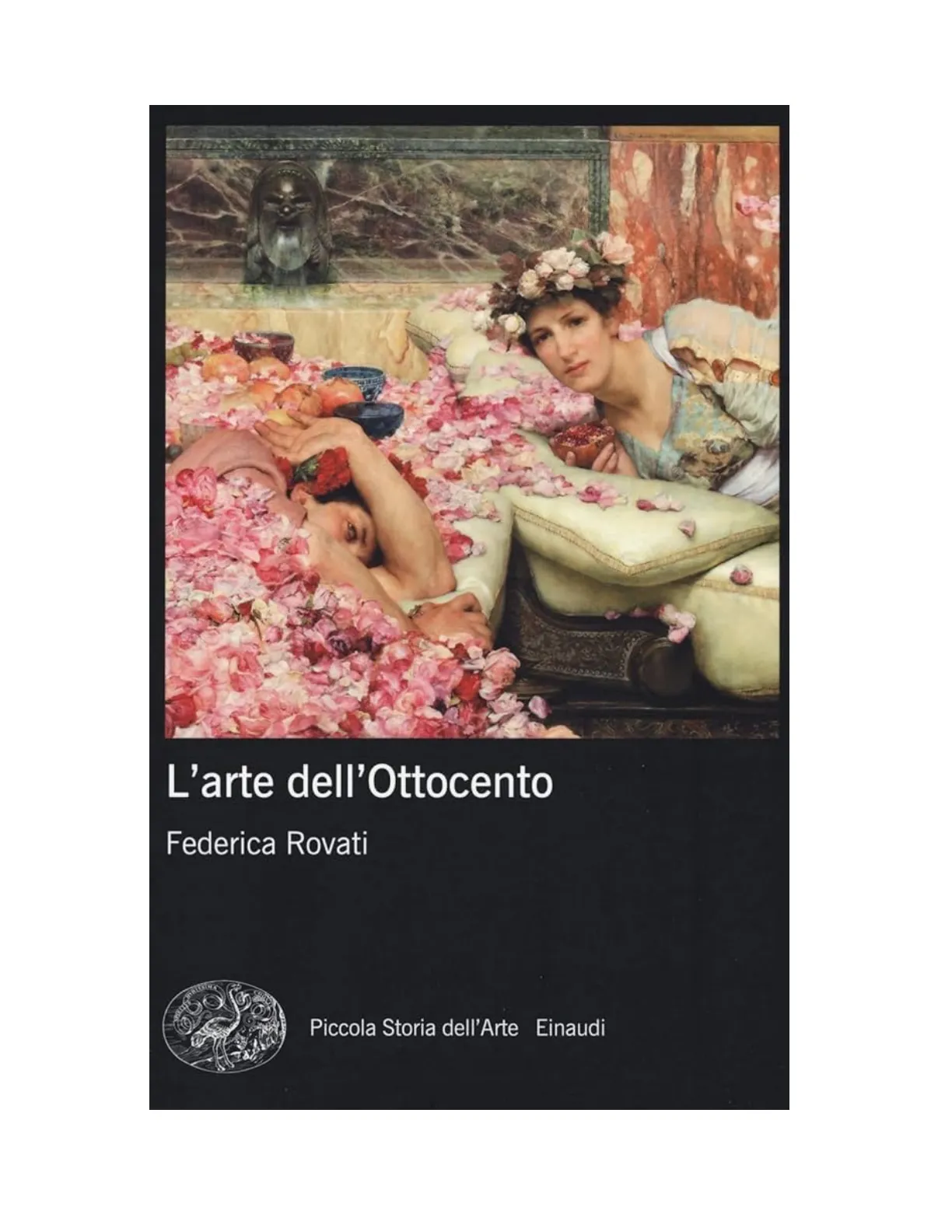
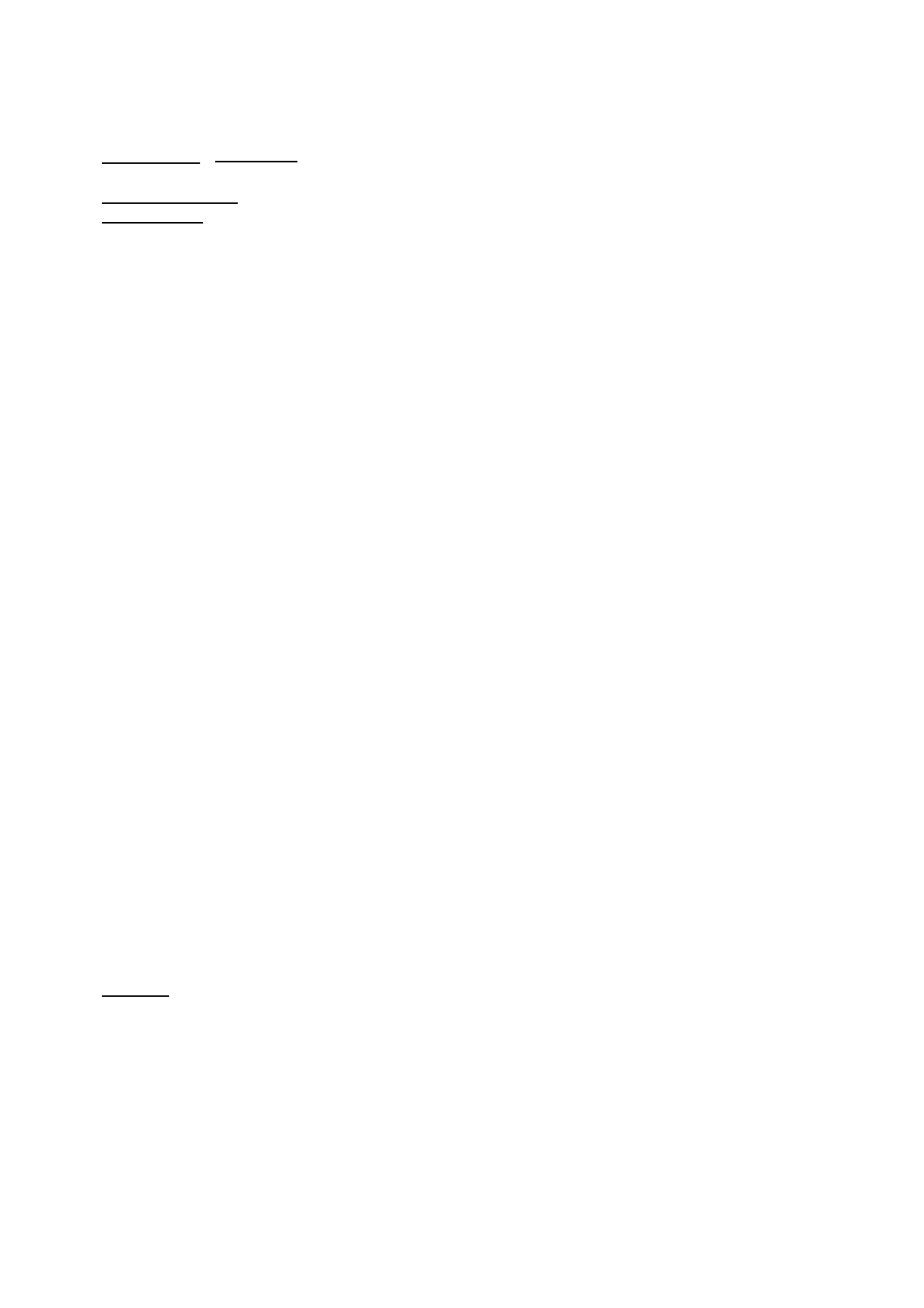
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
L'arte dell'Ottocento
Federica Rovati Piccola Storia dell'Arte EinaudiL'ARTE DELL'OTTOCENTO - Federica Rovati (Riassunti)
Capitolo primo - Scelte di stile
Fra passato e presente
Silenzi e censure
Nel giugno del 1814 l'appena restaurato regno borbonico decise di organizzare il Salon parigino, per rassicurare l'opinione pubblica. Nessuno degli artisti però riuscì a misurare le proprie ambizioni nella pittura storica, dato che tutte le tele ruotavano intorno alla figura di Napoleone. Quindi molti si rifugiarono nei paesaggi e nei ritratti, oppure nei soggetti mitologici. Era subentrato un sollievo per la misura domestica consona alla pace ritrovata, ma questo silenzio opposto a "Cuirassier blessé quittant le combat" di Géricault rivela come le ragioni politiche interferiscono nel giudizio artistico più di quanto non facevano in passato. Il confronto con "Officier de chasseurs à cheval de la garde impérial chargeant", sempre di Géricault, nuovamente esposto al Salon dopo aver preso una medaglia in quello precedente, contribuisce ad enfatizzare l'immagine recente: l'inizio della campagna russa che doveva risultare in una vittoria schiacciante, e la sua vergognosa fine.
Con la sconfitta di Napoleone il confronto politico diventa più aspro, arrivando a repressioni violente e pesanti censure:
- David condannato all'esilio;
- la statua dell'imperatore venne fusa;
- reintegrazione di monumenti distrutti durante la rivoluzione;
- commemorazione di Luigi XVI nel luogo della decapitazione e celebrazione della dinastia borbonica.
Queste iniziative furono dirette a ristabilire i vecchi equilibri e segnarono tutte le capitali europee, nelle quali si trovavano i beni depredati dall'esercito francese. Quest'ultime, infatti, reclamavano la restituzione delle opere, anche dei doni liberamente elargiti: ad esempio, Pio VII restituì all'Università di Heidelberg 847 manoscritti e libri di "scienze naturali".
Gli artisti, invece, protestavano contro la "scuola francese": Hayez la giudicava dura e falsa; per i tedeschi era intollerabile; per gli inglesi, invece, non era mai stata un modello plausibile. L'obiettivo delle polemiche era la lezione davidiana, la cui evidenza formale aveva espresso i vecchi ideali.
A Roma, nel 1819, fu allestita un'esposizione per l'arrivo dell'Imperatore austriaco. Questa venne vista come la prova della nascita di una vera e propria scuola tedesca; adesso, l'assunzione di stilemi medievali nella loro arte, fu vista come un sintomo di progresso, anche se prima era biasimata.
Nel contesto francese le opzioni stilistiche, invece, si ampliarono in diverse direzioni, come se volessero rinunciare ad una lingua univoca per evidenziare un allontanamento dal recente passato. Le opere capitali di David fluivano nella grafica satirica come paragone polemico per il presente; nelle litografie di Géricault, invece, la miseria attuale era rivelata dai reduci maltrattati dell'esercito napoleonico.
La fedeltà di Géricault alla monarchia si era incrinata per colpa degli abusi realizzati dal governo. Fu un episodio in particolare a farlo riflettere: il naufragio di una nave francese diretta in Senegal, che mise in luce l'incompetenza degli ufficiali borbonici, le manovre per insabbiare la vicenda e la terribile degradazione dell'umanità. Nella "Radeau de la Méduse" erano rappresentati cadaveri non compromessi dagli stenti con una tonalità livida su tutti i soggetti, sia morti che vivi. Questi, visti come errori, sono in realtà quelli che esprimono le mescolanze tra vita e morte avvenute sulla zattera, evocando gli episodi di cannibalismo realizzati dai superstiti. Nei suoi studi preparatori, Géricault aveva studiato su pezzi anatomici presi all'obitorio, non su nudi accademici. La presentazione di questo dipinto al Salon del 1819 non danneggiò però il sovrano, perché si pensava che, se il contenuto del dipinto fosse stato scomodo, questo non sarebbe stato esposto. La sua novità formale deviò lo sguardo dalla realtà storica: nazionalità dei naufraghi, tempo e luogo erano vaghi, quindi non poteva essere utilizzata propagandisticamente dagli avversari politici del sovrano.
Alternative
Un impresario inglese spostò il valore del "Radeau de la Méduse" sul piano commerciale, sfruttando che il fatto rappresentato, in Inghilterra, dimostrava l'incapacità francese di governare mari e colonie. La critica inglese apprezzò di questo dipinto il distacco dal modulo davidiano, ritenuto troppo compromesso con l'ex regime napoleonico, riconoscendoci anche l'apertura di un nuovo discorso per l'arte francese. Il confronto fatto con la realtà inglese metteva in evidenza gli sbagli realizzati nel sistema artistico francese: gli artisti inglesi non avevano mai fruito della committenza statale, che preferiva favorire le iniziative private di galleristi e artisti, anche se, ogni anno, la Royal Academy garantiva un appuntamento per presentare nuove opere. In Francia, il Salon, con cadenza biennale, è stato alterato sia nel periodo rivoluzionario che adesso durante la restaurazione borbonica, dilazionandone la cadenza per Document shared on https://www.docsity.com/it/l-arte-dell-ottocento-rovati/4675941/ Downloaded by: benedetta-baldi-3 (baldibenedetta40@gmail.com)indirizzare le scelte artistiche verso una realizzazione di opere gradite alla giuria accademica: gli artisti non potevano rifiutarsi a ciò, perché la non presenza dei loro dipinti nel Salon avrebbe compromesso la loro fama e le loro vendite.
L'unica novità nel contesto francese fu quella dell'apertura del Musée du Luxembourg: nuova sede istituzionale dedicata alle opere contemporanee. Questo era il luogo dove, dopo l'esposizione al Salon, si sarebbe collocato la "Radeu de la Méduse", che non fu acquistata da nessuno. Géricault cercò, quindi, di portare lo sguardo degli osservatori sui valori pittorici, censurando i contenuti polemici. Egli scrisse che una stessa opera poteva essere interpretata diversamente dalle persone: per alcune poteva avere un'espressione nazionale, per altre era una composizione rivoluzionaria. Géricault stesso fu accusato di aver diffamato, con una sola opera, tutta la Marina francese.
In questo periodo le gallerie d'arte aveva acquistato un tono insolito, per avvicinare nuovo pubblico così da guadagnare non solo sulla vendita delle opere, ma anche sulla vendita dei biglietti d'ingresso. Ad esempio, all'Egyptian Hall (dove fu esposta anche l'opera di Géricault), oltre ai reperti dell'antico Egitto erano stati sposti anche animali impagliati. Anche le gallerie parigine si adattarono a questo modello, dove, ai dipinti, si sommavano altri oggetti come mobili o bambole. Fu in questo periodo che fu inventata la litografia: si potevano stampare riproduzioni a basso prezzo; questa divenne infatti il mezzo migliore per insinuarsi nelle abitudini del pubblico non ricco.
Horace Vernet (che aveva realizzato una strage dei Mamelucchi che velava i recenti massacri perpetrati dall'esercito borbonico a Marsiglia) presentò al Salon del 1822 un dipinto celebrativo della resistenza francese a Clichy, insieme ad una tela con la rievocazione della battaglia di Jemmapes. Entrambe le tele furono però respinte, con la richiesta di censurare la presenza del tricolore, bandito nel territorio francese. Vernet si rifiutò e organizzò nel suo atelier un'esposizione di tutti i suoi quadri, comprese queste due tele. Egli fu il primo pittore a contestare il giudizio della giuria.
Un Medioevo da inventare
Non era insolita l'esigenza di attribuire all'attualità forme e stili del passato; ad esempio, l'età neoclassica si era configurata su questa ambizione. Questa operazione marca un dissidio nella realtà contemporanea, che si voleva riformare sui valori individuali nelle epoche trascorse. La nuova voga medievalistica si distingue, adesso, per la dimensione istituzionale. I caratteri salienti dell'arte medievale, riassunti dallo stile gotico fino alle opere quattrocentesche, furono individuati come strumenti utili alla definizione dell'identità presente. Prospettive politiche e nostalgie di incrociarono, assumendo valenze diverse in diversi contesti. Abbiamo diversi esempi:
- Ritratto dell'Imperatore Federico II d'Austria, Re Federico Guglielmo III di Prussia e lo zar Alessandro I con addosso armature metalliche che rimandano a vocazioni cavalleresche, per celebrare la costituzione della Santa Alleanza.
- La cappella gotica in rovina in Huttens Grab di Friedrich, che trasmette nostalgia per un disegno politico fallito, quello del movimento liberale.
- Il monumento di Kreuzberg eretto da Schinkel, che commemora, invece, il patriottismo prussiano e il sacrificio dei caduti nelle guerre napoleoniche.
Dello stile gotico si desumeva una lezione etica per la rispondenza tra scelte formali e funzioni pratiche nell'architettura: esso doveva essere adottato come scelta esemplare nella progettazione di nuovi edifici nel regno britannico e nelle operazioni di restauro. Il gotico, infatti, si impose sullo stile elisabettiano nella progettazione del Parlamento inglese. Era nella reinvenzione del passato che si configurava la fisionomia attuale degli edifici; in questo senso si possono interpretare le operazioni di restauro condotte attraverso lavoro di "restituzione" che: integrava lacune, demoliva aggiunti difformi e ricostruiva la presunta fisionomia originaria dei volumi e apparati decorativi. L'età medievale concedeva spazio a sondaggi avventurosi; delle ambiguità si alimentavano le edizioni dei "viaggi pittoreschi", che illustravano paesaggi segnati da vestigia medievali. Iniziative editoriali analoghe si diffusero presso il ceto borghese. Rispetto al periodo neoclassico si poteva registrare un cambiamento a livello iconografico nel lavoro degli artisti, con la sostituzione dei soggetti medievali al repertorio archeologico, ma anche un mutamento di sensibilità nel pubblico.
L'età medievale permetteva di esplorare un'articolazione più ampia della storia e dell'esistenza umana, scavata da ombre e tragedie: da qui la fortuna iconografica dell'Inferno dantesco, che offriva agli artisti occasioni per sottrarsi ai vincoli formali del classicismo. Ingres interpretò i soggetti danteschi senza allontanarsi dal controllo formale davidiano e continuò a difendere la pittura come attività intellettuale. Delacroix intrecciò la lettura di Dante a quella di Shakespeare e Byron, adottando torsioni michelangiolesche e seduzioni rubensiane. Mentre i "puristi" italiani non ammettevano modelli successivi a quelli giotteschi.
Scelte di stile
Educazione e talento
Document shared on https://www.docsity.com/it/l-arte-dell-ottocento-rovati/4675941/ Downloaded by: benedetta-baldi-3 (baldibenedetta40@gmail.com)