Il Servizio Sanitario Nazionale e la sua organizzazione nell'Azienda Sanitaria di Firenze
Documento sull'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Azienda Sanitaria di Firenze. Il Pdf analizza aspetti normativi, la struttura organizzativa e il rapporto con i cittadini, utile per lo studio universitario di Diritto.
Mostra di più42 pagine
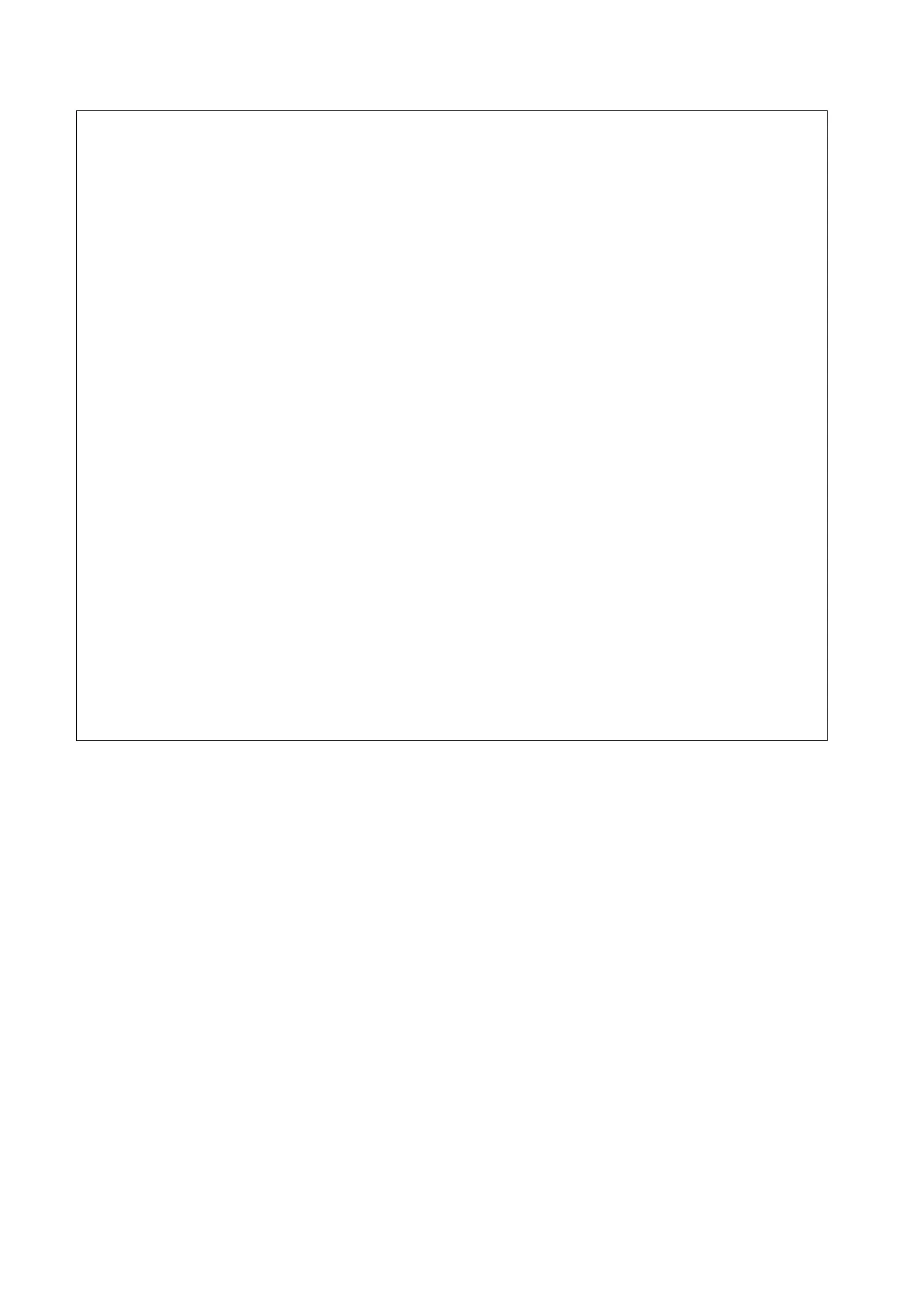

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
INDICE
CAPITOLO PRIMO
LA TUTELA DELLA SALUTE ED IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- La tutela della salute nella Costituzione
- Le funzioni "di regolazione" e "di prestazioni" della pubblica amministrazione
- L'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e la Legge 833/78
- La costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale e il D.Lgs. 502/92 e successive modifiche
- La programmazione e i Livelli Essenziali di Assistenza
- L'aziendalizzazione e l'autonomia imprenditoriale delle Unità Sanitarie Locali
- Riforma dell'organizzazione sanitaria territoriale ed evoluzione del sistema delle Aziende -Seconda fase dell'aziendalizzazione
Le Società della Salute
Enti Tecnico-Amministrativi di area Vasta / ESTAV
- La competitività tra pubblico e privato e la libertà di scelta da parte del cittadino
CAPITOLO SECONDO
L'ORGANIZZAZIONE E IL PROCESSO DECISIONALE NELLE AZIENDE SANITARIE
- Gli organi dell'Azienda Sanitaria
- La capacità di autorganizzare e l'atto aziendale
- La formazione delle decisioni: i soggetti della programmazione regionale toscana
- Le decisioni aziendali: gli atti del Direttore e gli atti della dirigenza
- La redazione degli atti e documenti aziendali
CAPITOLO TERZO
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
- L'atto aziendale dell'ASL di Firenze
- Il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Sanitaria di Firenze
- La capacità di agire ed il regolamento dell'attività contrattuale nell'Azienda Sanitaria di Firenze
- Il libro delle procedure
CAPITOLO QUARTO
IL MODO DI OPERARE DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI ED IL RAPPORTO DEL S.S.N. CON IL CITTADINO
- Principi costituzionali sull'amministrazione pubblica
- La legge n. 241/90 e il rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione; in particolare con il Servizio Sanitario
- L'atto aziendale dell'ASL di Firenze e il rapporto con il cittadino
24.4. Il Diritto di Accesso ed il Regolamento dell'Azienda U.S.L. 4.5. La semplificazione documentale e l'autocertificazione 4.6. Riservatezza e Codice in materia di protezione dei dati personali
CAPITOLO PRIMO
LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- La tutela della salute nella Costituzione
E' noto come la Costituzione Italiana sia la norma fondamentale del nostro ordinamento giuridico, che ha definito gli interessi pubblici preminenti per la Comunità nazionale,fra questi, l'esercizio del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato dalle seguenti norme di indirizzo. Innanzitutto, l'art. 32 che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Una rapida lettura della norma consente di fissare alcuni principi basilari:
- la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (e non solo del cittadino): non si tratta cioè di un semplice interesse protetto, ma della proclamazione di un diritto soggettivo primario e fondamentale; ciò non preclude che sia "compito del legislatore ordinario operare il bilanciamento degli interessi predetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento" (Corte Cost. ordinanza n. 40 del 17 - 31 gennaio 1991);
- la salute è interesse della collettività: viene posta in rilievo la valenza sociale del bene in considerazione, la cui soddisfazione risponde a un interesse collettivo;
le prestazioni per gli indigenti sono gratuite: ciò in forza anche dei principi, altrove affermati, di solidarietà e partecipazione che caratterizzano la nostra Costituzione;
- il trattamento sanitario può essere obbligatorio solo se espressamente previsto per legge: esso è pertanto libero, potendo essere erogato in presenza del consenso dell'interessato; tale libertà può essere limitata solo nell'interesse della collettività, esclusivamente da precise disposizioni di legge;
- il trattamento sanitario cui l'individuo è sottoposto, non può comunque prescindere dal rispetto della persona umana, essendo vietato qualsiasi prestazione che violi i suoi diritti fondamentali.
In secondo luogo, l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge di riforma costituzionale n. 3/2001, inserisce la tutela della salute in un regime di legislazione "concorrente" Stato/Regione. Ciò significa che alle Regioni spetta la potestà legislativa, nel rispetto dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato . Nel contesto della recente riforma federalista vengono ampliati i poteri delle Regioni in materie di tutela della salute, alle quali vengono affidati ulteriori funzioni di programmazione e di coordinamento. Ciò completa la regionalizzazione, tramite il trasferimento di funzioni, finora gestite dall'Amministrazione centrale, alle Regioni (o anche ai Comuni o alle Provincie), con l'obiettivo di semplificare la Pubblica Amministrazione, portandone l'esercizio più vicino possibile agli interessi dei cittadini (per effetto della legge 15/03/97 n. 59 conosciuta come "legge Bassanini").
- Le funzioni "di regolazione" e "di prestazioni" della pubblica amministrazione
Mentre con la funzione legislativa viene stabilito come determinati interessi debbano essere curati e con la funzione giurisdizionale ci si accerta che la volontà legislativa sia rispettata, con la funzione amministrativa si provvede in modo immediato alla cura degli interessi pubblici dei cittadini. Il termine "funzione" viene qui assunto in uno dei significati che sono propri nel campo del diritto, vale a dire di attività organizzata e preordinata al conseguimento di uno scopo, che nell'attività amministrativa consiste nella cura degli interessi dei cittadini. Titolare della funzione amministrativa è la Pubblica Amministrazione (PA), ovvero l'insieme di tutti gli organi del potere esecutivo e di quegli enti che svolgono un'attività diretta a curare gli interessi pubblici. La Pubblica Amministrazione esplica la propria attività di cura diretta degli interessi dei cittadini: a) sia mediante la più tradizionale funzione di regolazione delle attività dei singoli, diretta a imporre la propria autorità a tutela di interessi collettivi, anche attraverso la limitazione di libertà personali ed economiche di cittadini, che non 4possono più usarne a piacimento nell'interesse prioritario della comunità (per esempio, disciplina dell'utilizzo che i cittadini possono fare dei terreni di proprietà, disciplina del commercio, regolamentazione delle emissioni gassose o acustiche, ecc.); b) sia mediante la erogazione diretta ai cittadini di servizi pubblici e di prestazioni che i singoli non sono in grado di assicurare adeguatamente o con risorse individuali; questa tipologia di funzione pubblica acquista crescente rilevanza, già a partire del XX secolo (esempio, scuola, trasporti, posta, lavori pubblici, infrastrutture, ecc.). In campo sanitario, la funzione di regolazione si esplica soprattutto nel campo della prevenzione collettiva (igiene e sanità pubblica, igiene veterinaria, igiene del lavoro, ecc .. ), mentre la funzione di erogazione dei servizi sanitari, che indubbiamente assorbe le maggiori risorse e che è rivolta per lo più alla tutela della salute individuale, consiste nella gestione delle strutture ospedaliere e ambulatoriali, nell'acquisto di prestazioni di medicina di base, di specialistica, di ricovero, di prestazioni farmaceutiche e diagnostiche, nella gestione di servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, ecc.). L'azione della pubblica amministrazione, si esprime pertanto sia attraverso comportamenti concreti, che attraverso atti, che consistono, questi ultimi, nelle manifestazioni di volontà o dichiarazioni di verità, di conoscenza o di giudizio, posti in essere da un organo amministrativo nell'esercizio della propria competenza. Questi atti possono essere di diritto pubblico (tali sono, ad esempio, l'approvazione del bilancio preventivo che autorizza alla effettuazione di spese, le certificazioni, un ordine, un parere, ecc .. ) o di diritto privato (atto di organizzazione interna o di programmazione dell'attività, di volontà ad acquistare o a vendere, o a contrarre, ecc.). Nel primo caso la Pubblica Amministrazione si pone su un piano di supremazia rispetto al singolo cittadino cui l'atto è rivolto, sul quale esercita poteri autoritari per il prevalere del prioritario interesse pubblico sull'interesse del singolo (es. rispetto delle autorizzazione di spesa impartite con il bilancio, rispetto delle graduatorie concorsuali per le assunzioni, ordine sanitario di vaccinazione collettiva, ecc.); nel secondo caso, la pubblica amministrazione esprime una volontà di azione, cui il privato può o meno aderire, a seconda del proprio interesse e nel solo rispetto delle reciproche condizioni contrattuali che l'Amministrazione ha deciso di proporre.
- L'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e la Legge 833/78
La legge n. 833 del 13/12/1978, ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), aprendo un nuovo capitolo della sanità italiana. Tale legge, infatti, può essere considerata a pieno titolo l'espressione di un nuovo orientamento ed attenzione alla tutela della salute, in coerenza ed attuazione dell'art. 32 della Costituzione. Principi ispiratori del SSN:
- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività avvalendosi del S.S.N .: è la Repubblica dunque il titolare del diritto-dovere di tutelare la salute ed e il S.S.N. lo strumento operativo di attuazione della norma costituzionale;
- La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana; Il servizio è esercitato secondo un Piano Sanitario Nazionale, che con riferimento ad un determinato periodo, definisce il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Caratteri fondamentali del servizio, ispirato ai principi di cui sopra:
- Gli interventi a tutela della salute riguardano tanto la cura, quanto la prevenzione che la riabilitazione;
- I cittadini sono eguali nei confronti del servizio;
- Le prestazioni sono gratuite.
Lo strumento operativo per l'esercizio del servizio, che la riforma sanitaria del 1978 (citata legge n. 833) individuò, furono le Unità Sanitarie Locali, che nella riforma rappresentavano strutture operative dei Comuni, singoli o associati e delle Comunità Montane, costituite dall'insieme dei presidi, degli uffici e dei servizi che, in un ambito territoriale de- terminato, erano chiamate a fare fronte alle esigenze sociosanitarie dei cittadini. La legge, allora, non definì la natura giuridica dell'USL, che non dette origine ad un nuovo ente pubblico, ma semplicemente ad una struttura operativa dei Comuni, senza soggettività propria. La metodologia che fu prescelta per la definizione e la cura degli interessi affidati al complessivo sistema sanitario è quella della programmazione. Pertanto, attraverso il Piano Sanitario Nazionale sono stabilite le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del SSN. Spetta al Piano Sanitario Nazionale 5