Lezione 1: Dialettica culturale franco-italiana, stereotipi e influenze reciproche
Documento universitario sulla lezione 1 che esplora la complessa relazione culturale tra Francia e Italia. Il Pdf, per il corso di Letteratura, approfondisce la dialettica culturale franco-italiana, analizzando stereotipi, influenze reciproche e percezioni storiche tra i due paesi.
Mostra di più56 pagine
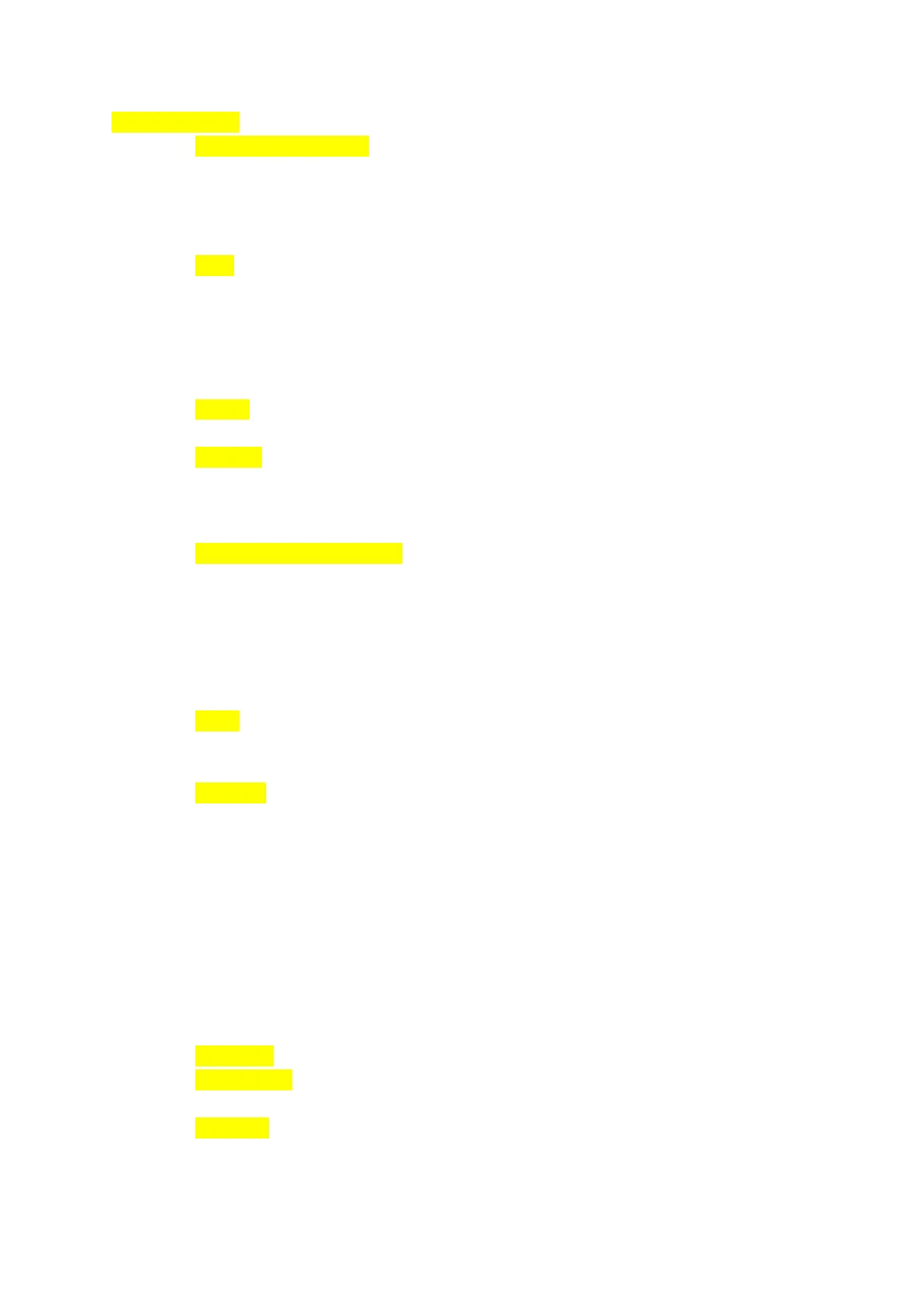
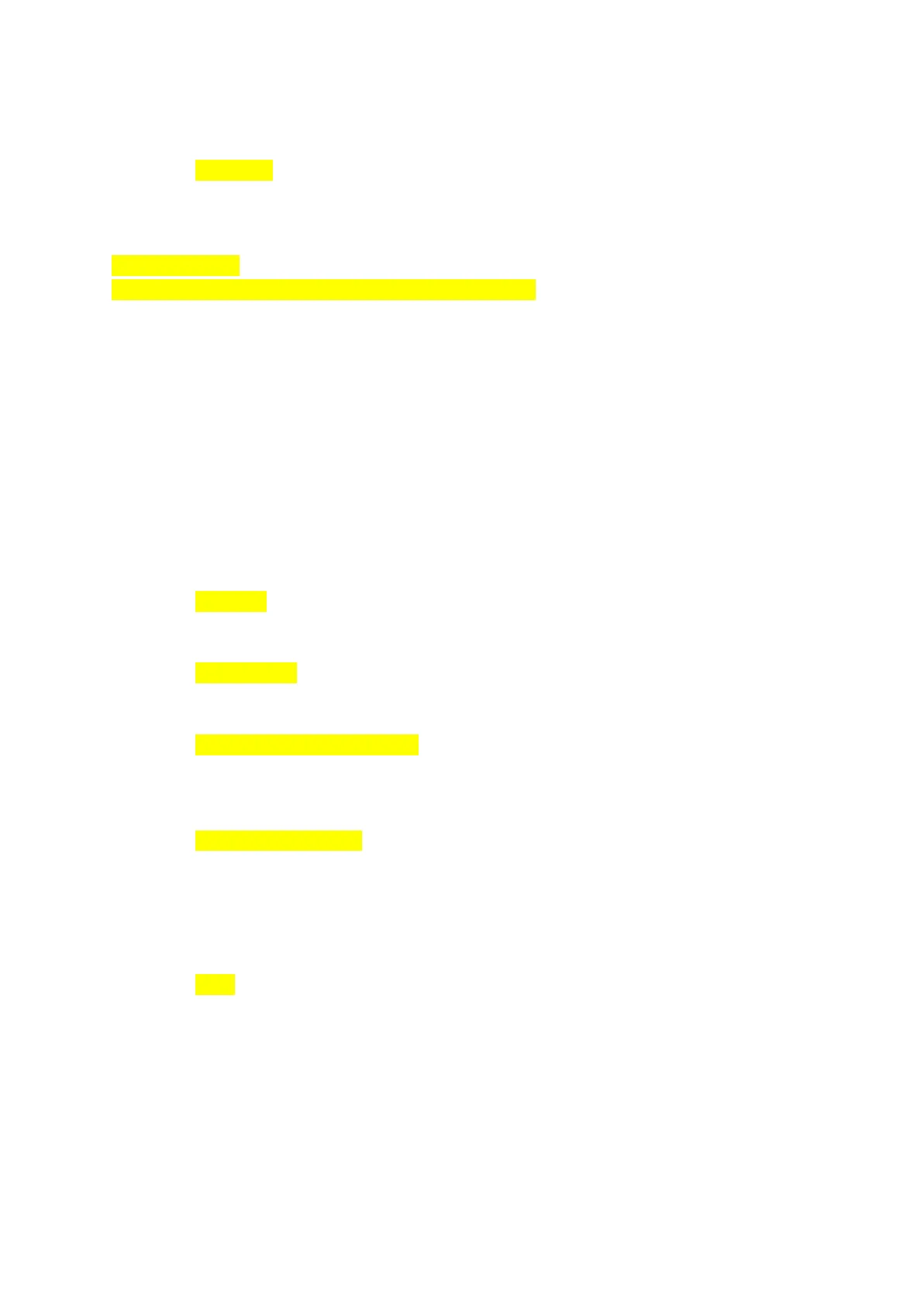
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Lezione 1 (20/02)
- Dialettica franco-italiana: ci sono molti stereotipi che comprendono questa dialettica. Questa relazione di rivalità tra i due paesi ha portato alla nascita di alcuni stereotipi presenti ancora oggi. Il sistema ci interessa quando entità come possono essere ad esempio due autori si mettono a confronto. Gli stereotipi sono un nucleo di pensiero di cui partire per mobilitare le idee. Le stereotipo ha una parte autentica e una parte rigida.
- Italia: luoghi comuni, insofferenza verso il francese, fondamentali incomprensioni culturali che porteranno fascinazione da fascinazione da entrambe le parti. L'Italia è sempre stata prima dell'Unità d'Italia nel 1861 ma anche dopo un paese frammentario. A differenza della Francia che ha schiacciato autori di altre culture, l'Italia ha una dialettica culturale aperta. Questa centralità ha fatto sì che la Francia portasse la propria identità (Tour Eiffel)
- Francia: potere politico, culturale che si fissa dal 1897 nell'Ile de France. Si crea una specie di piramide con distinzione tra Parigi e quello che sta al suo esterno. Colosseo: prima cosa da vedere in Italia per Stendhal. È il contrario della Tour Eiffel, spazio profondo, spettacolo di scontro tra uomo-animale davanti ad un pubblico. > Visione arcaica dell'Italia da una parte ma anche bellezza antica dall'altra. Romanzo-rinascimento: Italia per Francia.
- Il francese è una lingua ibrida: unione tra la lingua latina e le lingue germaniche, mentre l'Italiano è il vero erede del latino.
- Dal 1500 in poi la Francia si costruisce per ciò che non vuole essere l'Italia. I francesi erano rimasti affascinati da Firenze da cui partirà una rivalità per produrre un movimento culturale. La Francia ha dovuto negare questa portata della bellezza culturale dell'Italia per costruire una sua identità. Il francese era la lingua dello scambio in Europa. La Francia si costruisce sulla massa critica, è un paese di giudizio.
- Freud: mette in risalto che esistono le culture opprimenti e altri più reticolari. Complesso culturale-nazione giudicante. "Desiderio di redirige": società che sentono il desiderio di libertà e vedono questo proprio nell'Italia.
- Rousseau: Parigi era un ambiente troppo giudicante dal punto di vista culturale. L'Italia per lui era un modello. Scappa dalla cultura illuminista per andare in campagna (romanticismo). Guarda la cultura parigina dall'esterno cogliendo tutti i tratti di eccesso che crea un mondo di maschere, cultura opprimente. Apre al romanticismo con il valore della natura. Nascita del mito del buon selvaggio. È meglio la natura della cultura l'uomo della città è corrotto. La Francia aveva raggiunto quel livello di ipocrisia, mentre l'Italia rappresenta quel grado 0 della cultura da cui ripartire. > Italia archetipo della bellezza che non evolve, strutturata come delle Polis. Cultura protestante: etica del lavoro. Estetica- valore etico. Stendhal queste cose le ha già focalizzate. Erede di Rousseau. Supera su alcuni punti il suo pensiero. Amore verso l'Italia basato sui suoi soggiorni.
- Baudelaire: l'angoscia è la pietrificazione dello spazio, il vero esilio è dentro Parigi.
- Mito di Parigi: costruito nel 1800 con la nascita del turismo di massa grazie all'avvento del treno
- Paesaggio: uno spazio non esiste finché non lo percepiamo come unità. Diderot "La passeggiata di Vernai" immagina un personaggio che entra dentro un quadro e cicammina dentro. Si inizia nell'estetica del 1700 il paesaggio. Idea che la natura è arte. Il romanticismo: natura come arte, sposta l'attenzione dalla città alla natura.
- Spettacolo: la parola cambia di segno con Rousseau. Prima aveva un valore umano e teatrale come manifestazione di entrambi. Per lui in modo metaforico lo spettacolo è la natura.
Lezione 2 (22/02)
La letteratura ci permette di fare un viaggio nella conoscenza. La letteratura e il viaggio richiamano a questa esperienza che ci estranea da noi (esperienza della distanza), cosa che poi ci rimanda cambiati. L'esperienza dell'altro non si fa solo geograficamente ma anche storicamente. Il fondo storico ci permette di capire la distanza da un'altra fase culturale. Molti dei concetti oggi utilizzati vengono acquisiti dal 1800. La letteratura ci insegna che un determinato episodio non esiste da sempre, ma deve essere collegato in un un momento preciso. Questo estraniamento deve essere su due piani: geograficamente e storicamente. La cultura occidentale basata sullo studio di autori vicino a noi ad esempio (probazione: io sono io e tutto deve convergere a quello che sono io). Dovremmo studiare autori lontano da noi per capire meglio altri aspetti e non solo quelli vicino a noi. Questa esperienza storica all'indietro fa parte di questa esperienza per questo è anche importante conoscere le lingue classiche. Bisogna comprendere come le lingue attraverso il loro sistema rappresentano il mondo. La visione tecnologica tende a focalizzarsi sul produttivismo, operatività, sul presente e non a quello che invece è il passato. L'Umanesimo è una grande peculiarità.
- Topologia: scienza che studia i luoghi. Topos: spazio. Si parla spesso di topos letterario. Ci rimanda al luogo comune. Ad esempio noi stiamo studiando la tipologia franco italiana.
- Epistemologia: dottrina del conoscere. Foucault, uno dei più grandi filosofi francesi che ha cambiato il pensiero moderno, ne parla in modo stretto dove essa è quel sapere che noi dobbiamo avere un sapere comune che ci permette di parlarci. Viene relativizzata.
- Straniamento e domesticazione: il primo noi abbandoniamo la nostra dimensione per andare verso un'altra esperienza, quello che chiamiamo l'altro. Lo straniero è qualcuno fuori dalla nostra realtà. La domesticazione è l'esatto contrario. Prendo l'altro per portarlo nella nostra domesticazione (portare da noi).
- Etnologia dello sguardo: disciplina che studia i diversi popoli, etnie, tradizioni. Alla fine del 1800/1900 si preoccupò di studiare i diversi popoli dal punto di vista etnologico. Prima guardava presso altri popoli non mettendo in discussione l'occidente, senza decostruire la nostra immagine, Si andava a spiare cosa succedeva nelle altre culture. Lo sguardo è la capacità che noi abbiamo la capacità di vedere noi stessi con l'occhio della distanza. Operare questo estraniamento nella domesticità.
- Tribù: le culture primitive erano chiuse, si strutturano in piccole società che avevano un linguaggio interno. Si voleva mantenere una propria identità sposandosi anche tra di loro (endogamia). Tribù e fratria sono due termini che ci collegano a queste piccole comunità. Il viaggio ha cambiato mille dimensioni nella storia della cultura. Questa tendenza alla fratria come dice Freud le troviamo nei gruppi chiusi come possono essere le sette che non vogliono entrare in contatto con fenomeni esterni. Freud nota che questa cosa di sentirci noi puri e l'altro impuro è una paura che c'è sempre stata nell'uomo. Il nevrotico ha paura in modo paranoico dell'altro perché ha paura di essere contaminato. Il fenomeno ricorrente del nevrotico è quello di lavarsi continuamente.
- Contaminazione: in questo è stato importante il commercio che ha permesso di andare fuori dalla propria terra. Il mercato ha portato l'esogamia, dunque una contaminazione tra due culture. Dalla famiglia (fondamento biologico) si passa alla società (fondamento simbolico) che si costruisce attraverso la contaminazione e gli scambi.
- Nazione/Patria: due concetti molto discussi. Nazione proviene dal latino e vuol dire dove sono nato, attaccamento della terra di origine dell'uomo. In qualche modo a che fare con il sangue, dunque fondamento biologico. La patria sempre dal latino è il padre e si basa su una matrice simbolica. La patria è legata a questo concetto di legge (padre). Patria è un femminile astratto. Ecco perché questi concetti sono stati messi in discussione, perché portano ad un'ambiguità.
- Esistenza, esilio, eccentricità, eteronomia: L'esistenzialismo nasce con Sartre, in realtà c'era già prima. Parte dal concetto di esistenza, certezza di essere (io sono). L'esistenza è un problema dell'essere etimologicamente vuol dire "stare fuori." Per Sartre l'essenza non è un valore, l'esistenza sì. Per costruire un proprio concetto è andare in un'altra dimensione (esistere= estraniarsi). Eccentricità: lo usiamo in modo banale per dire che una persona è vestita in modo stravagante. In realtà ha sempre il prefisso ex quindi vuol dire andare nella propria periferia umana. Eteronomia usata da Kant: stare fuori dalla legge di dio, stare fuori da una struttura di legge. Mi dissocio da quella legge. Autonomia: la legge la faccio da sola.
- Xenofobia e Xenofilia: paura dello straniero e amore per lo straniero. Mimetismo: mimesi viene da Aristotele, nella politica dice che l'uomo è mimico e si forma attraverso i suoi simili. Assumere certi comportamenti dell'altro e farlo proprio. Identificarci con figure che apprezziamo, con miti.
Panoramica storica del viaggio
- Archetipo: struttura stabile che abbiamo nella nostra mente. Primo principio di un'immagine. Il viaggio è un archetipo che noi possediamo. L'istinto della domesticità. Entrambi determinano il nostro modo di essere, si controbattono. È dato per universale. L'allontanamento dell'eroe da casa. Jung forma questa dottrina degli archetipi. Nei nostri immaginari ci sono delle figure persistenti che ritornano in tutte le figure conosciute. Vladimir Propp su questa base scrive un libro su 33 funzioni, processi che troviamo su tutte le letterature mondiali. Come proprio l'allontanamento dell'eroe da casa. Il viaggio è primariamente sofferenza e sacrificio: abbandono una posizione certa per andare a cercare qualcosa che non c'è. L'abbandono da casa è l'avvio della letteratura. Viaggio: conoscere. Il viaggio porta con sé un destino/fatto. Lo ritroviamo nella tradizione greca: Iliade, Odissea ed Eneide. La partenza porta ad una nuova fondazione. Canto di Ulisse nella Divina Commedia: viaggia per conoscere mille peripezie. Nomadismo profetico: eroe culturale/eroe fondatore (Perceval) si muove per volontà di altri. Dio Hermes: personaggio interessante, curioso. Lui altera l'equilibrio, il suo scopo è quello di portarci da altre parti. Confonde tutti i pensieri. Si trovava dove le strade si incrociano. Dio del labirinto, della confusione. È il discorrere da tutte le parti, dicevano i greci.
- La città nasce da un mito di fondazione (Romolo e Remo con Roma).
- Letteratura odeporica: letteratura di viaggio