Sensibilità: classificazione, propriocettori e fasci sensitivi della sostanza bianca
Documento di Università sulla sensibilità. Il Pdf esplora la classificazione della sensibilità, distinguendo tra generale e speciale, e analizzando i propriocettori come i fusi neuromuscolari e l'organo muscolo-tendineo del Golgi, con un focus sui fasci sensitivi della sostanza bianca, utile per lo studio della Biologia.
Mostra di più9 pagine
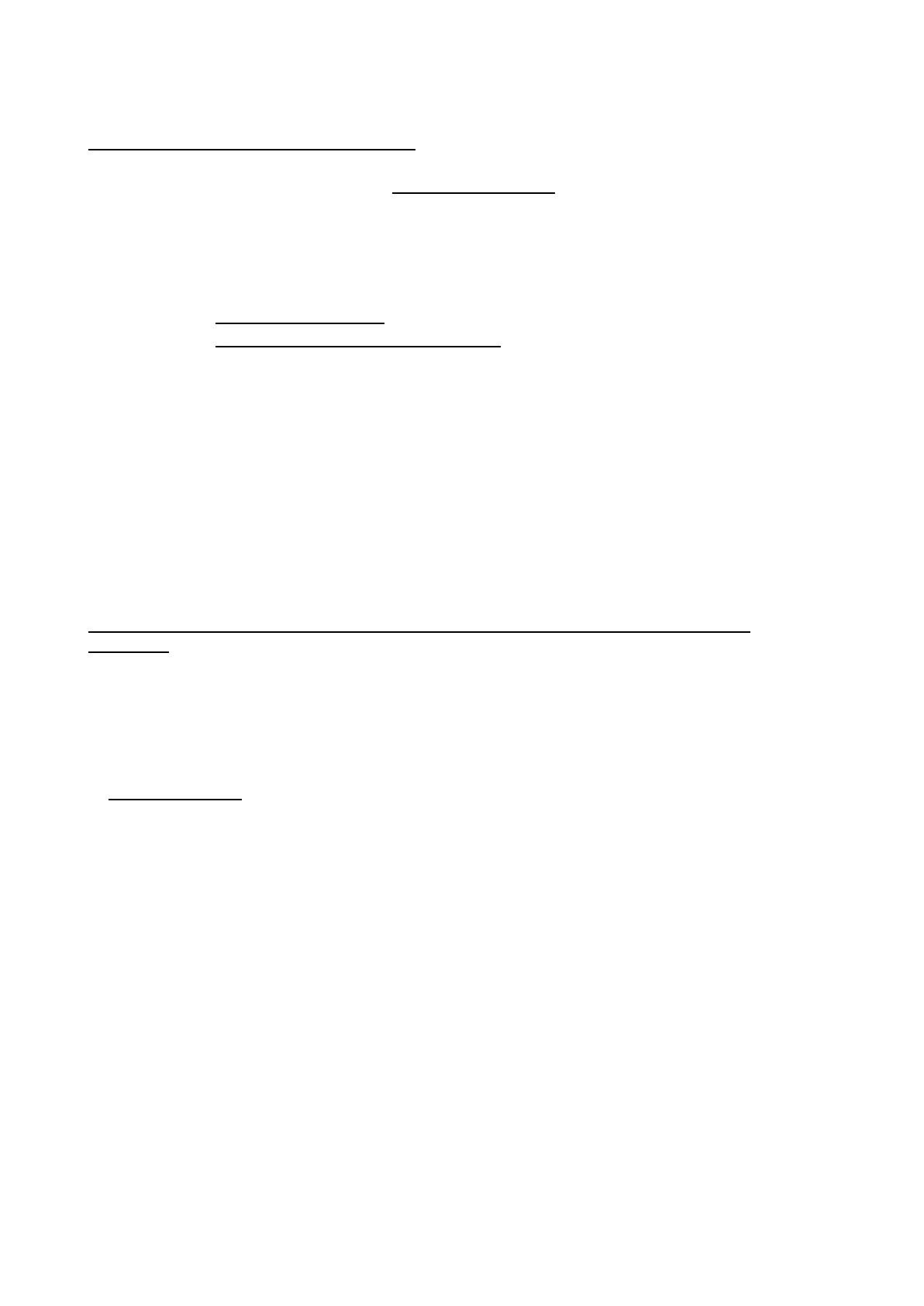
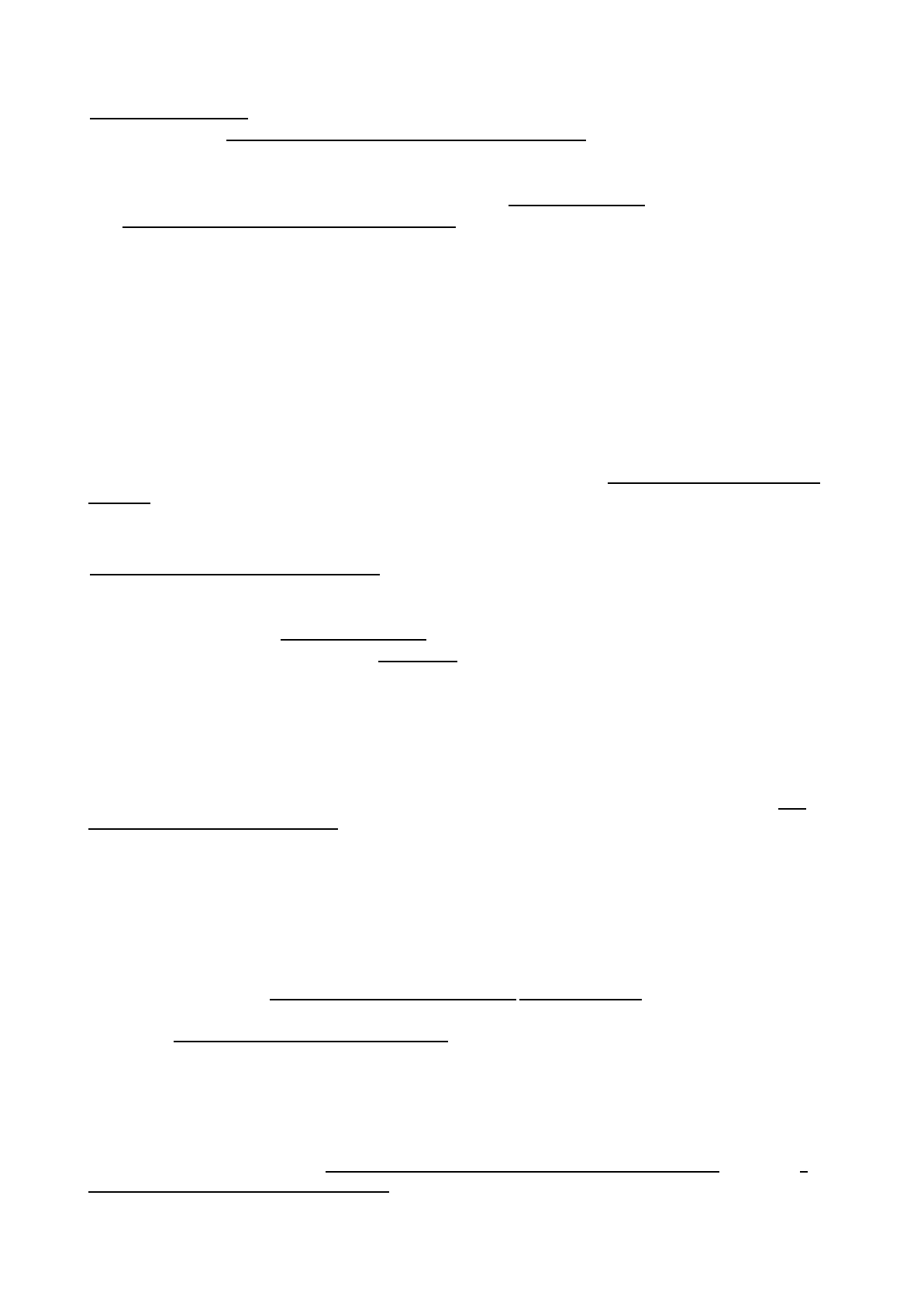
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
SENSIBILITÀ
CLASSIFICAZIONE DELLA SENSIBILITÀ
La sensibilità innanzitutto si può dividere in due grossi macrosettori:
- sensibilità speciale -> legata alla presenza di organi di senso molto particolari;
- sensibilità generale.
La sensibilità generale non è legata ad organi di senso particolari e viene suddivisa in base al comparto di raccolta:
- la sensibilità proveniente dall'esterno (esterocettiva);
- la sensibilità proveniente dall'interno del nostro corpo (interocettiva).
Quest'ultima può provenire da due comparti molto diversi:
- dai visceri (sensibilità viscerale o viscerocettiva);
- dall'apparato locomotore (sensibilità propriocettiva o chinestesica, chiamata così durante la dinamica).
La sensibilità esterocettiva può essere raccolta con due vie molto diverse:
- epicritica: sensibilità raffinata soprattutto di tipo tattile, pressorio, termico - ad es: immergendo la mano in tante bacinelle di acqua calda tra i 20 e i 40 ℃ riesco a ordinarle in ordine crescente o decrescente di temperatura grazie alla sensibilità epicritica.
- protopatica: sensibilità grossolana, anch'essa di tipo tattile, pressoria, dolorifica e termica - permette di stabilire se l'acqua è fredda o calda.
Se le vie di entrambe le sensibilità sono integre, noi non ci rendiamo conto di avere la sensibilità protopatica.
Sono state scoperte le vie della sensibilità grossolana quando, studiando un individuo che presentava lesioni delle vie della sensibilità epicritica, si è visto che sentiva in maniera grossolana il caldo e il freddo, oppure sentiva una pressione forte o una pressione nulla. In seguito a questo si è capito che ci sono anche delle vie della sensibilità protopatica, ma non ce ne rendiamo conto finché quelle della sensibilità epicritica funzionano.
La sensibilità speciale è la sensibilità ottica, acustica, vestibolare, olfattiva e gustativa. È stata paragonata alle tipologie di sensibilità già dette: la sensibilità ottica e acustica sono state paragonate alla sensibilità esterocettiva somatica, quella vestibolare - relativa alla posizione e al movimento - è stata paragonata alla sensibilità propriocettiva, infine quella olfattiva e gustativa sono state paragonate alla sensibilità viscerale speciale.
La sensibilità viene percepita da dei recettori e raccolta da dei neuroni sensitivi; ci sono diversi tipi di recettori (la prof non si concentra su di essi poiché già sono stati fatti in parte in istologia e verranno rifatti in fisiologia):
- recettori neuroepiteliali - in grado sia di percepire e trasmettere uno stimolo (cellule olfattive);
- cellule sensoriali primarie - ad esempio, le cellule olfattive che stanno nella volta del naso;
- recettori epiteliali - cellule di un epitelio sensitivo (NON nervoso) che percepiscono uno stimolo che viene poi necessariamente raccolto dal neurone sensitivo pseudounipolare o bipolare (cellule gustative);
- recettori neuronali -> terminazioni di un neurone sensitivo, che vengono incapsulate da strutture particolari (corpuscoli di Meissner).
PROPRIOCETTORI
Sono i recettori che consentono di percepire la sensibilità propriocettiva, cioè dell'apparato locomotore. Possono essere:
- generici - sentono pressione o tensione nelle capsule articolari o nei legamenti;
- specializzati - recettori presenti nella parte contrattile del muscolo (fusi neuromuscolari) o nel tendine (organo muscolo-tendineo specializzato del Golgi).
Questi non sono propriocettori generici, ma sono peculiari.
Facciamo un paragone rispetto alla motricità: la contrazione muscolare può essere più o meno sofisticata a seconda del numero di unità motorie del muscolo; più unità motorie ha un muscolo, più precisa e sofisticata è la sua regolazione. Per la sensibilità il discorso è simile: ci sono zone più sensibili e zone meno sensibili, cambia non solo la densità dei recettori ma anche il numero delle unità sensitive stesse, ovvero il neurone che fa capo ad un certo numero di recettori in un territorio -> più unità sensitive sono presenti in una sede, più la sede è sensibile.
Quando poi entrano nel midollo e seguono i neuroni dell'apparato d'integrazione che va in alto vengono portate nella circonvoluzione somestesica (la strisciolina azzurra in alto) dove viene proiettato tutto il territorio periferico.
Se si fa una sezione frontale della circonvoluzione, si nota che quella è la prima circonvoluzione del lobo parietale. Nei lobi si trova infatti un solco chiamato solco di Rolando che separa il lobo frontale dal lobo parietale - dietro al solco di Rolando si trova la circonvoluzione somestesica, la strisciolina azzurra citata.
PROPRIOCETTORI SPECIALIZZATI
Come già accennato in precedenza ci sono due propriocettori specializzati:
- fuso neuromuscolare nel ventre contrattile;
- organo muscolo-tendineo del Golgi nel tendine.
Questi propriocettori hanno finalità e modi di funzionare molto diversi, oltre a generare riflessi diversi.
FUSI NEUROMUSCOLARI
I fusi neuromuscolari sono formazioni fusate tra due fibre muscolari del ventre e sono delimitati da due capsule - una interna e una esterna - con un piccolo spazio endocapsulare. All'interno dei fusi si trovano delle piccole fibre muscolari, chiamate fibre intrafusali, che si differenziano dalle fibre extrafusali presenti invece nei muscoli.
Le fibre intrafusali non sono tutte uguali:
- possono avere un gruppo di nuclei a livello equatoriale, non debordando mai -> fibre a sacca di nuclei;
- possono avere i nuclei disposti l'uno sull'altro, possono anche debordare oltre l'apice del fuso - fibre a catena di nuclei.
Inoltre, le fibre intrafusali non hanno dappertutto i sarcomeri disposti a registro: in realtà nella parte equatoriale i sarcomeri sono tutti disgregati -> di conseguenza la parte equatoriale NON può essere contrattile.
Al contrario gli apici delle fibre si possono contrarre e di conseguenza la parte equatoriale si stira. Queste fibre intrafusali sono raggiunte solo a livello equatoriale da terminazioni sensitive:
- alcune si avvolgono a spirale sulla parte equatoriale - angospirali;
- altre si ramificano come le foglie di un ramo -> a fiorami.
Quindi se la fibra intrafusale viene allungata, a livello equatoriale viene percepito questa variazione di stiramento. Bisogna ricordare che lo stimolo attivante dei fusi è la variazione di stiramento. In generale il fuso stesso è sempre modicamente stirato, ma quando avviene una piccola variazione di stiramento questa viene captata dalle fibre equatoriali e lo stimolo viene portato al centro.Inoltre la soglia di attivazione dei fusi è bassissima: persino una variazione infinitesimale può attivarli. Così come a livello equatoriale le fibre intrafusali sono raggiunte da fibre sensitive che percepiscono anche modiche variazioni di movimento; invece, gli apici delle fibre sono raggiunti da motoneuroni y, grazie a questi il midollo spinale può esercitare un comando sui fusi neuromuscolari facendoli stirare.
DOMANDA: "Come si saggia la funzionalità del fuso?" RISPOSTA: " Coi riflessi"
RIFLESSO ROTULEO
In particolare con l'unico riflesso monosinaptico che abbiamo, ossia il riflesso rotuleo. Il medico percuote leggermente con un martelletto il tendine del quadricipite femorale che si inserisce sulla tibia - in questo modo si ha un riflesso, ossia la contrazione del quadricipite femorale; se c'è un iporiflessia o un'ariflessia vuol dire che c'è un problema.
Quello che succede è che col martelletto si comprime il tendine provocando un minuscolo stiramento, ma essendo i fusi molto sensibili e avendo una soglia di attivazione bassissima: la fibra sensitiva va nel midollo spinale e viene a contattato con il motoneurone alfa , che a sua volta contatta il quadricipite provocandone la contrazione.
ATTIVAZIONE DEI FUSI NEUROMUSCOLARI
I fusi si possono attivare in due modi: in maniera attiva o in maniera passiva.
- Un'attivazione passiva può avvenire ad esempio in caso di eccessiva contrazione del bicipite brachiale con conseguente stiramento del tricipite: infatti, se il fuso che sta in un muscolo estensore viene attivato, perché l'estensore è stirato da un muscolo antagonista, il fuso di stira e arriva all'interno del fuso un segnale sensitivo, il neurone pseudounipolare contatta il motoneurone a, che va a far contrarre il muscolo contenente il fuso stimolato. Ma contemporaneamente può essere contattato per divergenza anche un interneurone inibitore che inibisce il muscolo antagonista che ha generato lo stiramento. È importante che, quando viene effettuato un movimento, gli agonisti siano uniti. Altrimenti si verificano delle patologie come il Parkinson caratterizzate da una contrazione simultanea di muscoli antagonisti. In un'attivazione passiva il fuso può essere stirato perché il muscolo in cui si trova viene stirato dalla contrazione di un muscolo agonista e questa attivazione porta alla contrazione del muscolo in cui il fuso si trova. Questo meccanismo aiuta anche negli automatismi: se si deve camminare non si pensa ai movimenti necessari per farlo perché vengono automaticamente, ma per camminare si alternano i muscoli: nella gamba, contrazione dei flessori e stiramento degli estensori, si attivano i fusi, e inibizione dei flessori e contrazione degli estensori. I fusi neuromuscolare rendono più corretta l'alternanza tra agonisti ed antagonisti.
- Tuttavia, ci può essere uno stiramento attivo del fuso - ossia non dovuto alla contrazione di un muscolo antagonista, ma questo avviene quando il muscolo è ipotonico. Dicevamo infatti che i fusi sono sempre modicamente stirati perché i muscoli sono tutti più o meno tonici, ma se c'è un'atonia, quindi il fuso non è modicamente stirato ma è afflosciato, dal midollo parte un segnale diretto ai motoneuroni y, che vanno a stimolare gli apici delle fibre intrafusali, queste si contraggono quindi fanno stirare la parte equatoriale, quindi la fibra sensitiva andrà nel midollo e attiverà il motoneurone a che fa attivare il muscolo -> si ripristina il tono muscolare.
Ricapitolando: ci sono due modi per attivare i fusi, una passiva se avviene in un muscolo attivato da qualcos'altro, una attiva in cui il nevrasse attiva il motoneurone y e quindi la contrazione delle fibre, per far sì che lo stiramento della parte equatoriale faccia contrarre qualche unità motoria del muscolo - ripristina il tono muscolare.