Semisimboli tra segni e simboli: analisi e correlazioni in Greimas
Documento universitario sui semisimboli tra segni e simboli. Il Pdf esplora il concetto di semisimbolismo, distinguendolo da simboli e segni, e analizza le correlazioni semisimboliche in Greimas, la verità nella comunicazione e il quadrato semiotico della veridizione.
Mostra di più13 pagine
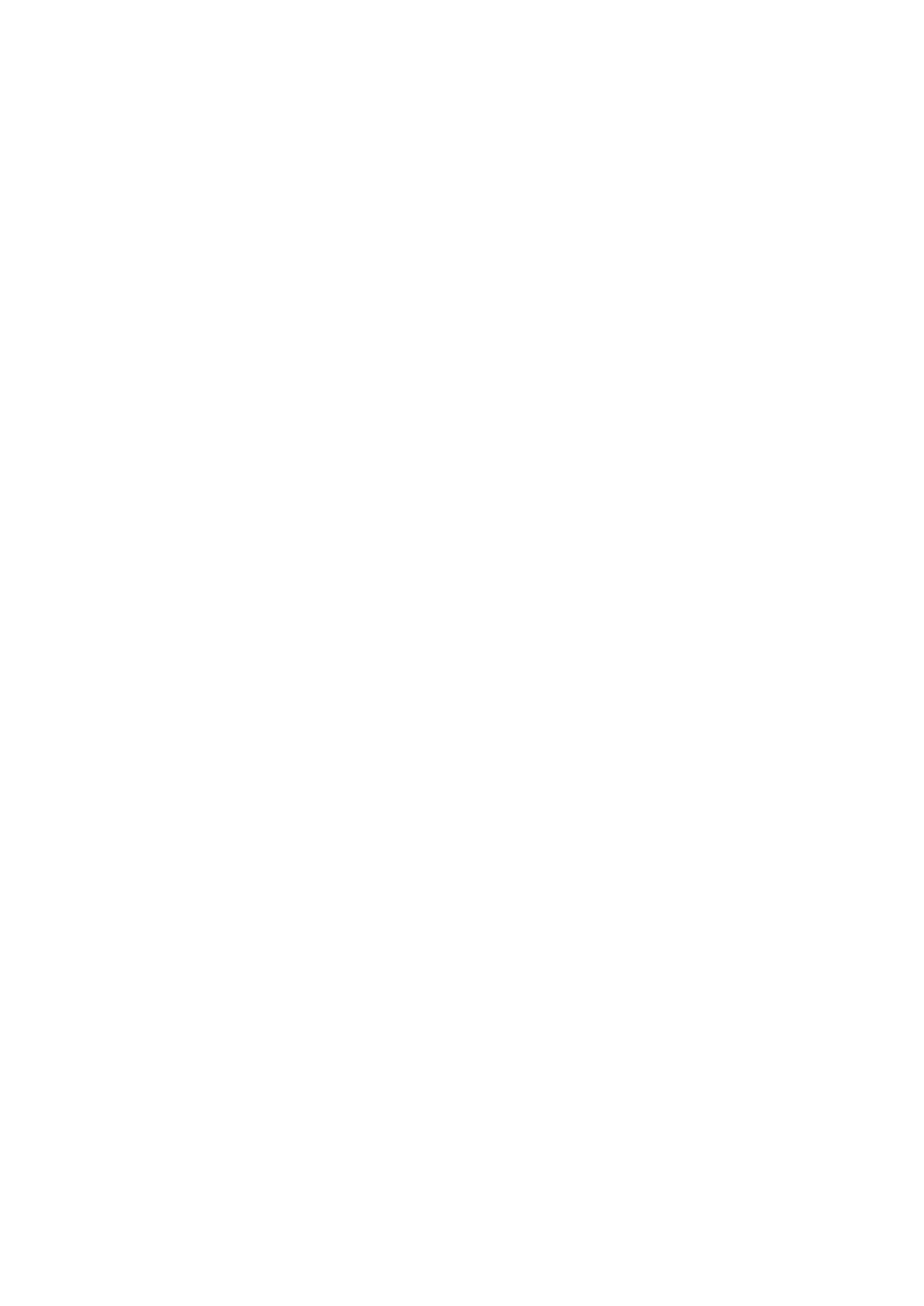

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Semisimboli tra segni e simboli
- Semisimboli tra segni e simboli
Il termine "semisimbolico" è stato coniato dal linguista danese Louis Hjelmslev (1943), che ha studiato il funzionamento dei sistemi di segni e notato alcune differenze cruciali. Esistono sistemi in cui c'è conformità fra piano dell'espressione e piano del contenuto e non commutabilità fra gli elementi. Hjelmslev li chiama sistemi simbolici o monoplanari: in essi espressione e contenuto hanno un rapporto motivato e "naturale" tanto da fondersi in un unico piano. La bilancia (analogica, non digitale!) è simbolo di giustizia per via della somiglianza fra il peso sui due piatti e il concetto di giudicare con equilibrio. I sistemi simbolici o monoplanari vanno distinti dai sistemi segnici o biplanari: in essi espressione e contenuto sono correlati secondo rapporti arbitrari e formano due piani autonomi e separati, non conformi l'uno con l'altro. Tutti i linguaggi verbali sono sistemi di segni. Le lingue ritagliano la materia del mondo, massa informe, ciascuna a proprio modo, cosicché una stessa sostanza del contenuto dello spettro solare corrispondente all'area di un colore avrà arbitrariamente la forma del contenuto /verdità/ e la forma dell'espressione v e r d e in italiano, la forma del contenuto /greenity/ e la forma dell'espressione g r e e n in inglese, la forma del contenuto /vert/ e la forma dell'espressione v e r t in francese. Non c'è alcun motivo per cui le lingue selezionino, distinguano la percezione dello spettro solare così né perchè chiamino con questi termini i colori. Le decisioni sono appunto arbitrarie, immotivate. Hjelmslev ha poi individuato un terzo regime di funzionamento semantico tra segni e simboli, che ha definito semisimbolico: in esso espressione e contenuto contraggono un rapporto parzialmente motivato in virtù della correlazione o meglio dell'omologazione non fra singoli elementi dei due piani, come nel caso del simbolo - bilancia : giustizia - ma fra coppie di contrasti dei due piani.
Un simbolo come la falce e il martello rappresenta il comunismo per il fatto, motivato, che il comunismo è quella ideologia politica che lotta per l'unione degli operai - martello - e dei contadini - falce. L'accoppiamento di queste due figure metonimiche - la parte per il tutto, gli strumenti che stanno per chi li adopera - simbolizza l'ideologia comunista, il suo nucleo semantico. Il simbolo è dunque un tipo di relazione di significazione dove l'espressione è motivata dal contenuto.Un segno linguistico, al contrario, è del tutto immotivato: esso è un'entità a due facce, ognuna delle quali è scomponibile in entità di minore portata (morfemi, fonemi, tratti per il significante) che non hanno tra loro alcuna relazione: non c'è alcuna relazione tra i fonemi v e r d e della parola "verde" e il fatto che significhi un colore dello spettro solare. L'esperienza però ci insegna che ci sono casi in cui le cose non vanno né in un modo né nell'altro. Nel sistema gestuale, per indicare l'affermazione e la negazione (Jakobson 1970), noi usiamo per esempio l'opposizione tra un movimento verticale - è il sì - e uno orizzontale - è il no. Ma, in senso stretto, il verticale non significa, non simboleggia l'affermazione a meno che il movimento orizzontale non significhi la negazione. È come se ci fosse una specie di proporzione tale per cui il verticale sta all'orizzontale come il sì al no; o - che è lo stesso - il verticale sta al sì come l'orizzontale al no. Non ci troviamo dunque in presenza di simboli (motivati in sé) né di segni linguistici (immotivati nelle due loro facce) ma di semi-simboli, che sono motivati nella loro relazione reciproca. Relazione che, si badi, non è per nulla naturale: in Sicilia, per esempio, il si-stema è diverso: la negazione viene segnalata da un movimento della testa verso l'alto, mentre l'affermazione da un movimento della testa verso il basso; c'è insomma un'altra proporzione (verso l'alto : verso il basso :: negazione : affermazione).
Diciamo dunque che le semiotiche semisimboliche praticano una rimotivazione dei segni, un ritaglio ulteriore della sostanza dell'espressione, che comporta un incremento di senso sul piano del contenuto. La poesia, tutte le arti in genere, lo fanno costantemente.
Correlazioni semisimboliche in Greimas
- Correlazioni semisimboliche in Greimas
Così Greimas, nel saggio Semiotica figurativa e semiotica plastica (1984), rifiuta l'idea che i testi astratti non abbiano significato. Vi riscontra anzi, a partire da Hjelmslev (1943), tutte le caratteristiche del dispositivo semisimbolico. Al punto che si può dire che l'analisi delle categorie topologiche, eidetiche e cromatiche qui sia preparatoria, funzionale, ad andare in cerca di questa semantica sui generis.
Individuata la cornice, reale o ideale, del testo (estrapolate le categorie metriche, aggiunte da noi), disegnata la griglia e trovate le categorie topologiche che ci aiutano a scoprire come è stato articolato e marcato il suo spazio, quindi osservate le categorie eidetiche, cromatiche (e testurali, aggiunte dal Gruppo mu) che lo costituiscono, si cercano coppie di contrasti topologici,(metrici), eidetici, cromatici (e testurali), cioè contrasti del piano dell'espressione, correlabili con coppie di contrasti del piano del contenuto:
Un contrasto cromatico alto/basso può veicolare, per esempio, un contrasto di contenuto superiore/inferiore o divino/terreno. A un'opposizione sul piano espressivo se ne omologa una sul piano del contenuto. I simboli hanno stabilità di significato perché, col tempo, la convenzione sociale ha portato ad associare 1:1 espressione e contenuto - "la bilancia è simbolo di giustizia". II semisimbolismo ottiene la stessa stabilità autonomamente, non attraverso elementi isolati, ma fra coppie. Coppie di significanti, che contraggono una relazione oppositiva con coppie di significati all'interno del medesimo insieme, ottengono la stessa motivazione e la stessa stabilità dei simboli. La parola stessa lo indica: si tratta di simboli a metà. Una metà è data dal piano dell'espressione, l'altra dal piano del contenuto.
Greimas (1984) fa esplicito riferimento a questo modus significandi in poesia e cita le ricerche sul semisimbolismo del linguista russo Roman Jakobson. In particolare Jakobson, nel saggio Sei lezioni sul suono e sul senso (1976), riflette sulla correlazione fra i termini di colore e le vocali, non solo in poesia ma in molte lingue. In ungherese, per esempio, c'è una specie di serie sinestetica tra il cromatismo crescente dei colori - bianco, giallo, giallo scuro, beige, beige scuro, azzurro, azzurro cupo etc. - e il passaggio dalle vocali più alte - a, i, ì aperta, e, è aperta, etc. - a quelle più basse - o, o aperta, u etc ..
Si tratta di fenomeni che i poeti richiamano, ma che sono presenti implicitamente nelle lingue anche se non se ne ha consapevolezza. In determinati contesti una serie di suoni, con precise relazioni fra loro, entra in relazione con una serie di significati, anch'essi già in qualche modo pre-ordinati. Così, per esempio, ricorda Jakobson (1976), «le parole ceche den ("giorno") e noc ("notte"), con l'opposizione del vocalismo acuto e grave, si associano facilmente nella poesiaal contrasto fra la luce di mezzogiorno e le tenebre notturne», in modo da ottenere, appunto, una proporzione del tipo:
acuto : grave :: luce diurna : luce notturna.
Se, come si dice, la poesia elimina l'arbitrarietà del segno, rimotivando al proprio interno i rapporti tra significanti e significati linguistici, è perché essa costruisce omologie strutturali non tra un singolo suono e un singolo senso, ma tra serie di significanti e serie di significati. Il parallelismo, l'inversione, le correlazioni prosodiche, grammaticali, sintattiche etc., ritrovate al momento dell'analisi del testo poetico, vengono in tal modo messe in relazione con altrettanti parallelismi, inversioni e correlazioni istituiti sul piano del contenuto di quello stesso testo:
Una donna s'alza e canta La segue il vento e l'incanta Sulla terra la stende Il sogno vero la prende. Giuseppe Ungaretti, Canto beduino (1932)
A prescindere dalla riconoscibilità e nominabilità di figure del mondo, il componimento poetico costruisce una propria struttura "sovrasegmentale", un linguaggio secondo fatto di rime, di assonanze, di allitterazioni in grado di veicolare una significazione autonoma, efficace (subliminalmente) sui sensi dell'udito, della vista, del tatto e che parla di posizioni corporee e spaziali e orientamenti.
Semisimbolico nelle culture e nel mondo naturale
- Semisimbolico nelle culture e nel mondo naturale
Sarebbe un errore pensare al semisimbolico come a una tecnica arida di decodificazione dei testi. Il mondo naturale e le culture funzionano già in questo modo, facendo tesoro dell'esperienza somatica e sensibile con gli altri, umani, non umani e animali, e semantizzandolaattraverso comportamenti, preferenze, indicazioni che il mondo stesso dà. Ad esempio, per molti popoli e anche tribù, luce e buio sono rispettivamente omologati a positivo e negativo in maniera semisimbolica. Questa associazione infatti è parzialmente motivata per la percezione della sicurezza che la luce del giorno dà in contrapposizione con la paura che nasce al buio. Di notte non si vedono i pericoli. Lo stesso motivo porta ad associare luce/buio, giorno/notte, bianco/nero o colore/non colore a vita/morte. Il maggiore filosofo degli elementi (aria, acqua, terra, fuoco), Gaston Bachelard, ha riconosciuto nel mondo naturale la più straordinaria semantica affacciata ai nostri occhi. Si chiede: «Perché cercare dialettiche di idee quando abbiamo dialettiche di esseri?» (Bachelard 1961). Tra i tanti esempi che fa c'è quello della fiamma della candela, che immagina come una clessidra che cola verso l'alto. Fiamma e clessidra esprimono la comunione del tempo pesante e del tempo leggero, della durata che scorre e della durata che fugge, in quanto figure di due contrapposte immaginazioni, del sollevamento positivo e del decadimento negativo:
fiamma : clessidra :: tempo leggero : tempo pesante.
L'importante è non credere che queste correlazioni siano universali. Alcune sono più stabili e motivate di altre. A rapporto con il cibo, per esempio, si può dire che:
sapore : insapore :: euforico : disforico.
In Italia, quando dimentichiamo di mettere il sale nella pasta e la assaggiamo a fine cottura, la sensazione che ne abbiamo è disforica, negativa. L'insipido "non sa di niente". Questo assunto vale per noi e per l'Occidente, per l'Oriente indiano ancora di più, dove le spezie sono "il sale della vita". La Cina, invece, ha un sistema di valori completamente rovesciato. Lì è l'insapore" a contare, ad essere giudicato positivo ed euforico, sia in cucina sia nelle maniere e strategie di vita, come "fondo indifferente delle cose" a partire dal quale si aprono tutte le possibilità di apprezzamento (Jullien 1996):
insapore : sapore :: euforico : disforico
Semisimbolico nei testi
- Semisimbolico nei testi
Oltre ai meccanismi di funzionamento semisimbolici riscontrabili nelle culture e