Appunti di Diritto Privato: diritti reali, proprietà e possesso
Documento di Gravina Serena su Diritto Privato. Il Pdf, utile per lo studio universitario, esplora i diritti reali, la proprietà, il condominio, la multiproprietà e il possesso, con definizioni e spiegazioni dettagliate.
Mostra di più22 pagine
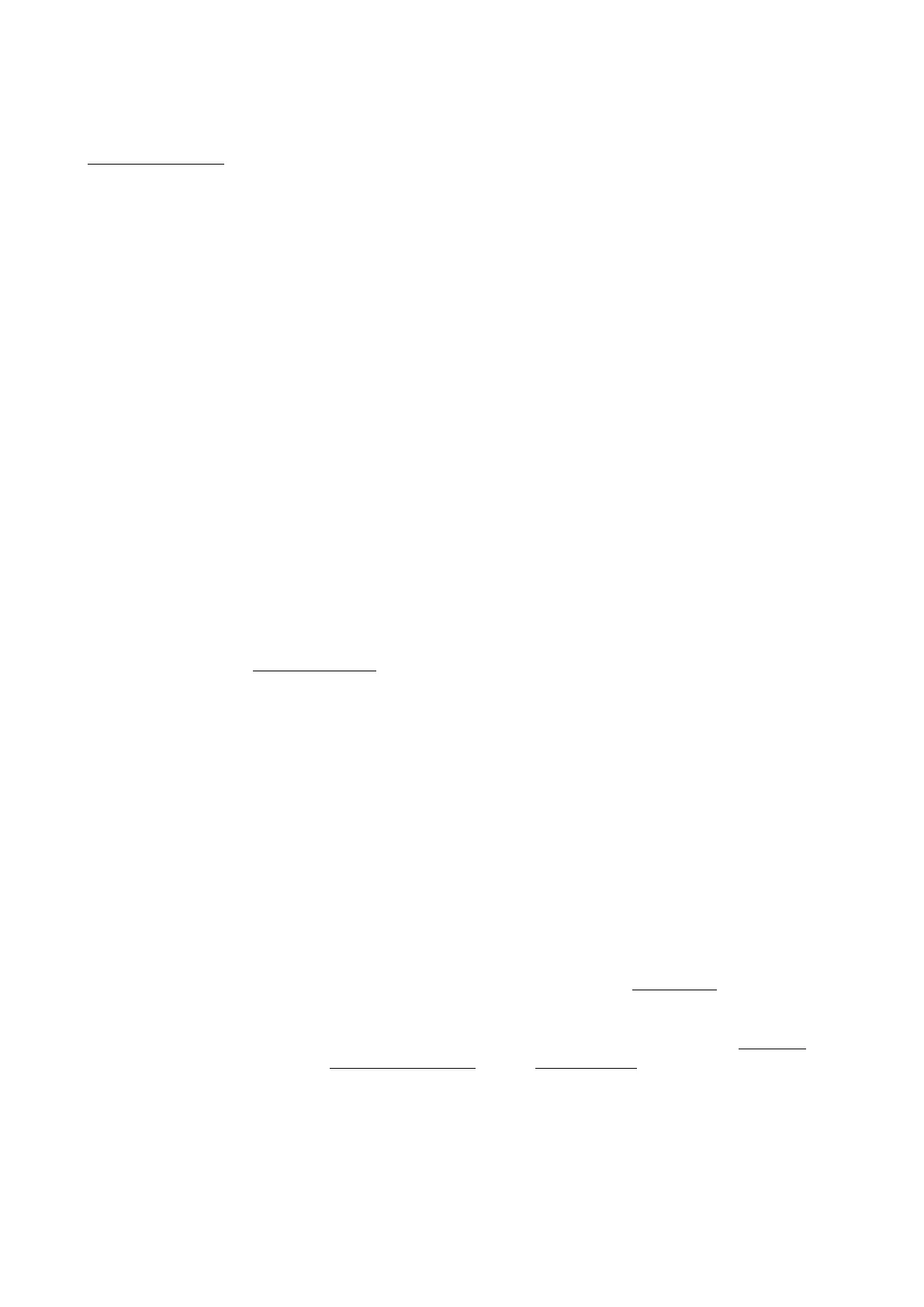
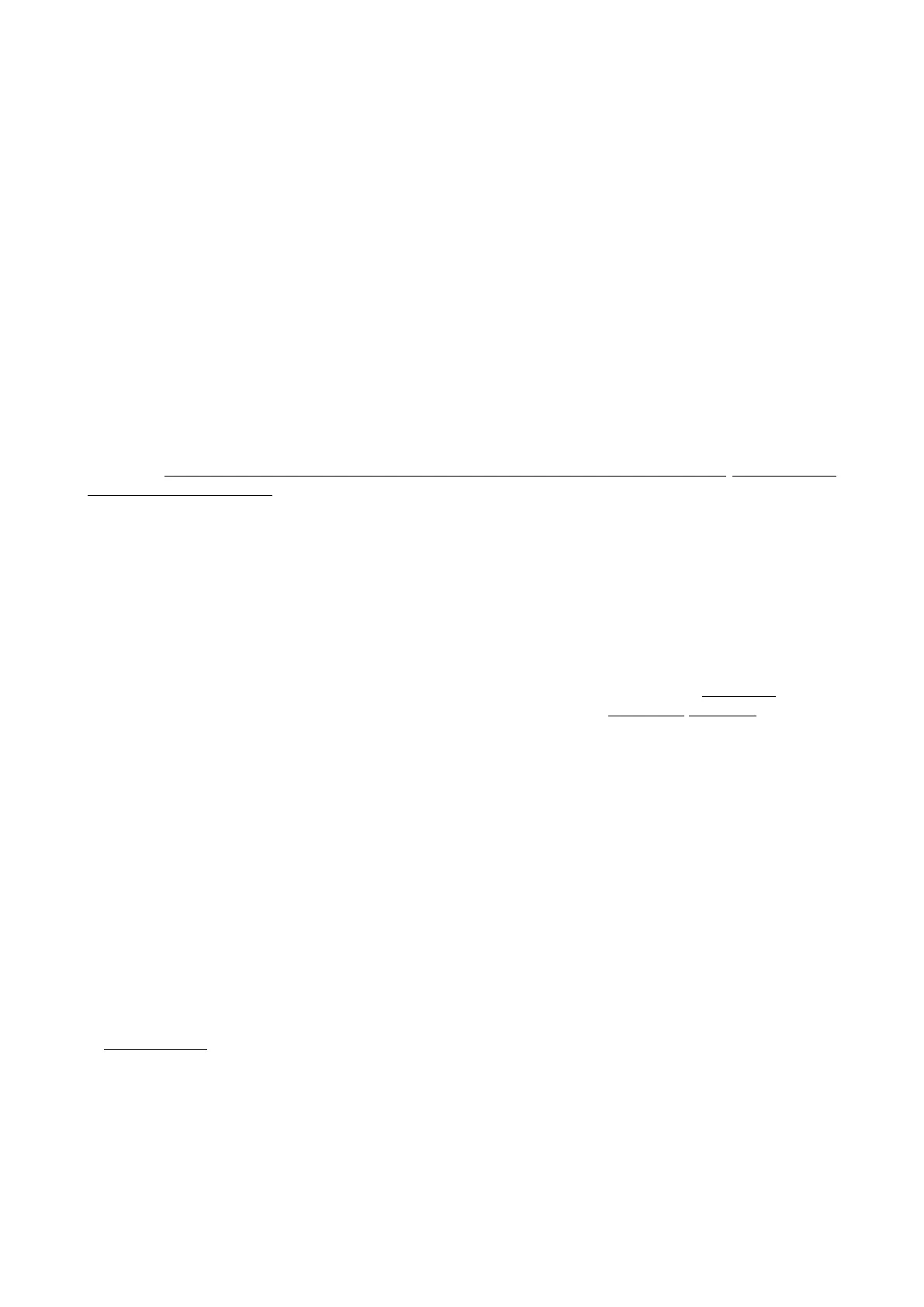
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
I Diritti Reali
Diritto reale è un diritto che ha per oggetto una cosa materiale determinata (in latino res). Nel nostro sistema giuridico sono a numero chiuso, caratterizzati dalla tipicità.
I diritti reali sono caratterizzati:
- Immediatezza: possibilità che il titolare eserciti direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi;
- Assolutezza: dovere di tutti i consociati di astenersi dall'interferire nel rapporto fra il titolare del diritto reale ed il bene che ne è oggetto e, correlativamente, dalla possibilità per il titolare di agire in giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto (efficacia erga omnes del diritto reale);
- Inerenza: opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa.
Si ritiene che i diritti reali costituiscano un numerus clausus e che siano connotati dal carattere della tipicità: con ciò si vuole impedire che i privati possano moltiplicare limiti e vincoli destinati a comprimere i poteri del proprietario, con il rischio di rendere inefficiente la gestione del bene e si intende tutelare i terzi che, volendo acquisire diritti sulla cosa, devono essere posti in grado di conoscere con esattezza i vincoli che gravano su di essa.
Si è soliti distinguere tra la proprietà privata (ius in re propria) e i diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui e che sono destinati a coesistere (iura in re aliena), comprimendolo, con il diritto del proprietario.
I diritti reali in re aliena si distinguono in diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali) e diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca). I primi attribuiscono al loro titolare il diritto di trarre dal bene talune delle utilità che lo stesso è in grado di fornire; i secondi attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi assegnare, con prelazione rispetto ad altri creditori, il ricavato dall'eventuale alienazione forzata del bene, in caso di mancato adempimento dell'obbligo garantito.
La Proprietà
L'art. 832 c.c. enuncia il principio secondo cui al proprietario spetta:
a. il potere di godimento del bene (il potere di trarre dalla cosa le utilità che la stessa è in grado di fornire, decidendo se, come e quando utilizzarla; direttamente o indirettamente); b. il potere di disposizione del bene (potere di cedere ad altri diritti sulla cosa).
Entrambi i poteri sono pieni ed esclusivi. La proprietà è caratterizzata dai connotati:
a. della pienezza: attribuzione al proprietario del diritto di fare della cosa tutto ciò che vuole; b. della esclusività: attribuzione al proprietario del diritto di vietare ogni ingerenza di terzi in ordine alle scelte che, in tema di godimento e di disposizione del bene, il proprietario si riserva di effettuare con totale arbitrio e discrezionalità.
L'art. 832 riconosce al proprietario il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, ma solo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Le caratteristiche della assolutezza e della esclusività sono tipiche ormai solo della proprietà dei beni di uso strettamente personale. Quanto agli altri beni l'ordinamento non rimette integralmente al proprietario le scelte in ordine al loro utilizzo. Il codice civile detta una disciplina differenziata per le proprietà dei beni di interesse storico e artistico, per la proprietà rurale, per la proprietà edilizia, per la proprietà fondiaria: elaborando per ciascuna categoria di beni una serie di previsioni miranti a conciliare l'interesse egoistico del proprietario con l'interesse degli altri proprietari o della collettività.
Con l'avvento della Carta costituzionale, inoltre, la proprietà non solo non viene più dichiarata inviolabile, ma non viene neppure disciplinata fra i principi fondamentali, né fra i diritti di libertà: essa è contemplata nel titolo relativo ai rapporti economici.
La cost. dichiara che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge (art. 42.2 c.c.): tale garanzia implica che non è consentito al legislatore ordinario di sopprimere l'istituto della proprietà privata, e che sarebbe altresì in contrasto con i principi costituzionali un'eventuale trasformazione del nostro sistema in un ordinamento in cui i beni siano prevalentemente collettivizzati.
Tuttavia l'art. 43 Cost. espressamente prevede che a fini di utilità generale il legislatore ben potrebbe escludere l'ammissibilità della proprietà privata per quanto riguarda una determinata categoria di beni che si riferiscano 1GRAVINA SERENA- Diritto privato a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Inoltre l'art. 42.2 Cost. demanda espressamente al legislatore ordinario il compito di determinare i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Quindi, il legislatore è legittimato ad intervenire per delineare, con riferimento a singole categorie di beni, il contenuto dei poteri (di godimento e di disposizione) che competono al proprietario (interventi conformativi dei vari statuti proprietari.
La proprietà è caratterizzata:
- Imprescrittibilità (la proprietà non decade mai, non si può perdere per "non uso", solo per usucapione, art. 948 c.c.);
- Perpetuità;
- Elasticità: i poteri che normalmente competono al proprietario possono essere compressi in virtù della coesistenza sullo stesso bene di altri diritti reali (es. usufrutto) o di vincoli di carattere pubblicistico; tali poteri sono però destinati a riespandersi automaticamente non appena dovesse venire meno il diritto reale o il vincolo pubblicistico concorrente.
Espropriazione e Indennizzo
Art. 42.3, la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale (interesse della collettività ad utilizzare il bene del proprietario, ove occorra, a fini di pubblico interesse). La Costituzione prevede che la posizione del privato possa essere sacrificata solo in presenza:
a) di un interesse generale; b) di una previsione legislativa che lo consenta (cd riserva di legge); c) di un indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce nell'interesse della collettività.
Riguardo l'espropriazione, è superata la nozione che vedeva l"espropriazione" solo come il trasferimento della titolarità di un bene dal precedente proprietario (espropriato) ad un altro soggetto, pubblico o privato (beneficiario dell'espropriazione): cd espropriazione traslativa.
La Corte Costituzionale ritiene che rientrino nella nozione d'espropriazione anche quelle limitazioni che, pur non determinando per il proprietario la perdita del suo diritto, siano tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile relativamente alla destinazione inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio (cd espropriazione larvata o limiti espropriativi) (il soggetto in questione è ancora formalmente proprietario di un bene ma, in virtù di dette limitazioni, non può goderne appieno).
La Corte tende a distinguere tra disposizioni (interventi di conformazione dei vari statuti proprietari) che si riferiscono ad intere categorie di beni, sottoponendo tutti i beni appartenenti alla categoria ad un particolare regime di godimento e/o disposizione e disposizioni (interventi di espropriazione larvata) che si riferiscono a singoli cespiti, restringendo i poteri del proprietario rispetto a quelli riconosciuti agli altri titolari di beni appartenenti a quella medesima categoria, o annulandone o diminuendone in modo apprezzabile il valore di scambio: le prime (es. restrizioni ai poteri di godimento e di disposizione spettanti a tutti indiscriminatamente i proprietari di beni culturali) rientrano nel concetto di conformazione del contenuto del diritto di proprietà sui beni appartenenti a quella determinata categoria e non comportano indennizzo; le seconde (es. quelle che impongono particolari restrizioni, rispetto ai poteri normalmente spettanti ai proprietari di aree agricole, al singolo titolare il cui fondo sia gravato da non marginali vincoli alla coltivazione, a tutela della sicurezza dei voli che si effettuano nel limitrofo aeroporto) rientrano invece nel concetto di espropriazione e necessitano di indennizzo.
Il DPR 327/2001 prevede che nella nozione di espropriazione di beni immobili rientri non solo l'ipotesi di passaggio del diritto di proprietà dall'espropriato al beneficiario dell'espropriazione, ma anche quella del vincolo sostanzialmente espropriativo, cioè quella in cui il fondo sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
Quanto all'indennizzo, la Corte Cost. ha escluso che l'indennizzo debba necessariamente consistere unicamente nell'integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto dall'espropriato in base al solo valore venale (di mercato) del bene; di contro ha escluso anche che l'indennizzo possa essere dal legislatore stabilito in termini meramente simbolici o irrisori, dovendo piuttosto rappresentare un serio ristoro del pregiudizio conseguente all'espropriazione.
2GRAVINA SERENA- Diritto privato Il DPR 327/2001 ha stabilito dei criteri di valutazione dell'indennizzo relativi all'espropriazione di aree non edificabili coltivate (l'indennizzo è pari al valore agricolo più un'indennità aggiuntiva se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale); la giurisprudenza dà una soluzione al problema dei criteri di quantificazione dell'indennizzo in caso di espropriazione di un'area non edificabile; aree edificabili (l'indennizzo è pari al suo valore venale); in caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennizzo è pari al suo valore venale; in caso di vincolo sostanzialmente espropriativo, l'indennizzo è commisurato al danno effettivamente prodotto.
Al fine di incentivare la cessione volontaria della proprietà del bene dall'espropriando al beneficiario dell'espropriazione senza necessità di addivenire ad un formale decreto di esproprio, la legge prevede che il corrispettivo della cessione sia, di regola, maggiore rispetto all'indennizzo.
L'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, dopo averlo modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, è legittimata ad adottare un provvedimento (provvedimento di acquisizione coattiva), in forza del quale l'immobile viene acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile: acquisizione sanante. Al proprietario è riconosciuto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto.
La Proprietà dei Beni Culturali
Beni culturali: cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, o che comunque costituiscono testimonianze aventi valore di civiltà. Art. 9.2 Cost. La repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 839 c.c .: postula un particolare regime dominicale per le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico o etnografico.
D.lgs. 42/2004: impone al proprietario, cui sia stata notificata dal Ministero per i beni e le attività culturali la c.d. dichiarazione dell'interesse culturale, una serie di a. limiti relativi al potere di godimento (es. prevedendo che i beni culturali non possano essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico; e b. limiti al potere di disposizione (es. prevedendo che l'obbligo di denuncia degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di detti beni.
Inoltre, i beni culturali possono essere espropriati per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorarne le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica.
La Proprietà Edilizia
Al proprietario di un'area interessata all'edificazione compete il c.d. ius aedificandi: il diritto di costruire. L'attività edificatoria può essere svolta solo nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. L'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata: a) al previo rilascio, da parte dell'autorità comunale, di un permesso di costruire, quanto agli interventi di maggiore impatto (es. interventi di nuova costruzione). Tale permesso può essere rilasciato solo se l'intervento da realizzare sia conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comporta l'obbligo a favore del Comune di un contributo di costruzione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, che consenta all'amministrazione municipale di provvedere, ove non già esistenti, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (es. strade) e secondaria (es. asili nidi); b) alla segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A) indirizzata all'amministrazione comunale; c) alla comunicazione, anche telematica, dell'inizio dei lavori (C.I.L.) per interventi di minore rilevanza (es. manutenzione straordinaria).
Non richiede alcun titolo abilitativo la realizzazione degli interventi edilizi minori.
Inoltre, per evitare l'abusivismo edilizio, la legge fa ricorso a strumenti di tipo amministrativo (es. sospensione dei lavori sanzione pecuniaria,) e penale, ma anche di tipo privatistico quali: a) sanzione di nullità per gli atti inter vivos, aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali su terreni, ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dall'autorità comunale, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata; b) sanzione di nullità per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali su edifici, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, ove dagli stessi atti non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso per costruire; c) divieto alle aziende erogatrici di servizi pubblici, di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire e sanziona con la nullità i relativi contratti, ove la richiesta dell'utente non sia corredata dall'indicazione degli estremi di detto permesso; d) imposizione a chi abbia violato le disposizioni che regolamentano l'attività edilizia dell'obbligo di risarcire i danni che terzi ne abbiano eventualmente 3