Estinzione delle obbligazioni e requisiti essenziali del contratto
Documento universitario sull'estinzione delle obbligazioni e i requisiti essenziali del contratto. Il Pdf esplora la nullità, l'annullabilità, la rescissione e la risoluzione del contratto, con riferimenti al Codice Civile, utile per studenti di Diritto.
Mostra di più23 pagine
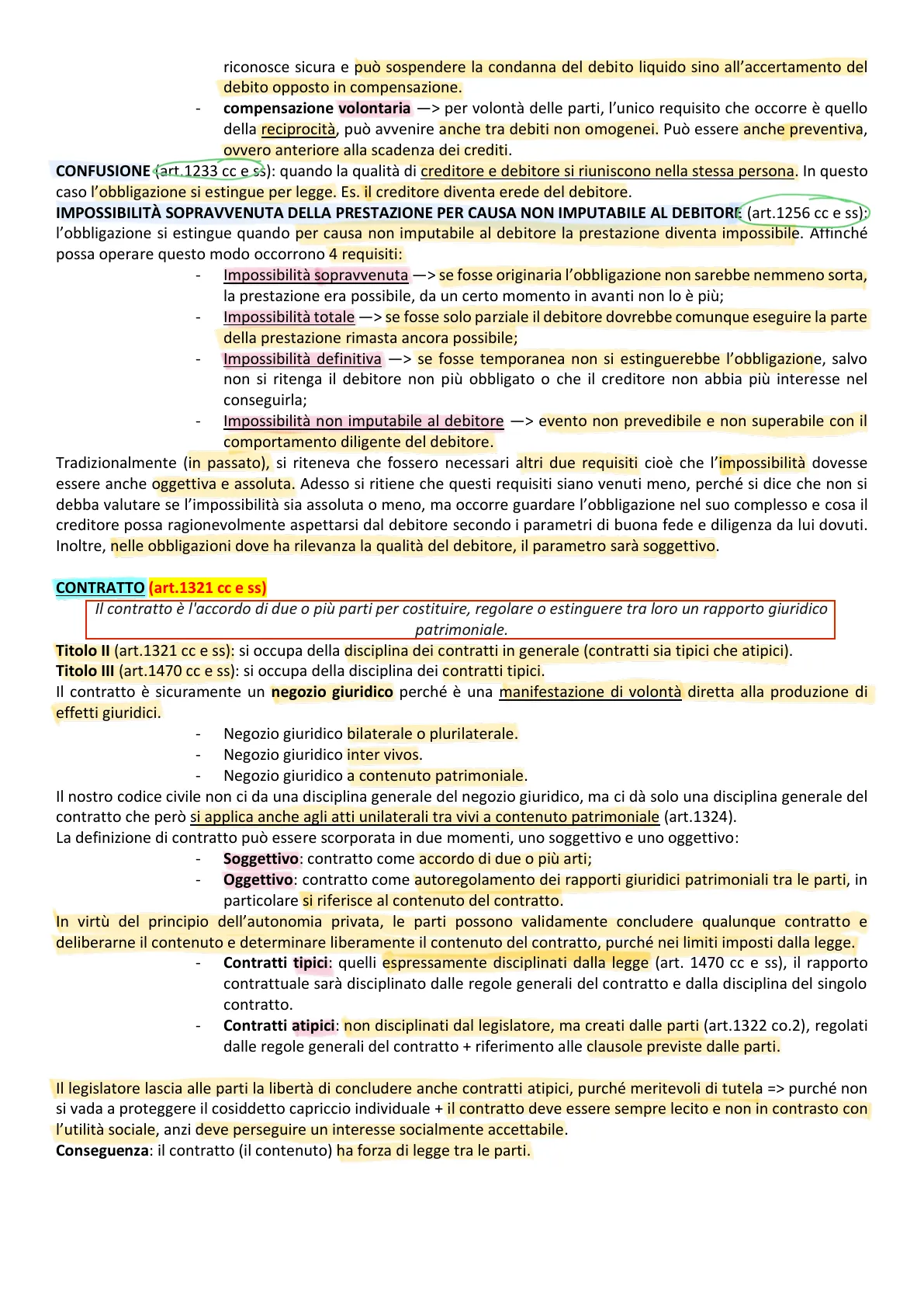
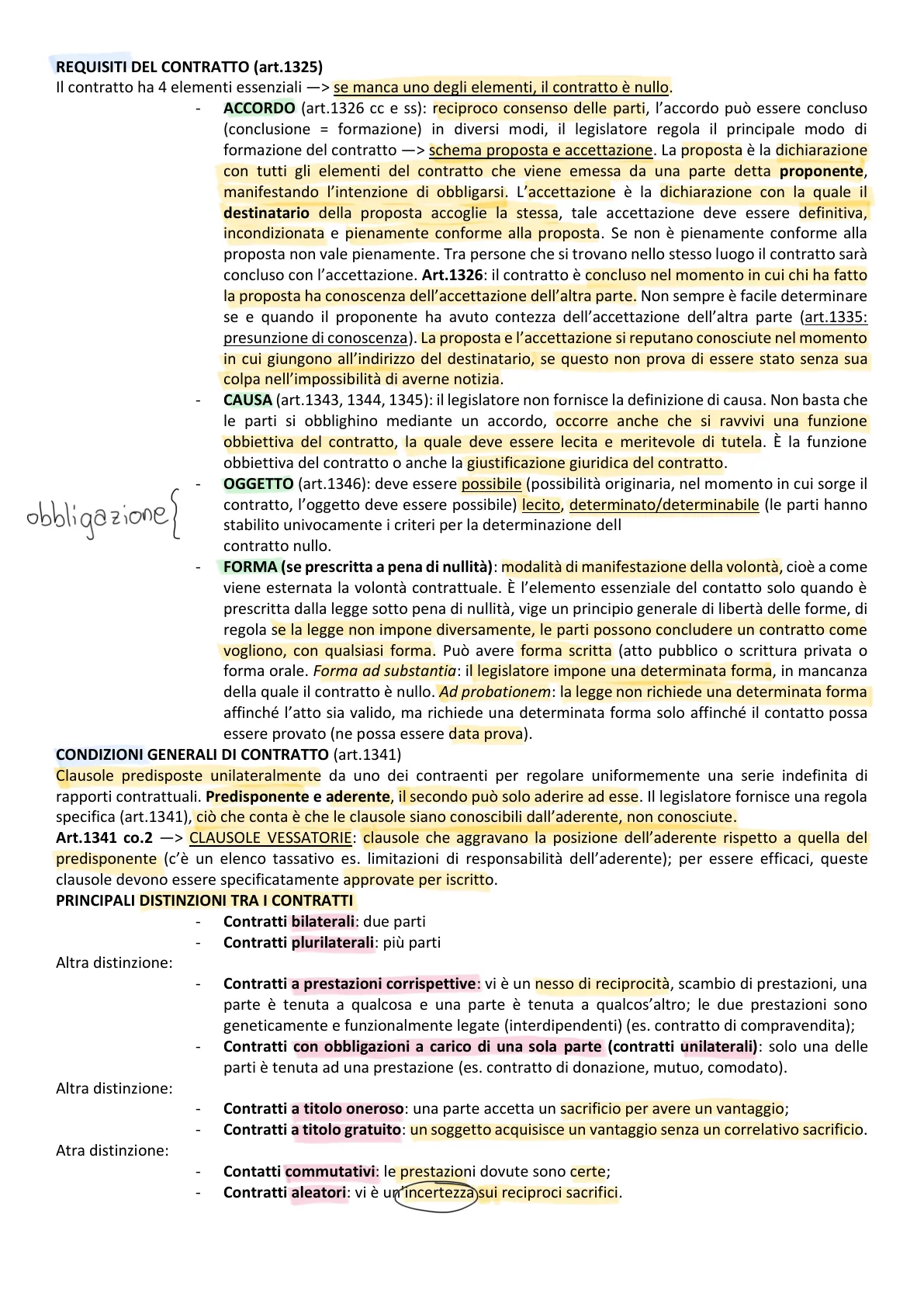
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Estinzione delle Obbligazioni
riconosce sicura e può sospendere la condanna del debito liquido sino all'accertamento del debito opposto in compensazione.
Compensazione Volontaria
- compensazione volontaria -> per volontà delle parti, l'unico requisito che occorre è quello della reciprocità, può avvenire anche tra debiti non omogenei. Può essere anche preventiva, ovvero anteriore alla scadenza dei crediti.
Confusione (art.1233 cc e ss)
CONFUSIONE {art.1233 cc e ss): quando la qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona. In questo caso l'obbligazione si estingue per legge. Es. il creditore diventa erede del debitore.
Impossibilità Sopravvenuta della Prestazione
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE (art.1256 cc e ss): l'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile. Affinché possa operare questo modo occorrono 4 requisiti:
- Impossibilità sopravvenuta -> se fosse originaria l'obbligazione non sarebbe nemmeno sorta, la prestazione era possibile, da un certo momento in avanti non lo è più;
- Impossibilità totale -> se fosse solo parziale il debitore dovrebbe comunque eseguire la parte della prestazione rimasta ancora possibile;
- Impossibilità definitiva -> se fosse temporanea non si estinguerebbe l'obbligazione, salvo non si ritenga il debitore non più obbligato o che il creditore non abbia più interesse nel conseguirla;
- Impossibilità non imputabile al debitore -> evento non prevedibile e non superabile con il comportamento diligente del debitore.
Tradizionalmente (in passato), si riteneva che fossero necessari altri due requisiti cioè che l'impossibilità dovesse essere anche oggettiva e assoluta. Adesso si ritiene che questi requisiti siano venuti meno, perché si dice che non si debba valutare se l'impossibilità sia assoluta o meno, ma occorre guardare l'obbligazione nel suo complesso e cosa il creditore possa ragionevolmente aspettarsi dal debitore secondo i parametri di buona fede e diligenza da lui dovuti. Inoltre, nelle obbligazioni dove ha rilevanza la qualità del debitore, il parametro sarà soggettivo.
Contratto (art.1321 cc e ss)
CONTRATTO (art.1321 cc e ss) Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Disciplina del Contratto
Titolo II (art.1321 cc e ss): si occupa della disciplina dei contratti in generale (contratti sia tipici che atipici). Titolo III (art.1470 cc e ss): si occupa della disciplina dei contratti tipici. Il contratto è sicuramente un negozio giuridico perché è una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici. Negozio giuridico bilaterale o plurilaterale. Negozio giuridico inter vivos. Negozio giuridico a contenuto patrimoniale. Il nostro codice civile non ci da una disciplina generale del negozio giuridico, ma ci dà solo una disciplina generale del contratto che però si applica anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (art.1324).
Definizione di Contratto
La definizione di contratto può essere scorporata in due momenti, uno soggettivo e uno oggettivo:
- Soggettivo: contratto come accordo di due o più arti;
- Oggettivo: contratto come autoregolamento dei rapporti giuridici patrimoniali tra le parti, in particolare si riferisce al contenuto del contratto.
In virtù del principio dell'autonomia privata, le parti possono validamente concludere qualunque contratto e deliberarne il contenuto e determinare liberamente il contenuto del contratto, purché nei limiti imposti dalla legge.
Contratti Tipici e Atipici
- Contratti tipici: quelli espressamente disciplinati dalla legge (art. 1470 cc e ss), il rapporto contrattuale sarà disciplinato dalle regole generali del contratto e dalla disciplina del singolo contratto.
- Contratti atipici: non disciplinati dal legislatore, ma creati dalle parti (art.1322 co.2), regolati dalle regole generali del contratto + riferimento alle clausole previste dalle parti.
Il legislatore lascia alle parti la libertà di concludere anche contratti atipici, purché meritevoli di tutela => purché non si vada a proteggere il cosiddetto capriccio individuale + il contratto deve essere sempre lecito e non in contrasto con l'utilità sociale, anzi deve perseguire un interesse socialmente accettabile. Conseguenza: il contratto (il contenuto) ha forza di legge tra le parti.
Requisiti del Contratto (art.1325)
REQUISITI DEL CONTRATTO (art.1325) Il contratto ha 4 elementi essenziali -> se manca uno degli elementi, il contratto è nullo.
Accordo (art.1326 cc e ss)
- ACCORDO (art.1326 cc e ss): reciproco consenso delle parti, l'accordo può essere concluso (conclusione = formazione) in diversi modi, il legislatore regola il principale modo di formazione del contratto -> schema proposta e accettazione. La proposta è la dichiarazione con tutti gli elementi del contratto che viene emessa da una parte detta proponente, manifestando l'intenzione di obbligarsi. L'accettazione è la dichiarazione con la quale il destinatario della proposta accoglie la stessa, tale accettazione deve essere definitiva, incondizionata e pienamente conforme alla proposta. Se non è pienamente conforme alla proposta non vale pienamente. Tra persone che si trovano nello stesso luogo il contratto sarà concluso con l'accettazione. Art.1326: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Non sempre è facile determinare se e quando il proponente ha avuto contezza dell'accettazione dell'altra parte (art.1335: presunzione di conoscenza). La proposta e l'accettazione si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questo non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.
obbligazione?
Causa (art.1343, 1344, 1345)
- CAUSA (art.1343, 1344, 1345): il legislatore non fornisce la definizione di causa. Non basta che le parti si obblighino mediante un accordo, occorre anche che si ravvivi una funzione obbiettiva del contratto, la quale deve essere lecita e meritevole di tutela. È la funzione obbiettiva del contratto o anche la giustificazione giuridica del contratto.
Oggetto (art.1346)
- OGGETTO (art.1346): deve essere possibile (possibilità originaria, nel momento in cui sorge il contratto, l'oggetto deve essere possibile) lecito, determinato/determinabile (le parti hanno stabilito univocamente i criteri per la determinazione dell'oggetto), la loro mancanza rende il contratto nullo.
Forma (se prescritta a pena di nullità)
- FORMA (se prescritta a pena di nullità): modalità di manifestazione della volontà, cioè a come viene esternata la volontà contrattuale. È l'elemento essenziale del contatto solo quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità, vige un principio generale di libertà delle forme, di regola se la legge non impone diversamente, le parti possono concludere un contratto come vogliono, con qualsiasi forma. Può avere forma scritta (atto pubblico o scrittura privata o forma orale. Forma ad substantia: il legislatore impone una determinata forma, in mancanza della quale il contratto è nullo. Ad probationem: la legge non richiede una determinata forma affinché l'atto sia valido, ma richiede una determinata forma solo affinché il contatto possa essere provato (ne possa essere data prova).
Condizioni Generali di Contratto (art.1341)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (art.1341) Clausole predisposte unilateralmente da uno dei contraenti per regolare uniformemente una serie indefinita di rapporti contrattuali. Predisponente e aderente, il secondo può solo aderire ad esse. Il legislatore fornisce una regola specifica (art.1341), ciò che conta è che le clausole siano conoscibili dall'aderente, non conosciute.
Clausole Vessatorie (art.1341 co.2)
Art.1341 co.2 -> CLAUSOLE VESSATORIE: clausole che aggravano la posizione dell'aderente rispetto a quella del predisponente (c'è un elenco tassativo es. limitazioni di responsabilità dell'aderente); per essere efficaci, queste clausole devono essere specificatamente approvate per iscritto.
Principali Distinzioni tra i Contratti
PRINCIPALI DISTINZIONI TRA I CONTRATTI
Contratti Bilaterali e Plurilaterali
- Contratti bilaterali: due parti
- Contratti plurilaterali: più parti
Contratti a Prestazioni Corrispettive e Unilaterali
Altra distinzione:
- Contratti a prestazioni corrispettive: vi è un nesso di reciprocità, scambio di prestazioni, una parte è tenuta a qualcosa e una parte è tenuta a qualcos'altro; le due prestazioni sono geneticamente e funzionalmente legate (interdipendenti) (es. contratto di compravendita);
- Contratti con obbligazioni a carico di una sola parte (contratti unilaterali): solo una delle parti è tenuta ad una prestazione (es. contratto di donazione, mutuo, comodato).
Contratti a Titolo Oneroso e Gratuito
Altra distinzione:
- Contratti a titolo oneroso: una parte accetta un sacrificio per avere un vantaggio;
- Contratti a titolo gratuito: un soggetto acquisisce un vantaggio senza un correlativo sacrificio.
Contratti Commutativi e Aleatori
Atra distinzione:
- Contatti commutativi: le prestazioni dovute sono certe;
- Contratti aleatori: vi è un'incertezza sui reciproci sacrifici.
Contratti a Esecuzione Istantanea e di Durata
Altra distinzione:
- Contratti a esecuzione istantanea: la prestazione delle parti è concentrata in un certo momento, che può anche essere differito nel tempo -> contratti a esecuzione immediata, contratti a esecuzione differita;
- Contratti di durata: la prestazione è continua nel tempo oppure si ripete periodicamente.
Contratti Consensuali e Reali
Altra distinzione:
- Contratti consensuali: si perfezionano con il consenso delle parti, rappresentano la regola;
- Contratti reali: si perfezionano con la consegna della cosa, il consenso è sempre necessario, ma il non è sufficiente, occorre anche la consegna del bene dedotto in contratto, pochi ma importanti contratti (es. contratto di comodato, di mutuo, di deposito, di pegno).
Contratti a Effetti Reali e Obbligatori
Altra distinzione:
- Contratti a effetti reali: si costituiscono o trasferiscono diritti in capo ad altri (art.1376);
- Contratti a effetti obbligatori: contratti mediante i quali sorgono obbligazioni per le parti.
Un contratto può avere si effetti reali che obbligatori, uno non esclude l'altro.
Le Parti del Contratto - La Rappresentanza (art.1387 cc e ss)
LE PARTI DEL CONTRATTO - LA RAPPRESENTANZA (art.1387 cc e ss) Istituto mediante il quale, a un soggetto chiamato rappresentante, è attribuito il potere di sostituirsi ad un altro soggetto nel compimento di atti giuridici.
Rappresentanza Diretta e Indiretta
- Rappresentanza diretta: quando un soggetto agisce in nome e per conto di un altro soggetto. Occorre sia la sperita del soggetto sia l'agire nell'interesse del rappresentato. Vi è una scissione tra la parte in senso formale del contratto (autore della volontà, colui che manifesta la volontà contrattuale) e la parte in senso sostanziale del contratto (parte su cui ricadono gli effetti giuridici di quell'atto).
- Rappresentanza indiretta: il rappresentante agisce solo per conto di un altro soggetto (il rappresentato). Manca la sperita del nome perché il soggetto agisce in nome proprio.
La rappresentanza disciplinata dal codice è la RAPPRESENTANZA DIRETTA. Art.1388 -> rappresentanza diretta -> il rappresentante agisce per nome e in conto del rappresentato + gli effetti giuridici dell'atto compiuto dal rappresentato si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Rappresentante: partecipa all'atto con una propria volontà, è lui che stipula il contratto seppur in nome e per conto del rappresentato. Nunzio: trasmette la volontà altrui, non manifesta la sua volontà.
Potere Rappresentativo e Procura
Potere rappresentativo (art.1387): la rappresentanza può avere la sua fonte nella legge o nella volontà delle parti. Procura: (la rappresentanza può essere conferita per volontà delle parti) negozio unilaterale con il quale si conferisce il potere rappresentativo ad un altro soggetto -> si rende noto ai soggetti terzi che il rappresentante ha il potere di agire per conto del rappresentato e in suo nome. La procura potrebbe essere inserita all'interno di un contratto (es. contratto di mandato). La procura può essere generale (conferisce il potere di compiere tutti gli atti concernenti gli interessi patrimoniali dell'interessato, ad esclusione degli atti di rappresentanza e straordinaria amministrazione) o speciale (potere di compiere singoli atti giuridici). Art.1392: forma per relationem, la procura dovrà avere la stessa forma prescritta, pena di nullità, per l'atto che deve essere compiuto.
Falsa Rappresentanza (art.1398)
Cosa accade se un soggetto agisce in rappresentanza di un altro non avendo o eccedendo il potere amministrativo? Falsa rappresentanza (art.1398): il falso rappresentante è responsabile del danno che il terzo ha subito per avere, senza sua colpa, confidato nell'efficacia del contratto + obbligo di risarcimento del danno -> ipotesi di responsabilità precontrattuale (riguarda la lesione della libertà negoziale);
Ratifica (art.1399)
Art.1399: il contratto compiuto dal falso rappresentante con un soggetto terzo è validamente formato, però è inefficace nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. L'interessato può ratificare l'atto compiuto dal falso rappresentante. Ratifica = istituto mediante il quale si rende efficace l'atto compiuto dal falso rappresentante; considerata come una procura successiva, con la quale si approva l'atto compiuto dal falso rappresentante. La ratifica ha effetto retroattivo, è come se l'atto fosse stato regolarmente compiuto; se manca la ratifica, l'atto è inefficace. Il terzo e il falso rappresentante possono di comune accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandoli un termine, oltrepassato il quale la ratifica si intende negata.