Diritto Pubblico: funzioni, distinzioni e istituzioni dell'Unione Europea
Documento di Università sul Diritto Pubblico. Il Pdf, adatto per lo studio universitario, esplora il Diritto Pubblico, le sue funzioni, le distinzioni tra diritto pubblico e privato, i gruppi sociali, le norme giuridiche e le teorie istituzionali e normative, includendo le istituzioni e le fonti del diritto dell'Unione Europea.
See more30 Pages
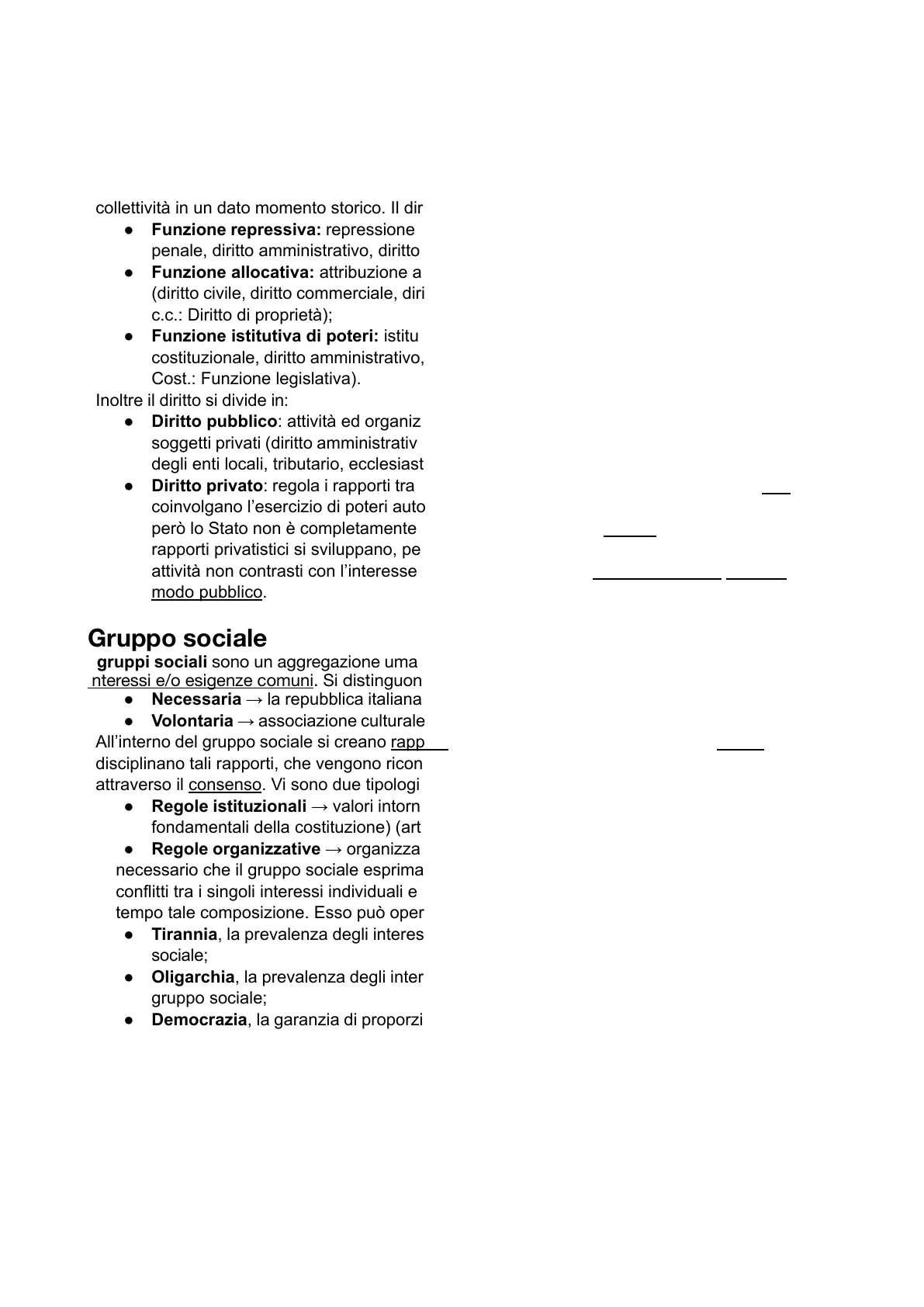
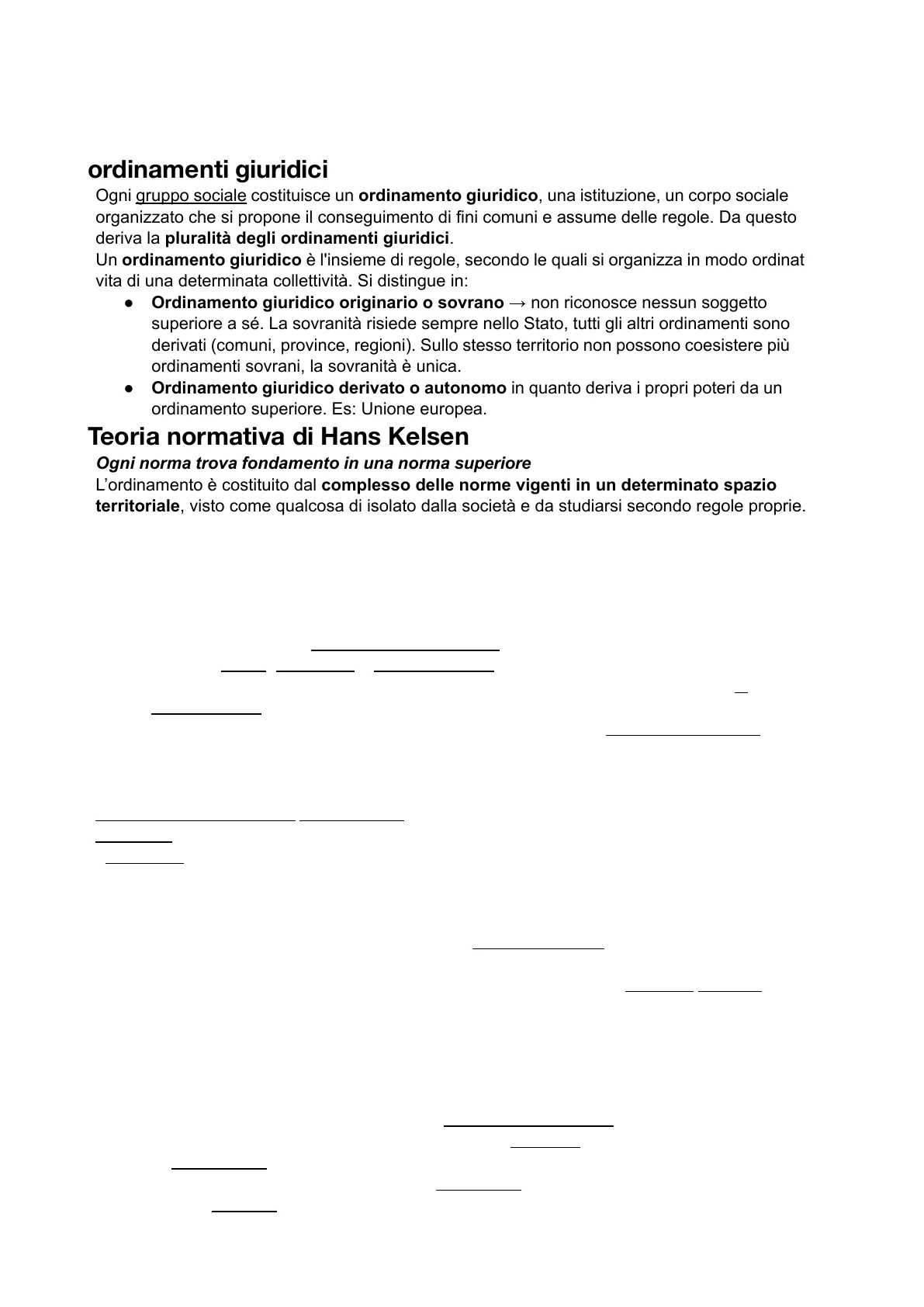
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Diritto Pubblico: Funzioni e Divisioni
Il diritto è l'insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico. Il diritto ha tre funzioni:
- Funzione repressiva: repressione di comportamenti socialmente pericolosi (diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario) (es. art 624 c.p .: Furto);
- Funzione allocativa: attribuzione agli individui ed alla collettività di beni e servizi (diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario, diritto amministrativo) (es. art. 832 c.c .: Diritto di proprietà);
- Funzione istitutiva di poteri: istituzione ed assegnazione di poteri pubblici (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale) (es. art. 70 Cost .: Funzione legislativa).
Inoltre il diritto si divide in:
- Diritto pubblico: attività ed organizzazione dei pubblici poteri e loro rapporti con i soggetti privati (diritto amministrativo, costituzionale, penale, parlamentare, regionale e degli enti locali, tributario, ecclesiastico, processuale civile, processuale penale);
- Diritto privato: regola i rapporti tra soggetti privati lo Stato ed i suoi apparati che non coinvolgano l'esercizio di poteri autoritativi (diritto civile, commerciale, societario ... ). Qui però lo Stato non è completamente assente, ma definisce il quadro entro il quale i rapporti privatistici si sviluppano, per garantire una certa parità tra i privati e che la loro attività non contrasti con l'interesse generale. Ecco perché tutto il diritto è in qualche modo pubblico.
Gruppo Sociale e Regole
I gruppi sociali sono un aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni. Si distinguono ad appartenenza:
- Necessaria -> la repubblica italiana, la famiglia (in cui si nasce);
- Volontaria -> associazione culturale, sportiva, sindacato.
All'interno del gruppo sociale si creano rapporti tra i soggetti che lo compongono e regole che disciplinano tali rapporti, che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo attraverso il consenso. Vi sono due tipologie di regole:
- Regole istituzionali -> valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito (i principi fondamentali della costituzione) (art. 1-54);
- Regole organizzative -> organizzazione e struttura del gruppo sociale. (art.55-139). E' necessario che il gruppo sociale esprima un principio ordinatore che componga e risolva i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale e stabilizzi nel tempo tale composizione. Esso può operare:
- Tirannia, la prevalenza degli interessi di un singolo su tutti i componenti del gruppo sociale;
- Oligarchia, la prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo sociale;
- Democrazia, la garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i
consociati. Gli strumenti che garantiscono la democrazia sono:
- Il principio della maggioranza (semplice, assoluta, qualificata)
- Limitata con garanzie poste a tutela delle minoranze
- Trasparenza nell'esercizio dei poteri pubblici
- Tutela delle libertà civili
- Effettiva partecipazione all'organizzazione del paese
- Separazione dei poteri (Montesquieu: legislativo, esecutivo e giudiziario)
- Garanzia della libertà
Teoria Istituzionale di Santi Romano
Pluralità degli Ordinamenti Giuridici
Ogni gruppo sociale costituisce un ordinamento giuridico, una istituzione, un corpo sociale organizzato che si propone il conseguimento di fini comuni e assume delle regole. Da questo deriva la pluralità degli ordinamenti giuridici.
Un ordinamento giuridico è l'insieme di regole, secondo le quali si organizza in modo ordinato la vita di una determinata collettività. Si distingue in:
- Ordinamento giuridico originario o sovrano -> non riconosce nessun soggetto superiore a sé. La sovranità risiede sempre nello Stato, tutti gli altri ordinamenti sono derivati (comuni, province, regioni). Sullo stesso territorio non possono coesistere più ordinamenti sovrani, la sovranità è unica.
- Ordinamento giuridico derivato o autonomo in quanto deriva i propri poteri da un ordinamento superiore. Es: Unione europea.
Teoria Normativa di Hans Kelsen
Ogni norma trova fondamento in una norma superiore L'ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio territoriale, visto come qualcosa di isolato dalla società e da studiarsi secondo regole proprie. Questa teoria legge le norme in via gerarchica, secondo cui la costituzione coincide con il contenuto del documento costituzionale. Ogni norma trova fondamento in una norma superiore (fino ad arrivare alla norma fondamentale).
Norma Giuridica
La norma giuridica detta le regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale e possono essere scritte, non scritte e consuetudinarie. Le sue caratteristiche sono:
- La generalità -> cioè l'applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti (le norme speciali si riferiscono ad ipotesi determinate);
- L'astrattezza -> cioè ripetibilità dell'applicazione nel tempo (le norme eccezionali si riferiscono a specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo);
- Principio di effettività -> quando una norma viene osservata e rispettata dai consociati (concreta applicazione).
Generalità = Tutti i soggetti Astrattezza =. Tutti i casi
I destinatari delle norme giuridiche sono i soggetti di diritto. Per soggetto di diritto si intende ogni soggetto che l'ordinamento giuridico considera come possibile titolare di diritti e di obblighi. Il soggetto di diritto comprende due sottospecie:
- Persona fisica -> ogni essere umano che assume, dal momento della nascita, lo stato di soggetto di diritto e come tale una capacità giuridica;
- Persona giuridica -> è un soggetto di diritto costituito da persone fisiche e da beni, volti al raggiungimento di fini comuni, cui l'ordinamento riconosce la capacità giuridica; è responsabile dei propri debiti. Può essere anche un ente. Le persone giuridiche possono essere pubbliche, come enti pubblici (es. università), regioni, comuni e altri enti territoriali; oppure possono essere persone giuridiche private come associazioni, fondazioni, società per azioni e società con diversi tipi di responsabilità.
La capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri e si acquista dal momento della nascita (al primo atto di respirazione polmonare) (art. 1 c.c.). Essa non è un attributo innato, ma è una concessione dell'ordinamento.
La capacità di agire è l'attitudine a compiere atti giuridici e si acquisisce a diciotto anni (la maggiore età) (art. 2 c.c.).
Posizioni Giuridiche Soggettive
Le norme giuridiche attribuiscono ai soggetti di diritto posizioni giuridiche soggettive:
Posizioni di Svantaggio o Passive
- Doveri: imputabili ad una generalità di soggetti previsti per la soddisfazione di un interesse generale (art. 4 Cost .: dovere di svolgere un'attività lavorativa, Art. 30 Cost .: dovere di mantenere i figli, Art. 53 Cost .: dovere di concorrere alle spese pubbliche).
- Obblighi: un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto, cui l'ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretenderne l'osservanza. Es: obbligo di prestare la propria opera nell'ambito di un rapporto di lavoro.
- Oneri: un soggetto può scegliere se tenere un determinato comportamento al fine di ottenere un certo risultato.
Posizioni di Vantaggio o Attive
- Potere giuridico: imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse rilevante proprio o altrui.
- Facoltà: capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti.
- Diritti soggettivi: è un complesso di poteri e di facoltà che l'ordinamento (ovvero
il diritto oggettivo) riconosce al singolo, il quale, in quanto titolare del diritto, può
esercitare la pretesa che gli altri soggetti si astengano dal turbarne il libero
esercizio o adempiano ad un dovere (correlativo) che la legge impone per la
soddisfazione di un suo interesse. Si distinguono in:
- Diritti assoluti -> vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento (diritti fondamentali)
- Diritti relativi -> vincolano solo soggetti determinati (diritti di credito).
- Interessi legittimi: sono quegli interessi individuali che ricevono una tutela indiretta e mediata allorché coincidono con interessi della collettività o di Enti (es .: concorso pubblico);
- Interessi semplici o di fatto: l'interesse di un soggetto non tutelato (ne direttamente, né indirettamente) dall'ordinamento giuridico.
Atto e Fatto Giuridico
Gli atti giuridici sono gli atti derivanti dalla manifestazione della volontà dell'uomo. I fatti giuridici sono i fatti presi in considerazione (nascita e morte).
La Costituzione
Origini del Costituzionalismo Moderno
Alla fine del XVIII secolo, con lo sviluppo del costituzionalismo moderno, si cominciarono ad avere costituzioni scritte. Le prime furono quelle delle colonie inglesi del Nord America, al momento di dichiararsi indipendenti nel 1776. Undici anni dopo venne varata la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Per i cittadini americani la costituzione è un insieme di regole che riflettono un ordine oggettivo che si presenta alla ragione e alla volontà individuale come un dato preesistente.
La prima in Europa fu la Costituzione francese, ma ebbe una durata breve. I sussulti rivoluzionari produssero nuovi testi costituzionali. Per i cittadini francesi la Costituzione è un insieme di regole, capaci di conformare artificialmente l'ordine politico, prodotte dalla ragione e/ o dalla volontà umana, consapevolmente esercitate in un momento storico preciso.
La costituzione italiana è la legge fondamentale dello stato, è entrata in vigore il 1º gennaio 1948 con l'approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, a seguito del referendum monarchia/ repubblica del 2 giugno del 1946.
Occorre rimarcare che attualmente ci troviamo in presenza di un potere costituito, ovvero il potere del Parlamento che è cosa ben diversa dal potere costituente, ovvero quello degli anni