Filosofia del diritto: introduzione, compiti e distinzione diritto-morale
Documento di Università sulla Filosofia del diritto. Il Pdf, un documento, esplora la distinzione tra diritto e morale, i campi socio-normativi e il ruolo di magistrati e avvocati. Questo materiale di Diritto, adatto per l'Università, offre una panoramica completa sulla formazione giuridica.
See more52 Pages

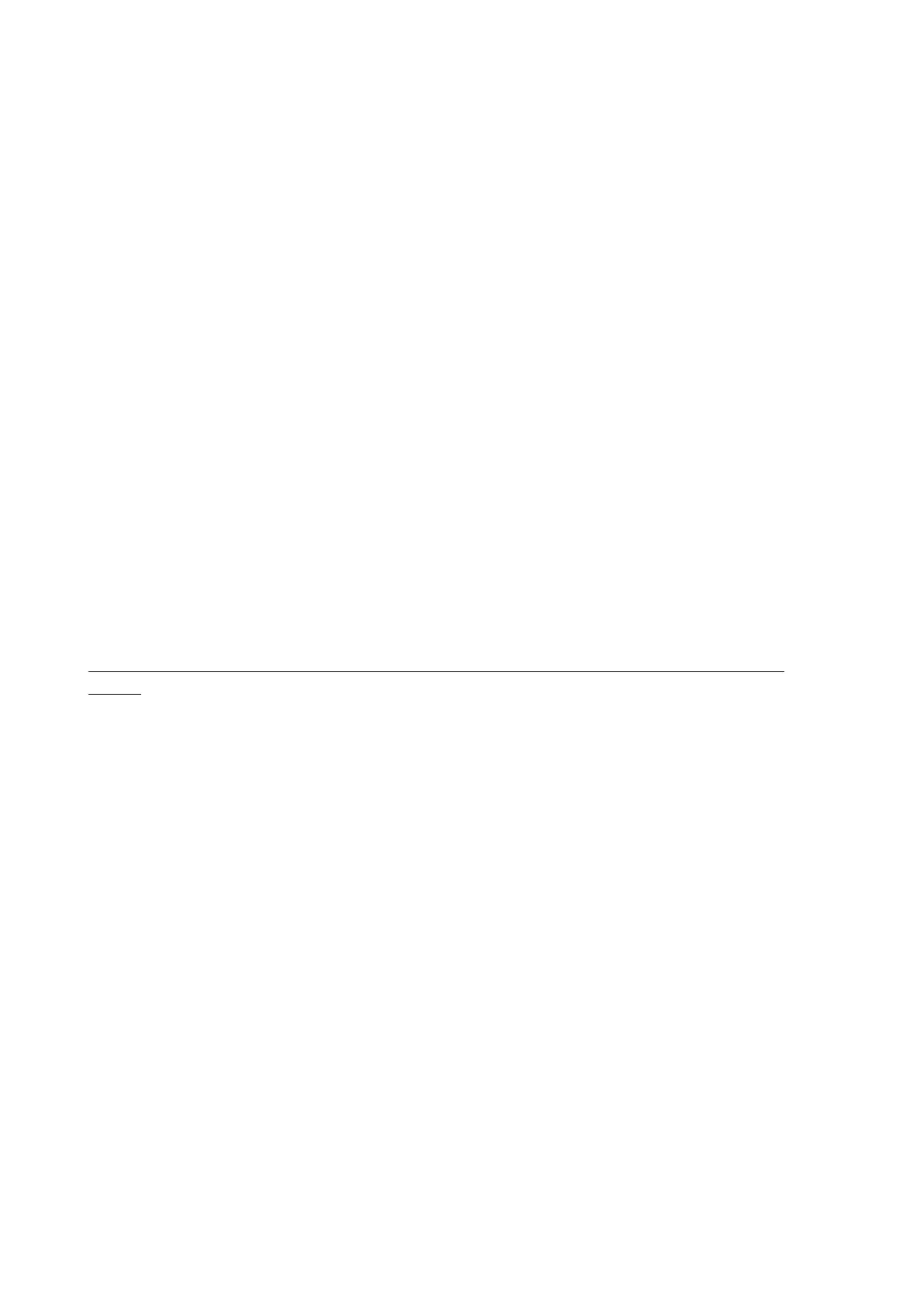
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Introduzione alla Filosofia del Diritto
Che cosa è la "filosofia del diritto"? Quali sono i suoi "compiti"? Quando è nata? La risposta più ovvia alla prima domanda è: la filosofia del diritto è quel settore della filosofia che si occupa di diritto. Ma tale risposta è tautologica, perché rinvia a due nozioni - "filosofia" e "diritto". Riguardo a "diritto" il termine è usato in almeno due significati, cioè come sistema di norme poste in essere da un potere sovrano allo scopo di regolare i rapporti tra cittadini o come insieme di valori superiori a qualsiasi legislazione positiva. Quanto a "filosofia", si potrebbe dire che i significati del termine sono tanti quanti sono i filosofi, lungo una gamma che va da concezioni di essa come sapere globale e totalizzante, fino a concezioni estremamente riduttive che la relegano, tuttalpiù, ad un ruolo metodologico.
Compiti della Filosofia del Diritto
Naturalmente alla filosofia del diritto le sono stati attribuiti "compiti" diversi. Con una fraseologia molto in voga in Italia nella prima metà del secolo scorso, si può parlare di:
- Compito ontologico: volto a indagare ciò che il diritto è;
- Compito fenomenologico: volto ad indagare come il diritto si manifesta nella società;
- Compito deontologico: volto ad indagare come il diritto dovrebbe essere.
Alla luce di tutto ciò è impossibile dare una definizione di "filosofia del diritto": sarebbe infatti assurdo tentare di rispondere alla domanda "che cosa è la filosofia del diritto" combinando insieme definizioni diverse di "filosofia" e di "diritto", come pure sarebbe assurdo fissare i "compiti" della filosofia del diritto. Fare ciò presupporrebbe infatti che ognuno di questi avesse un valore assoluto e non fosse invece rappresentativo di un particolare momento storico.
Origini della Filosofia del Diritto
Resta da rispondere alla terza delle domande: quando è nata la filosofia del diritto? Il termine fu usato per la prima volta nel 1798 da un esponente della scuola storica tedesca, Gustav Hugo, autore dell'opera Lehrbuch des Naturrechts, als einer Philosophie des positiven Rechts [Trattato di diritto naturale, come filosofia del diritto positivo]; fu poi consacrato dall'opera di Wilhelm Friedrich Hegel Grundlinien der Philosophie des Rechts [Lineamenti di filosofia del diritto] del 1821 e nel corso dei primi decenni dell'Ottocento si diffuse in tutta Europa. Se l'origine del termine è relativamente tarda, tuttavia la riflessione filosofica sul diritto nasce molto prima e si può far risalire al pensiero greco. Già Platone distingueva la scienza pratica, che è quella "insita per sua natura nelle azioni", da quella conoscitiva, che è priva di riferimento all'azione. Nelle varie classificazioni citate non si trova in verità mai nominato il diritto, ma perché fino al Settecento non esisteva una categoria specifica dell'agire pratico definita come tale.
Distinzione tra Diritto e Morale
È un illuminista tedesco Christian Thomasius (1655-1728) a distinguere nell'ambito della vita pratica tre forme, che egli definisce:
- iustum (il diritto),
- honestum (la morale),
- decorum (ciò che è opportuno).
Il comportamento giuridico (iustum) si distingue da quello morale (honestum) anzitutto per il carattere intersoggettivo, che comporta il riferimento dell'azione ad almeno due persone. Mentre l'azione morale si riferisce ad un'obbligazione interna che riguarda la coscienza individuale. Immanuel Kant (1724-1804), nella Critica della ragion pratica parte proprio dalla distinzione tra diritto e morale. Principio fondamentale dell'etica kantiana è che è buono solo ciò che non è determinato da impulsi dei sensi o dal calcolo delle conseguenze dell'azione, ma solo dalla necessità di obbedire a un dovere. La legislazione morale è dunque quella che è fine a se stessa, che ordina l'azione solo per la bontà di questa ed è obbedita solo per questo motivo, mentre la legislazione giuridica è quella che ammette un impulso diverso dall'idea del dovere in se stesso. Per distinguere le norme morali da quelle giuridiche non si guarda al contenuto ma al motivo per il quale il soggetto le osserva: la medesima condotta può essere morale o giuridica secondo il motivo che la determina. La legge giuridica si riferisce alle azioni esterne e impone doveri esterni, mentre la legislazione morale, che prende impulso dall'idea di dovere, riguarda le azioni interiori. Da Kant in poi il diritto si consolida come categoria autonoma e nasce quella disciplina particolare che è la filosofia del diritto. Fino al Settecento la storia della riflessione filosofica sul diritto, si identifica con la storia del giusnaturalismo.
Campi Socio-Normativi e Finalità dell'Agire
La pluralità dei campi socio normativi e le finalità dell'agire (lineamenti di sociologia del diritto) Prima di presentare nel prossimo Capitolo una proposta definitoria dei messaggi normativi di tipo giuridico, affrontiamo brevemente la questione dei campi socio-normativi che si affiancano a quello del diritto. È importante sottolineare l'esistenza di questi campi normativi extra-giuridici, in quanto nella percezione del giurista moderno il diritto positivo statuale ha la pretesa di rendersi indipendente dall'intero universo della normatività sociale. Abbiamo utilizzato non casualmente il termine di campi socio-normativi facendo riferimento ad un concetto teorico del sociologo francese Pierre Bourdieu. Secondo questo Autore, "nelle società fortemente differenziate, il cosmo sociale è costituito dall'insieme di questi microcosmi sociali relativamente autonomi, spazi di relazioni oggettive in cui funzionano una logica e una necessità specifiche, non riconducibili a quelle che regolano altri campi. Per esempio, il campo artistico, il campo religioso e il campo economico rispondono a logiche diverse". In questo contesto non si fa riferimento a singoli messaggi classificabili secondo i criteri che abbiamo esposto, ma a complessi socio-normativi tenuti insieme da un elemento teleologico, ovvero dalle finalità dell'agire che essi si prefiggono. Tale criterio ci appare il più appropriato rispetto a molti altri possibili, in quanto ogni campo normativo ruota intorno a finalità che ne strutturano il funzionamento e condizionano il contenuto dei singoli messaggi che di questi insiemi normativi fanno parte. Ognuno di tali campi, infatti, qualifica le azioni secondo significati propri. Secondo questa prospettiva teleologica, possiamo fornirne una classificazione, che peraltro non esaurisce la gamma dei campi possibili.Distingueremo dunque sette campi socio-normativi extra-giuridici con le loro rispettive finalità d'azione così come illustrato nello Schema.
Classificazione dei Campi Socio-Normativi
- Campo della morale Agire secondo giustizia
- Campo delle religioni positive Agire escatologico
- Campo della politica Agire politico
- Campo della tecnologia Agire tecnologico
- Campo dell'economia Agire utilitaristico
- Campo della pubblicità Agire consumistico
- Campo dell'arte Agire espressivo-estetico
Questi campi si collocano a diversi gradi di prossimità con quello giuridico. Il campo dell'etica, ad esempio, appare più vicino al fenomeno giuridico rispetto a quello artistico, in quanto il tema della giustizia da sempre si è confrontato con quello del diritto. Comunque tutti i campi instaurano relazioni e hanno punti di contatto quando li si osserva dal punto di vista di orientare l'agire degli individui e di attribuirgli significato. Il soggetto agente, infatti, fa parte contemporaneamente di una molteplicità di campi che lo orientano nelle sue scelte d'azione. Il campo giuridico della modernità si caratterizza per uno spirito egemonico rispetto agli altri campi, nel senso che concepisce il diritto come il sistema normativo che regola altresì il loro funzionamento. In effetti, il diritto si occupa di regolare anche le attività economiche, quelle artistiche, quelle tecnologiche, ma occorre sottolineare come tali normative non cancellino la relativa autonomia di tali campi socio-normativi. Un artista che compone un brano musicale si informerà e potrà essere influenzato nella sua attività creativa dai diritti che gli spettano in base alla legge che tutela la proprietà intellettuale, ma in primis, in quanto tale, sarà mosso dall'obiettivo di esprimere la sua sensibilità artistica attraverso l'opera musicale.
La Norma e il Messaggio Normativo
La norma e il messaggio normativo (lineamenti di sociologia del diritto) Anche il termine norma possiede vari significati. Riprendendo una definizione di norma di uno dei più importanti teorici del diritto del XX secolo, Hans Kelsen (1881-1973), potremmo dire che la norma è uno schema qualificativo con cui ad un determinato fatto naturale (oggetto, evento o azione) viene assegnato un significato normativo nel senso che a quel fatto naturale: a) viene attribuita una qualificazione e b) vengono previste delle conseguenze in relazione all'ordinamento normativo considerato Qualificare normativamente indica attribuire un significato ad una determinata azione per farne derivare determinate conseguenze. Tali conseguenze, peraltro, non sono fini a se stesse, ma sono stabilite dalla norma allo scopo di orientare la scelta d'azione del soggettoa cui essa si rivolge, in modo tale che egli tenda ad uniformarsi al modello d'azione indicato dalla norma stessa. Bisogna precisare però che le norme, così come le abbiamo ancora approssimativamente definite, sono:
- artefatti cognitivi, ovvero entità artificiali che mediano tra la mente umana e il mondo della realtà fenomenica fornendo schemi interpretativi di tale realtà (attribuzione di significato) e guida per le azioni degli individui che operano in essa (orientamento dell'azione);
- Tali artefatti non vanno concepiti come il prodotto unilaterale del soggetto che li genera, ma come la risultante di un processo di continua negoziazione tra gruppi sociali portatori di valori e interessi diversi e spesso in conflitto tra loro; negoziazione che si manifesta nell'ambito dell'attività interpretativa.
Rispetto al punto b) occorre, infatti, liberarsi dall'idea, che la norma sia un'entità linguistica che precede e sia indipendente dalla sua interpretazione. Essa non è un artefatto cognitivo esistente di per sé stesso che attenderebbe di essere interpretato correttamente per sco- prime il vero significato. La norma quindi non ha un significato, ma è un significato. Quindi di un'interpretazione non si può dire che sia vera o falsa, ma solamente che è quella più praticata da una certa comunità interpretante. Gli artefatti cognitivi costituiti dalle norme hanno necessità, per svolgere la loro funzione di mediazione tra realtà fenomenica e mente umana, di tradursi in atti di comunicazione o messaggi che veicolino un determinato contenuto da un soggetto ad un altro attraverso un processo di interpretazione del messaggio stesso. Per atto di comunicazione si intende un'operazione attraverso la quale un soggetto trasmette ad un altro soggetto un contenuto informativo di qualche tipo. La risultante di questa attività del mettere in comune è propriamente l'interpretazione del messaggio, che peraltro va concepita come un'attività di scambio reciproco tra i due soggetti. In generale gli atti comunicativi possono essere classificati secondo molti criteri diversi; quello che qui ci interessa in prima battuta è il criterio con cui è possibile distinguere quelli che possiamo chiamare normativi. A tal fine, possiamo utilizzare un'acquisizione della teoria generale del diritto che ha affermato come una particolare caratteristica del messaggio normativo sia costituita dalla compresenza al suo interno di un duplice elemento designato coi termini di descrittività e prescrittività. Il messaggio normativo è composto da una parte che descrive una certa azione e di un'altra parte che prevede le conseguenze che verranno collegate al compimento di quell'azione. Il messaggio normativo, in tale prospettiva, svolge una duplice funzione. Da un lato, esso ha lo scopo di orientare le scelte d'azione dei soggetti destinatari, in quanto attraverso la previsione e l'attuazione delle conseguenze previste dal messaggio stesso il destinatario sarà influenzato nell'effettuare le sue scelte d'azione. Dall'altro si potrà attribuire a quella determinata azione un significato o un senso, condiviso e comprensibile nella misura in cui siano condivise e comprese le pratiche interpretative che costruiscono il contenuto del messaggio stesso. Esempio: Per far comprendere meglio che cosa s'intende con questa duplice funzione, facciamo un banale esempio tratto dal gioco degli scacchi. Possiamo considerare tale gioco come un insieme di messaggi normativi che circoscrivono uno spazio sociale in cui due giocatori vengono dotati di una tavola piana suddivisa in 64 caselle quadrate e di 16 figure di