La filosofia di Immanuel Kant: Critica della ragion pura, pratica e del giudizio
Documento di Università su Kant (1724-1804). Il Pdf esplora la filosofia di Immanuel Kant, suddividendola in campi conoscitivo, pratico-morale ed estetico, con un focus sulle sue opere principali e i principi dell'imperativo categorico, utile per Filosofia a livello universitario.
Mostra di più17 pagine
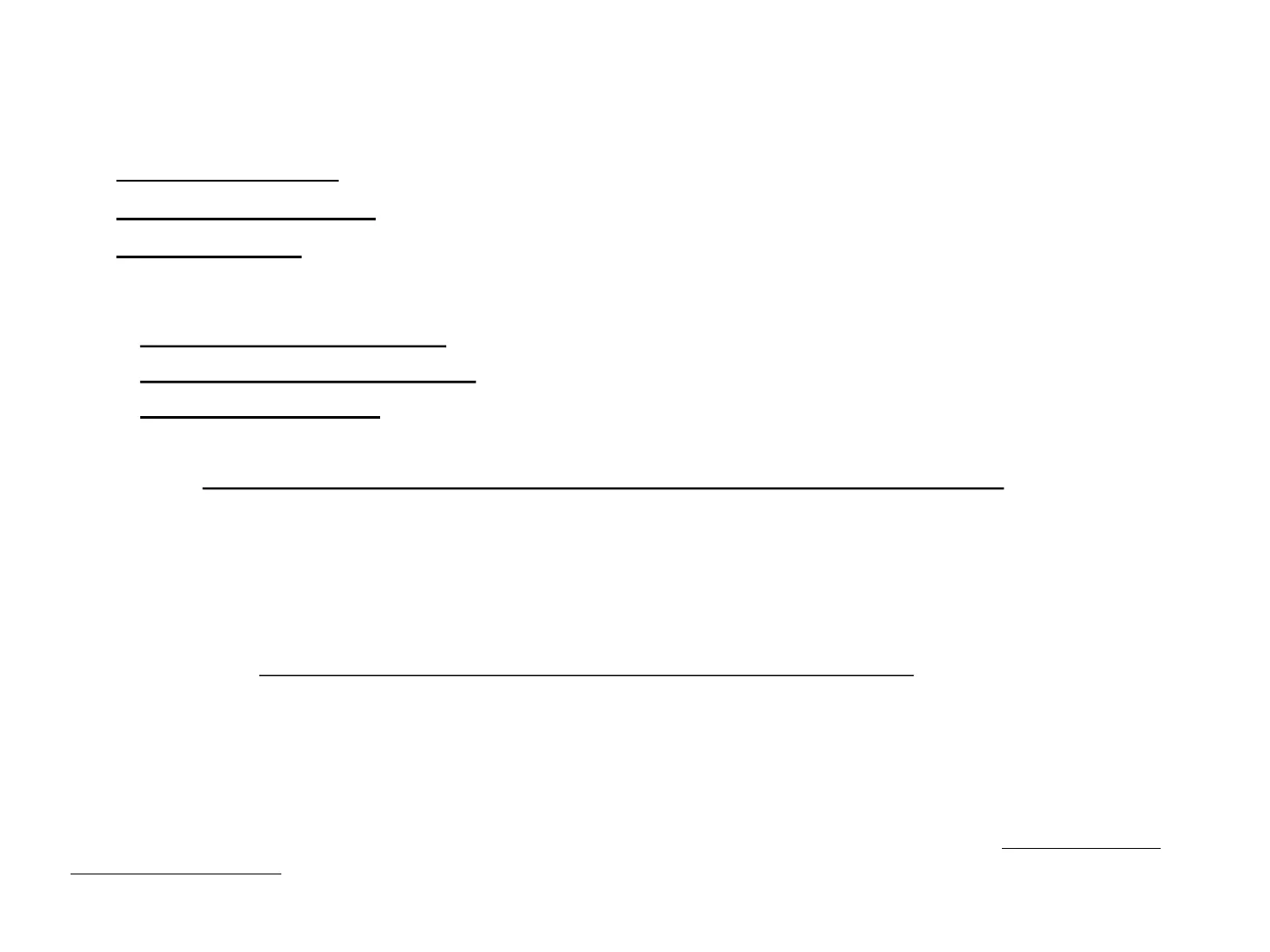
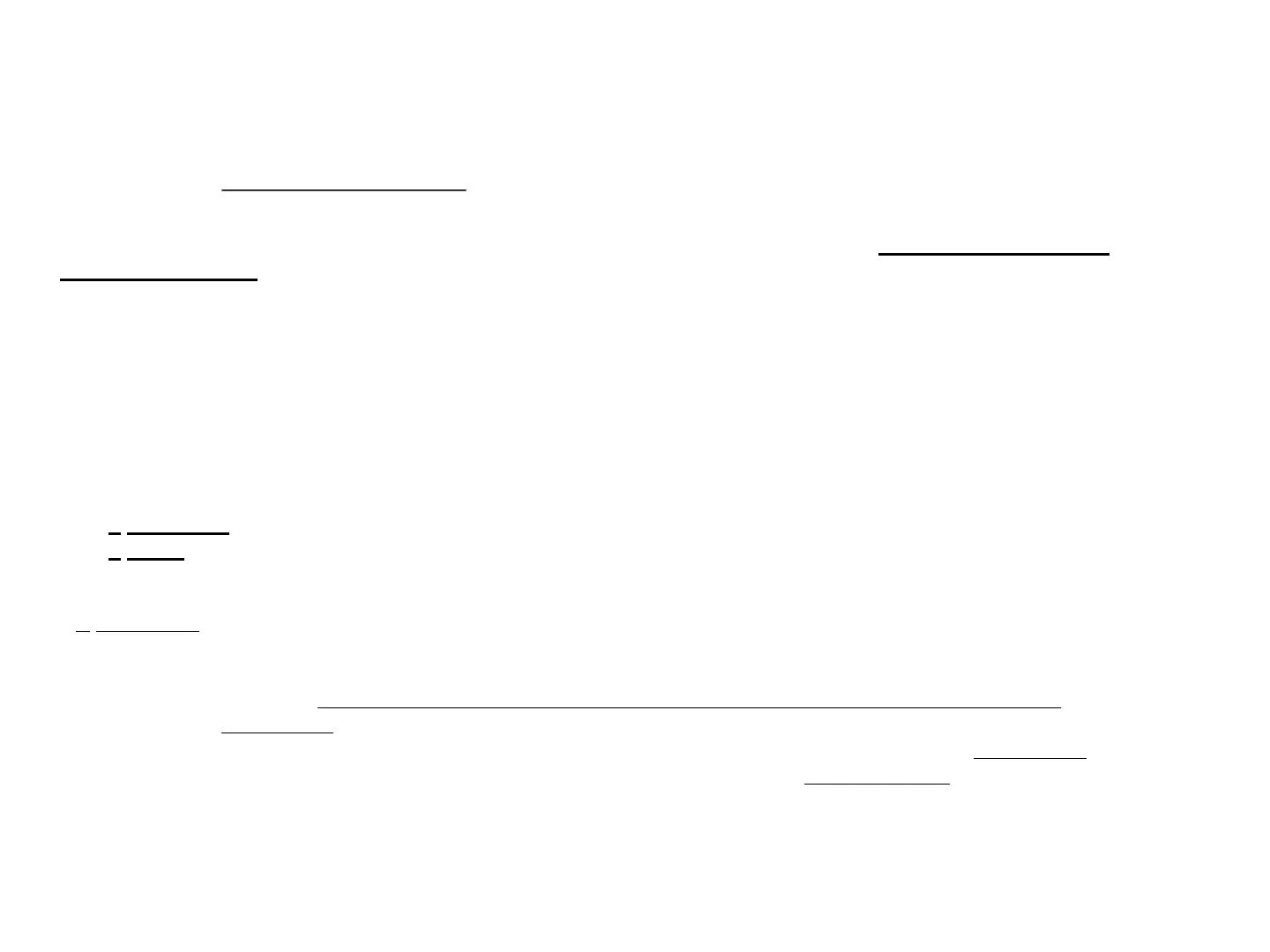
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
KANT (1724-1804)
Kant suddivide la filosofia in tre campi, gli aspetti essenziali della vita di un uomo:
il campo conoscitivo > la conoscenza (gnoseologia)
il campo pratico-morale > il giusto comportamento pratico (la morale)
il campo estetico - il sentimento di bellezza verso le cose (l'estetica)
A questi aspetti Kant dedica tre opere:
- la Critica della ragion pura (1781), che affronta il problema conoscitivo
- la Critica della ragion pratica (1787), che analizza il problema morale
- la Critica del Giudizio (1793), che riflette sul problema estetico
Il punto in comune è dato dal ruolo centrale del soggetto umano
Il pensiero di Kant è detto "criticismo" > atteggiamento critico > "Criticare", per Kant, non significa soltanto
"giudicare, valutare", ma cercare di comprendere quale sia il fondamento della conoscenza, della morale e
dell'estetica.
La Critica della ragion pura (che cosa posso sapere?)
«Critica della ragion pura» significa "analisi della conoscenza, ossia dei modi del
conoscere applicati all'esperienza ma indipendenti da essa".
L'intento di Kant è quello di mettere in luce i motivi della superiorità conoscitiva della scienza e, al tempo stesso, di
ridimensionare le pretese conoscitive del sapere metafisico.
Il tema principale trattato da Kant nella Critica della Ragion Pura cerca di rispondere alla domanda: che cosa posso
davvero conoscere?
1Kant analizza la ragione nella sua forma "pura" (cioè non condizionata dall'esperienza), analizza il modo in cui
essa funziona, i limiti e le possibilità entro cui correttamente opera
La teoria dei giudizi
Gli elementi base della conoscenza scientifica (e di ogni conoscenza) sono costituiti dai "giudizi" > conoscere
vuol dire giudicare
Che cos'è un "giudizio"?
Il termine "giudizio" significa attribuire un predicato (una proprietà) al soggetto di una proposizione, affermare o
negare cioè qualcosa in relazione ad un determinato argomento.
Un giudizio è una proposizione in cui si uniscono due elementi, un Soggetto (A) e un Predicato (B)
Es. La penna (A) è nera (B)
I giudizi possono essere dopo o prima l'esperienza
"a posteriori" (che vengono dopo)
"a priori" (che vengono prima)
Giudizi a posteriori
Per affermare "l'acqua è bollente" o "il caffè è zuccherato", bisogna prima fare l'opportuna esperienza e
formulare poi il giudizio: sono giudizi "a posteriori" che presuppongono appunto l'esperienza. Si
tratta di giudizi "fecondi", cioè dicono qualcosa di nuovo, che prima non era conosciuto (guardando il caffè
io non so se sia zuccherato, dopo, "a posteriori", lo so, e ho aumentato il mio sapere). Sono poi "sintetici",
cioè uniscono cose diverse (il caffè e lo zucchero), ma sono anche giudizi "particolari", non hanno un
valore universale e necessario: valgono infatti solo per quel caffè specifico
2
Giudizi a priori
I giudizi "a priori" sono invece " universali e necessari".
Esempio: "ogni corpo ha una estensione", un tale giudizio non ha bisogno della verifica sensibile quindi è "a
priori", ed è vero sempre e dovunque, quindi è universale e necessario. In nessuna circostanza, infatti, un
corpo non ha un'estensione: la ragione lo sa anche senza esperienza, e pertanto si tratta di giudizi che non
aggiungono nulla di nuovo a quanto è già implicito nel soggetto del predicato.
Tradizionalmente, esistono due categorie di giudizi:
> giudizi sintetici
> giudizi analitici
- I giudizi sintetici (a posteriori)
Un giudizio è sintetico (sintetico significa che fa sintesi, che unisce) quando il predicato aggiunge al soggetto
qualcosa di nuovo, che non è già implicito al soggetto medesimo.
Il giudizio sintetico è "a posteriori", ossia deriva dall'esperienza ed è basato su di essa. Derivando da esperienze
sempre nuove, il giudizio sintetico aumenta la conoscenza, però non è né universale né necessario, perché
non si può fare esperienza di tutto ed essere sicuri che le esperienze saranno necessariamente sempre
uguali in ogni caso, ora e nel futuro. - I giudizi analitici (a priori)
Si ha un giudizio analitico (che opera un'analisi di tipo logico) quando il predicato è compreso nel soggetto.
Il giudizio analitico è basato sul principio di identità: A=A (ossia il soggetto e il suo predicato hanno il medesimo
significato) e sul principio di non contraddizione (cioè è impossibile che una stessa cosa possa essere
contemporaneamente uguale a se stessa e diversa da se stessa).
Il giudizio analitico è "a priori", è cioè indipendente dall'esperienza, poiché basato unicamente su principi e regole
logiche.
Pertanto il giudizio analitico è sempre universale e necessario:
❖
universale = valido per tutti in ogni tempo e in ogni luogo
❖
necessario = non può che essere così in ogni caso
però non aggiunge niente di nuovo a quanto già sappiamo.
3Per essere autentica, dice Kant, la conoscenza scientifica deve basarsi su giudizi universali e necessarie ma
collegati anche all'esperienza, perché solo la possibilità di fare sempre nuove esperienze può incrementare
la conoscenza.
Di quali giudizi si avvale allora la scienza?
QI giudizi sintetici a priori
Sul giudizio sintetico è basato l'empirismo, per il quale le conoscenze sono solo posteriori.
Sul giudizio analitico è invece basato in particolare il razionalismo, che ritiene possibile una conoscenza a
priori.
È chiaro allora che la vera scienza non può basarsi ne su giudizi analitici ne sintetici, bensì su
"giudizi sintetici a priori", che siano cioè universali e necessari ma anche capaci di
incrementare la conoscenza per effetto dell'accumularsi delle esperienze.
Ma, si chiede Kant, come sono possibili i giudizi sintetici a priori?
Kant risponde a questa domanda attraverso quella che è stata definita "la rivoluzione copernicana di Kant nel
campo della gnoseologia".
La rivoluzione copernicana di Kant e la distinzione tra fenomeno e noumeno
Kant scopre che la conoscenza funziona in questo modo:
non è il soggetto che deve adeguarsi all'oggetto (che deve cioè far corrispondere le sue percezioni alle presunte
proprietà e caratteristiche dell'oggetto) ma è l'oggetto che viene regolato, organizzato e dunque conosciuto dal
soggetto
4Così come in astronomia Copernico aveva rovesciato la posizione della Terra e del Sole,
ponendo il Sole al centro dell'universo e non più la Terra, altrettanto, nella gnoseologia
Kant inverte il ruolo fra oggetto e soggetto: la conoscenza non si basa sulle effettive proprietà e caratteristiche
dell'oggetto che si vuol conoscere, ma deriva dai modi/meccanismi in cui il soggetto (ora posto al centro) organizza e
interpreta i dati sensibili
Secondo Kant, queste modalità di funzionamento sono proprie della ragione, connaturate ad essa, e le definisce
"forme pure a priori universal", che non dipendono dall'esperienza e che tutti gli uomini possiedono.
Si tratta però di "forme" (cioè "modalità" di funzionamento) che noi riempiamo con l'esperienza, la quale ci fornisce
dunque la "materia" della nostra conoscenza.
Kant afferma quindi che la conoscenza è formata da materia e forma.
'materia" è costituita da tutte le impressioni sensibili che derivano dall'esperienza
"forma" è l'insieme delle modalità fisse attraverso cui la mente umana ordina tali impressioni
NB. Per comprendere quanto detto, si possono fare tre esempi.
Esempio 1. Pensa di vedere il mondo, fin dalla nascita, attraverso un paio di occhiali con le lenti rosse. Tu
vedrai il mondo (esperienza), ma lo vedrai rosso, perché i tuoi occhiali (le forme della ragione) sono fatti così.
Esempio 2. Immagina la mente umana come una grande stanza con diverse librerie vuote. Successivamente
queste librerie vengono riempite di libri (esperienza), ma i libri verranno collocati secondo un certo ordine nei
vari scaffali già pronti (le forme della ragione).
Esempio 3. Si può anche paragonare la ragione ad un bicchiere in cui viene versata dell'acqua: il liquido
viene da fuori (esperienza), ma in un certo senso è costretto ad assumere la "forma" del bicchiere (le forme
della ragione).
La mente è dunque attiva (non è un semplice specchio che riflette l'oggetto così com'è), in
quanto "modella" la realtà (l'esperienza) attraverso le forme a priori della ragione
5Kant introduce la fondamentale distinzione tra fenomeno e noumeno.
Fenomeno
Il fenomeno (ciò che è percepibile dai sensi) è la realtà derivata dal mondo esterno sensibile, che si mostra a noi
attraverso le forme a priori: quindi, tutto ciò di cui facciamo esperienza nel mondo è "fenomeno". Per questa
ragione i fenomeni sono apparenze soggettive, dipendono cioè in parte dalle forme di conoscenza del soggetto. Le
forme a priori sono infatti il modo in cui noi percepiamo, ordiniamo, modelliamo e conosciamo le informazioni (i
fenomeni) che ci arrivano dal mondo.
Noumeno
Il noumeno (ciò che è pensato dal puro intelletto), invece, è la cosa in sé, cioè l'essenza dei fenomeni, ciò che le
cose veramente sono, indipendentemente dal modo in cui vengono percepite dal soggetto. Il "noumeno" può
essere solo pensato ma non conosciuto, proprio perché del noumeno non si può fare esperienza.
La tripartizione della Critica della ragion pura
La conoscenza, per Kant, è possibile a partire da tre facoltà mentali, a cui corrispondono le tre parti in cui è divisa
la Critica della ragion pura :
- 1. Sensibilità ( Estetica trascendentale, che studia i modi, cioè le forme della conoscenza sensibile).
/2. Intelletto (Analitica trascendentale, che studia i modi, cioè le forme della conoscenza intellettiva).
v3. Ragione (Dialettica trascendentale, che studia le idee della ragione in senso metafisico).
Kant chiama i modi di funzionare della sensibilità (delle nostre sensazioni) e dell'intelletto "forme pure" o "forme
a priori", (indipendenti dall'esperienza), poiché vi sono tre tipi di conoscenza, ossia:
la conoscenza sensibile (le sensazioni)
la conoscenza intellettiva (quella che avviene mediante l'intelletto)
la conoscenza tramite la ragione
Egli distingue tra:
1) forme della sensibilità - 2) forme dell'intelletto - 3) idee della ragione
6
L'Estetica trascendentale
Il termine "estetica" va interpretato in senso etimologico, da "aisthesis", che nella lingua greca significa
sensazione, sulla quale si fonda per l'appunto la conoscenza sensibile.
Estetica trascendentale significa quindi "teoria che tratta delle forme trascendentali della conoscenza sensibile",
ossia dei modi a priori (indipendenti dall'esperienza) di funzionare della conoscenza sensibile.
La nostra sensibilità (cioè la capacità di ricevere i fenomeni tramite i sensi), dice kant, non è qualcosa di passivo,
poiché è proprio il nostro "cervello" che organizza i dati fenomenici grazie alle due forme a priori della
sensibilità, chiamate da Kant anche "intuizioni pure che sono
1) SPAZIO
2) TEMPO
Ogni conoscenza sensibile avviene nello spazio e nel tempo. Infatti non è possibile avere alcuna
sensazione, cioè fare esperienza di qualcosa che non sia immediatamente collocata in un dato spazio e
in un dato tempo
Non sono gli oggetti che stanno in un certo spazio e in un certo tempo, ma siamo noi che li collochiamo nello spazio
e nel tempo, perché spazio e tempo sono la prima "forma" con cui percepiamo e facciamo esperienza degli oggetti
in quanto fenomeni. Spazio e tempo dunque sono modi di funzionare della nostra sensibilità, universalmente
presenti e uguali in tutti gli uomini.
E poiché, conclude Kant, la geometria si fonda sull'intuizione pura dello spazio (gli enti geometrici hanno dimensioni
spaziali) e l'aritmetica si fonda sull'intuizione pura del tempo (sommare, moltiplicare, sottrarre, dividere sono
operazioni che si distribuiscono sempre nel tempo), ciò significa che geometria e aritmetica sono senz'altro valide
come scienze.
7