La filosofia di Kant, il Positivismo e l'Esistenzialismo all'Università
Documento di Appunti sulla filosofia di Kant, il Positivismo e l'Esistenzialismo. Il Pdf esplora l'idealismo trascendentale, la Critica della Ragion Pura e la Rivoluzione Copernicana, per poi introdurre il Positivismo e accennare all'esistenzialismo con Kierkegaard e Heidegger, utile per lo studio universitario di Filosofia.
Mostra di più34 pagine
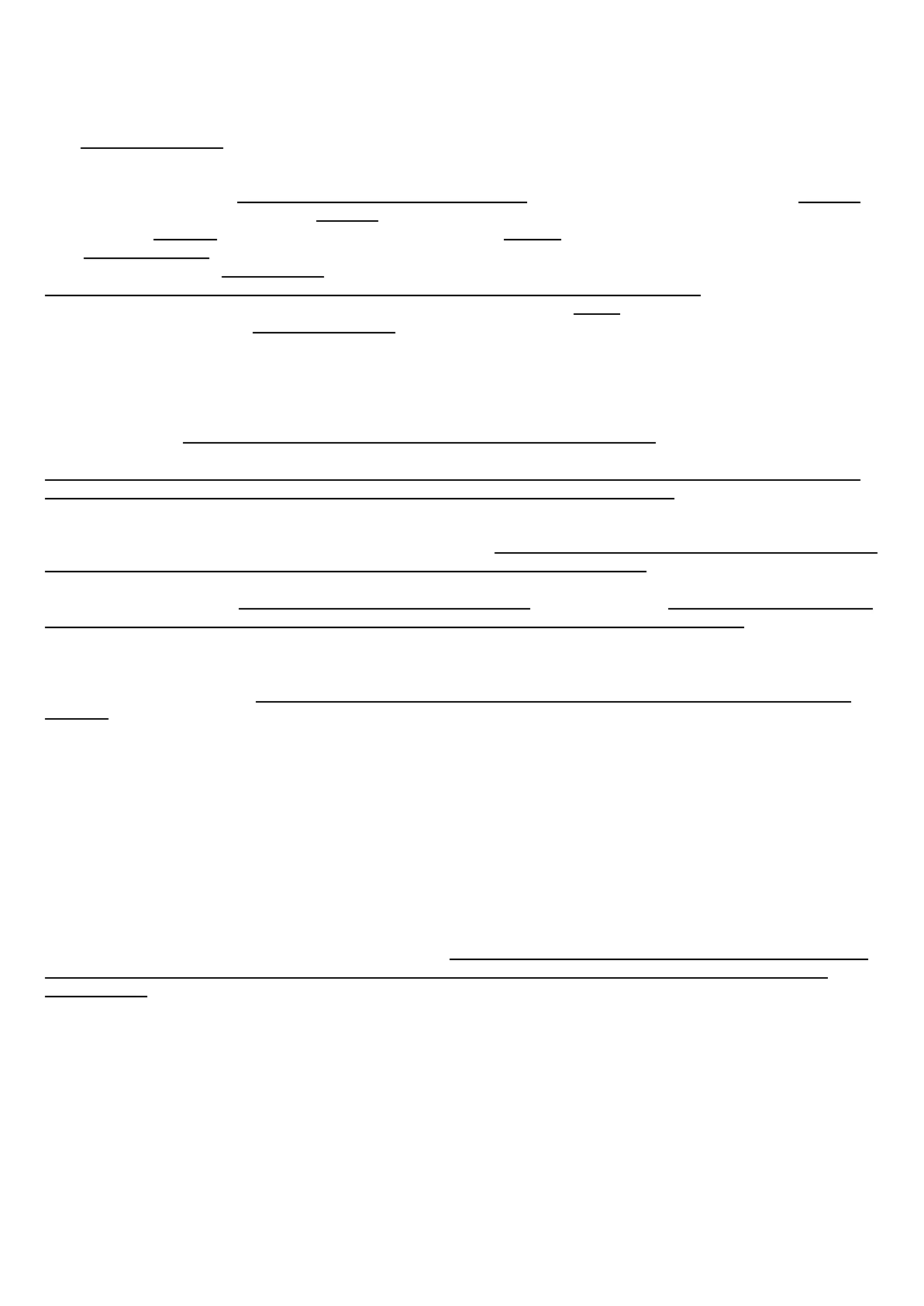
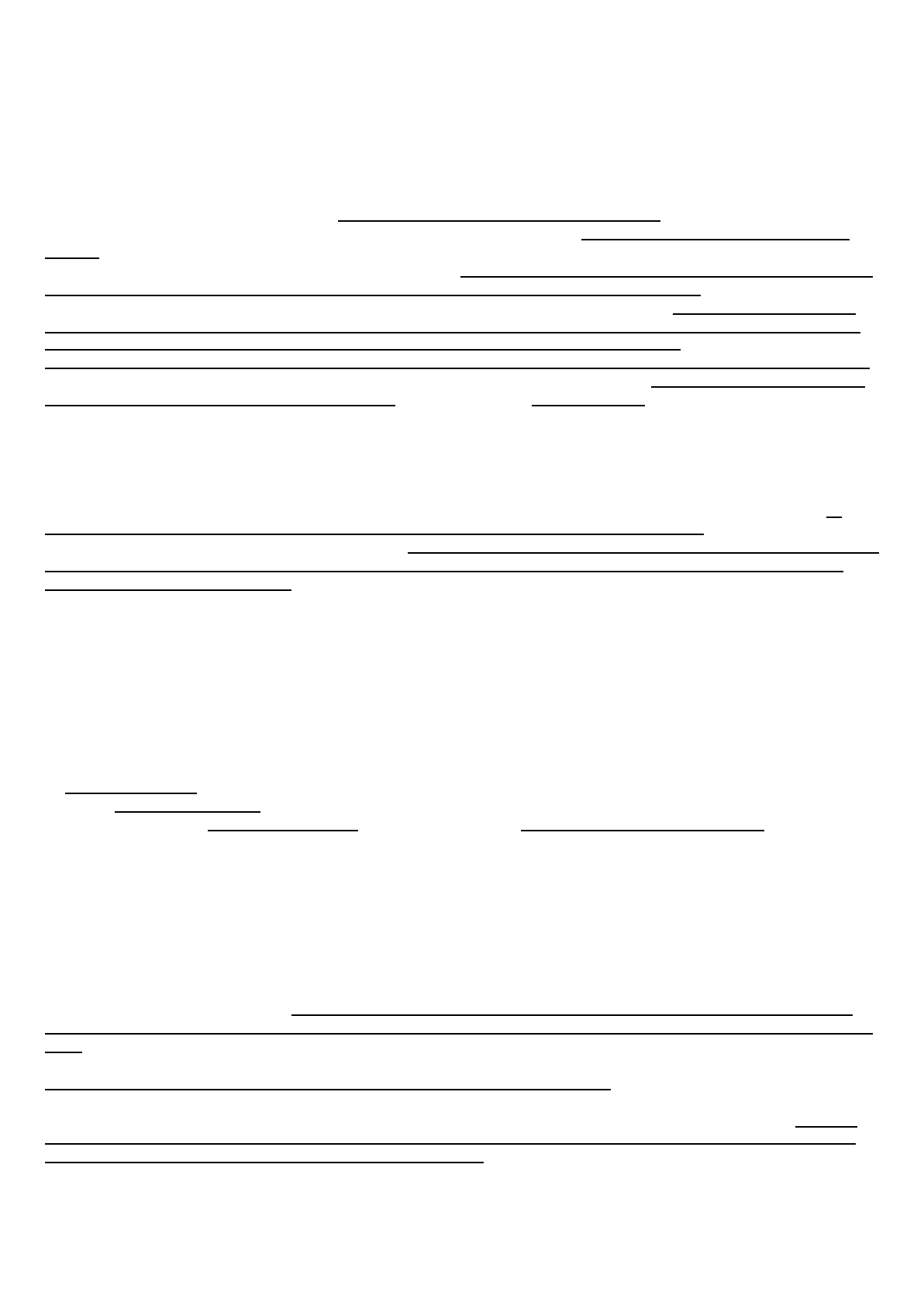
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Idealismo e Conoscenza a Priori
Idealismo: far dipendere le strutture a priori della conoscenza dal soggetto, perché la materia è sempre data dal soggetto. Individuati gli a priori, applicati al materiale empirico permettono di conoscerlo senza passare dall'esperienza. Gli a priori Far dipendere le forme a priori dal soggetto e non i contenuti che dipendono dall'esperienza.
Dissertazione e Differenza tra Conoscenza Sensibile e Intelligibile
Nella Dissertazione del 1770, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (La forma e i principi del mondo sensibile e intelligibile), presentata in occasione della nomina a docente ordinario di logica e metafisica presso l'università di Konigsberg, è presente la prima formulazione critica del pensiero kantiano. Kant parte dalla distinzione tra conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile. La conoscenza sensibile che si basa sulla sensibilità come facoltà di riferimento ha per oggetto il fenomeno, cioè ciò che si manifesta alla conoscenza sensibile. La conoscenza intelligibile ha per oggetto la cosa in sé che per la sua essenza intelligibile si chiama "noumeno". La conoscenza sensibile coglie gli aspetti della realtà così come appaiono ("uti apparent") cioè come fenomeni, mentre la conoscenza intelligibile coglie gli aspetti della realtà non conoscibili mediante i sensi, così come sono ("uti sunt") nel loro ordine intelligibile. Tale distinzione è fondamentale perché il fenomeno, dal momento che rientra nelle condizioni spazio-temporali dell'esperienza è conoscibile, al contrario il noumeno è "un concetto limite", è al di là di ogni esperienza possibile. La conoscenza sensibile è passiva poiché il soggetto subisce continue affezioni (modificazioni) ed è una conoscenza immediata, pertanto come tutte le conoscenze immediate avviene attraverso lo spazio e il tempo che Kant definisce chiama "intuizioni pure".
Critica della Ragion Pura 1781
Nel 1781 Kant pubblica la "Critica della ragion pura". "Criticare" nel linguaggio di Kant è un atto di intelligenza e significa vagliare, soppesare, giudicare, passare in rassegna le condizioni di possibilità e i limiti del conoscere umano. Per tale ragione il suo pensiero filosofico è anche detto "criticismo". La prima Critica è un'opera decisamente illuminista di taglio teoretico che si propone di individuare le forme a priori che permettono al soggetto di conoscere autenticamente la realtà e di identificare sul piano del pensiero quelle strutture che giustificano la fisica newtoniana e prendono le distanze dallo scetticismo hiumiano. La Critica della ragion pura analizza criticamente i fondamenti del sapere, da un lato prendendo le distanze dallo scetticismo scientifico hiumiano (che metteva in discussione il principio di causalità e i nessi causa-effetto), ritenendo il valore della scienza un fatto ormai acquisito di cui non si possa dubitare, ma dall'altro condividendo con Hume lo scetticismo metafisico, sostenendo tuttavia che se la metafisica è chimerica. lo sforzo dell'uomo, il perenne anelito, verso la metafisica è reale e dunque deve poter essere giustificato. L'analisi di Kant e pura perché non "contaminata" dai contenuti dell'esperienza ed è trascendentale perché non riguarda l'oggetto del conoscere, ma le condizioni di possibilità della conoscenza stessa, in quanto è possibile attuare la sintesi a priori. Il pensiero filosofico di Kant è anche detto idealismo trascendentale, perché la realtà dipende dal pensiero e le strutture a priori dipendono dalle idee del soggetto. Dal soggetto dipendono le forme e non i contenuti.
Fondamento della Scientificità della Matematica e della Fisica
Kant si propone di individuare il fondamento della scientificità della matematica e della fisica per verificare se esso fondi anche la metafisica. Da un lato il pensiero kantiano quindi si interrogherà su come siano possibili la matematica e la fisica in quanto scienze, dall'altro si chiederà se sia possibile fare della disciplina filosofica chiamata metafisica una scienza. Il pensiero filosofico di Kant è anche detto filosofia del limite perché Kant porta la ragione davanti al tribunale di se stessa per identificare quali ambiti possono essere conosciuti dalla razionalità umana e quali invece le rimarranno strutturalmente preclusi. L'impossibilità, il limite, della conoscenza di trascendere l'esperienza (di uscire dalle condizioni spazio-temporali dell'esperienza) costituisce la base su cui si fonda la conoscenza stessa.
Rivoluzione Copernicana
Nel ridefinire le modalità conoscitive, in un passo della Critica della ragion pura, Kant scrive "Noi tanto conosciamo a priori delle cose, quanto noi poniamo in esse". Questa nuova impostazione del problema della conoscenza comporrà un'importante conseguenza, la cosiddetta "Rivoluzione Copernicana". Proprio come Copernico nello spiegare il moto dei corpi celesti aveva dimostrato che non è il Sole a ruotare attorno alla terra, ma il contrario, allo stesso modo Kant afferma non sarà più il soggetto a doversi adeguare all'oggetto per poterlo conoscere. ma sarà l'oggetto a modellarsi sulle forme razionali a priori del soggetto per poter essere conosciuto dal soggetto stesso. Nell'estetica trascendentale che costituisce insieme alla logica trascendentale la Dottrina degli Elementi nella Critica della ragion pura, studia la sensibilità e le forme a priori della sensibilità, lo spazio e il tempo, dimostrando come su di esse si fondi la matematica. Il termine estetica non viene usato da Kant nel suo significato consueto di riflessione sulla natura e sul valore della bellezza, ma nel suo significato etimologico (aístetis) di "dottrina della sensibilità".
Dottrina dei Giudizi
Kant parte dall'analisi di tutti i giudizi possibili e li racchiude in tre specie di giudizi: i giudizi sintetici a posteriori, analitici a priori e sintetici a priori. Egli si propone di trovare quella specie di giudizi che possieda contemporaneamente i caratteri di oggettività enovità che sono propri della scienza. La scienza deve essere valida per tutti necessariamente, quindi oggettiva, e deve essere sempre scoperta del nuovo e mai ripetizione, quindi nuova. I giudizi sintetici a posteriori possiedono il carattere della novità, ma non il carattere dell'oggettività. Il predicato aggiunge qualcosa al soggetto, ma tali giudizi derivano dall'esperienza e pertanto non sono oggettivi ("i corpi sono pesanti"). I giudizi analitici a priori possiedono il carattere dell'oggettività, ma non il carattere della novità, in quanto il concetto espresso dal predicato è già contenuto dal concetto espresso dal soggetto ("i corpi sono estesi"). I giudizi sintetici a priori invece possiedono sia il carattere dell'oggettività, sia il carattere della novità. Sono sia estensivi, perché ampliano la conoscenza, sia oggettivi, perché a priori e dunque non derivano dalla conoscenza. I giudizi sintetici a priori dunque costituiscono il fondamento della conoscenza scientifica e sono tutti i principi della matematica, della geometria e della fisica generale ("la retta è la via più breve che intercorre tra due punti"). Ma se tali giudizi non derivano dall'esperienza, Kant si chiede da dove derivino la loro giustificabilità. Per rispondere a tale quesito elabora una nuova teoria della conoscenza intesa come sintesi di materia e forma. La materia della conoscenza è l'esperienza sensibile, l'insieme dei fenomeni che si manifestano alla conoscenza sensibile, l'insieme delle impressioni sensibili che derivano dall'esperienza. La forma della conoscenza è l'elemento razionale. La forma sono le strutture a priori della conoscenza, spazio, tempo e categorie, che sono innate poiché non derivano dall'esperienza e sono comuni a tutti i soggetti pensanti. Lo spazio, il tempo e le dodici categorie sono le modalità attraverso cui la mente umana percepisce, ordina e pensa la realtà. La mente raccoglie e ordina il materiale empirico attraverso le forme a priori della sensibilità, lo spazio e il tempo, intesi come raccoglitori delle esperienze sensibili che il soggetto subisce passivamente, che viene pensato dalle forme a priori dell'intelletto, le categorie. In virtù di queste forme a priori, possono essere enunciati i giudizi sintetici a priori senza che possano essere smentiti dall'esperienza. dal momento che l'esperienza non può essere percepita se non mediante le forme a priori stesse. Il fondamento dei giudizi sintetici a priori è quindi il soggetto con le sue leggi della sensibilità (lo spazio e il tempo) e del suo intelletto (le categorie). È possibile quindi attribuire a priori alle cose i caratteri dello spazio e del tempo certi che Ii possiederanno, in quanto il fenomeno, dal momento che rientra nelle condizioni spazio-temporali dell'esperienza, deve necessariamente possedere le caratteristiche spazio temporali. Kant ci parla dello spazio e del tempo nell'estetica trascendentale. Lo spazio e il tempo sono le forme a priori della sensibilità e sono "intuizioni pure", intuizioni per il loro carattere di immediatezza, pure perche trascendentali, dal momento che non riguardano l'oggetto del conoscere, ma le modalità conoscitive del soggetto che possiede in modo innato gli a priori. Lo spazio è la forma a priori dell'intuizione sensibile che esprime l'ordine della coesistenza delle cose esterne. La geometria si avvale dello spazio che registra i rapporti di contiguità tra le cose. Il tempo è la forma a priori dell'intuizione sensibile che esprime l'ordine della successione dei nostri stati d'animo e ha un primato ideale sullo spazio, perché è solo mediante il tempo cioè il senso interno che giungono a noi i dati del senso esterno. L'aritmetica si avvale del tempo perché contare significa presupporre un'intuizione pura temporale che ci consenta di farlo. Ogni rappresentazione in noi presuppone una sintesi in noi. Al di là di queste due modalità dell'intuizione sensibile non ve ne sono altre in sede di estetica trascendentale. Il soggetto applica lo spazio e il tempo senza dover passare per l'esperienza, in quanto è possibile farlo a priori. Kant vuole dunque capire come avvenga la conoscenza e lavora sui trascendentali, sulle strutture a priori innate che permettono al soggetto di conoscere autenticamente la realtà.
Logica Trascendentale
La logica trascendentale, che costituisce insieme all'estetica trascendentale la Dottrina degli Elementi nella Critica della Ragion Pura, si divide in analitica trascendentale che studia l'intelletto e le forme a priori dell'intelletto, le dodici categorie, dimostrando come su di esse si fondi la fisica, e in dialettica trascendentale che studia la ragione e le idee della ragione, anima, mondo e Dio, dimostrando come su di esse si fondi la metafisica.
Analitica Trascendentale
Nell'analitica trascendentale Kant affronta il problema della fisica. Egli deve giustificare la pretesa su cui si fonda la fisica, cioè il nesso causa-effetto. Se non giustificasse tale pretesa la fisica cadrebbe sotto la critica di Hume. I fenomeni non sono legati tra loro soltanto da rapporti di contiguità (spazio) e successione (tempo), ma anche da nessi causali. I rapporti causa-effetto non sono percepiti intuitivamente, ma sono pensati dal nostro intelletto. Se prima era evidente che i fenomeni dovessero adeguarsi al nostro modo di recepirli (cioè entrare nelle condizioni spazio-temporali dell'esperienza), ora non è altrettanto evidente perché debbano adeguarsi al nostro modo di pensarli. In altre parole, se per Kant è stato "facile" spiegare perché recepiamo il materiale sensibile tutti allo stesso modo, adesso non è altrettanto facile giustificare il motivo per cui pensiamo tutti allo stesso modo, dal momento che pensare è un atto attivo. La soluzione kantiana parte dal presupposto che non siamo i creatori del materiale empirico. Non possediamo un'intuizione intellettuale propria di una mente divina che conosce le cose nell'atto in cui le crea, ma ci limitiamo ad ordinare il materiale sensibile che non siamo stati noi a creare. Il nostro pensiero deriva da due facoltà conoscitive, una recettiva, la sensibilità, e una attiva, l'intelletto. L'intelletto non può agire direttamente sul materiale empirico, ordinato dalle forme a priori della sensibilità, perché non ne è il creatore, ma può condizionarlo attraverso le categorie che hanno una validità universale (ricordiamo solo sostanzialità e causalità).