Il modello islamico: diritto musulmano, shari'a e diritto penale
Documento dall'Università degli Studi di Firenze sul modello islamico, diritto musulmano, shari'a e diritto penale. Il Pdf, utile per la preparazione di esami universitari di Diritto, analizza i contratti islamici, i reati e le relative sanzioni, offrendo una panoramica completa e dettagliata.
See more66 Pages
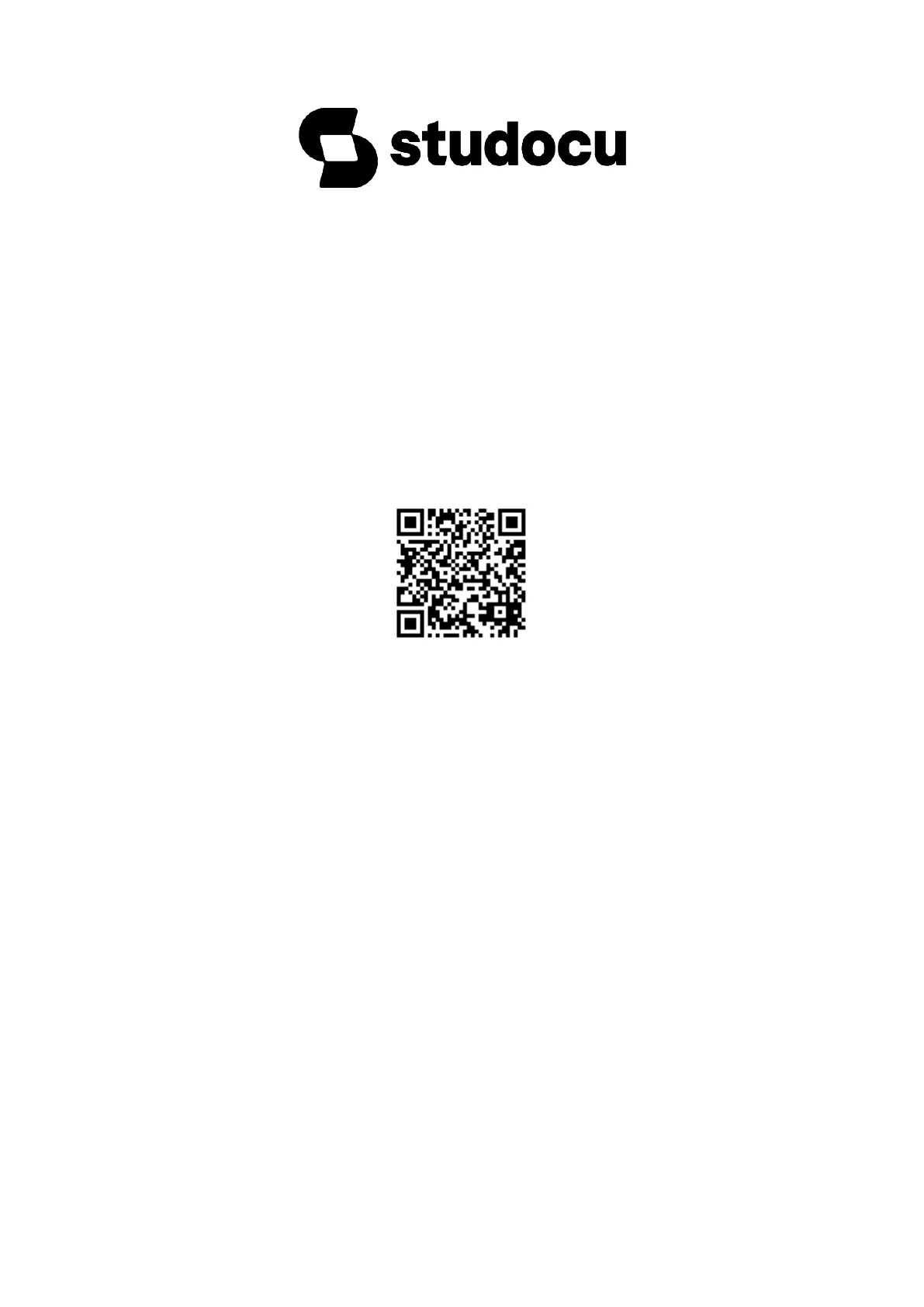

Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
IL MODELLO ISLAMICO
PARTE PRIMA: IL DIRITTO MUSULMANO
CAPITOLO PRIMO: LA SHARI'A, IL FIQH E LE FONTI DEL DIRITTO
L'espressione "diritto mussulmano" o "diritto islamico" può essere adoperato in 3 diverse accezioni:
a) Come traduzione dell'arabo fiqh, che riguarda quella parte della legge religiosa (la shari'a) che regola l'attività esterna del credente verso Dio, verso sé stesso e verso gli altri. Il fiqh (che dovrebbe equivalere al nostro "diritto") comprende sia le regole del rituale religioso e i precetti morali, ma rimangono escluse la dottrina dello Stato e l'amministrazione della cosa pubblica b) Come estratto, fatto dagli studiosi americani e europei, di quelle parti del fiqh che sono "veramente" giuridiche, arricchite di quelle parti del diritto pubblico che sono estranee al fiqh e che i giuristi musulmani chiamano siyàsa shar'iyya c) Come il diritto vigente presso i musulmani di una data regione e comprendente non solo di quelle parti del fiqh classico non cadute in desuetudine, ma anche il diritto locale consuetudinario non necessariamente legato con l'islamismo
Il diritto musulmano nasce e si afferma con la nascita e l'affermazione dell'islam, termine che indica la religione monoteistica fondata da Muhammad (morto nel 632 d.C.), ma anche il sistema politico, sociale e culturale che a essa si riconnette. La ripartizione dell'islàm in sistema religioso, sistema politico e sistema giuridico è un adattamento, secondo criteri laico-occidentali, di una realtà che dal punto di vista interno si presenta come unitaria: l'islam è un unicum dogmatico, morale, rituale, giuridico in cui non ha alcun senso distinguere la sfera giuridica da quella morale, perché entrambe trovano le proprie fonti nella shari'a.
Nell'islàm, pur essendo presenti molti precetti positivi estremamente minuziosi tutte le manifestazioni della vita del credente, non è presente un clero gerarchicamente organizzato e composto di soggetti investiti di particolari caratteri sacramentali, al cui vertice si collochi un capo e autorità docente in tema di dogma, rito e diritto.
Muhamman non istituì sacramenti, sacerdoti e ministri del culto: alle pratiche cultuali ogni musulmano attende direttamente non appena le abbia apprese; allo stesso modo, nelle cerimonie comuni, come la preghiera pubblica del venerdì, ogni musulmano esperto può presiedere al rito. La moschea, il luogo del culto comune, ha carattere sacro solo nei confronti degli infedeli: i musulmani possono utilizzarla anche per scopi profani (ma non indecorosi), come luogo di rifugio o di riunione.
Quello che, invece, è chiamato "clero musulmano" è l'insieme degli addetti alle funzioni della moschea, dei quali può far parte qualsiasi musulmano sufficientemente preparato, senza che sia necessaria alcuna investitura od ordinazione sacerdotale.
Alla salvaguardia del dogma, del rito e del diritto, alle decisioni in merito alla legittimità o illegittimità di nuove idee e teorie sono destinati i dottori della legge (ulamà o fuqahà'), i quali godono di autorità puramente morale e beneficiano solo della reputazione nella loro scienza.
Secondo l'islam, tutti i diritti si riferiscono a Dio, da questa constatazione discende la distinzione elaborata dai fuqahà tra:
- Haqq Allah (diritto di Dio), cioè il diritto cogente relativo all'autorità pubblica
- Haqq àdamì o al-'ibàd nel senso di diritto dell'uomo (o della creatura rispetto a Dio Creatore), cioè il diritto dispositivo riguardante l'interesse privato
Alcuni fuqahà' aggiungono a queste due categorie intermedie a seconda del prevalente interesse, divino- pubblico o umano-privato al quale si riferiscono.
L'esercizio dei diritti soggettivi (huquq) ha per il musulmano limiti oggettivi posti da Dio e soggettivi di varia natura, la cui trasgressione senza utilità propria costituisce una sorta di abuso di diritto. Sulla natura e estensione di tale abuso, c'è tra i fugahà divergenza d'opinione, nel senso che per alcuni le azioni vanno giudicate secondo le intenzioni, mentre per altri prevale il principio che chi fa uso del proprio diritto non reca danno altrui.
Il concetto generale di obbligo religioso è espresso dai fuqahà con la formula wugùb 'alayhi. Wugùb è il primo degli atti ricadenti nella quintuplice ripartizione sciaraitica (al-ahkàm al-khamsa) che il mukallaf, cioè il musulmano pubere tenuto all'adempimento degli obblighi giuridico-religiosi, deve compiere, in caso di inosservanza vi è sanzione a carico di coloro che non adempiono. Tale atto è opposto a quello che si ha l'obbligo di non compiere (haram), mentre nessun obbligo esiste rispetto alle altre tre categorie di atti (consigliato, sconsigliato, libero).
LA COMUNITA' MUSULMANA E I SUOI PILASTRI
a) La siyàsa
Muhammad poneva al centro del suo progetto la sostituzione della tribù come aggregato politico fondato sul vincolo di sangue, vero o fittizio, con un nuovo aggregato sociale basato sul vincolo religioso, e quindi aperto a tutti coloro che via via si convertivano all'islam. Questo progetto comportava una rivoluzione del sistema successorio agnatizio in un sistema ove l'individuo, per divenire membro di una comunità di eguali dal punto di vista religioso, doveva acquistare individualità nei confronti del gruppo agnatizio. La riforma coinvolgeva sia l'uomo che la donna (divenuta anche questa titolare di diritti successori individuali), l'abolizione degli istituti dell'adozione e dell'affratellamento, ai quali il Profeta aveva dovuto far ricorso agli inizi del soggiorno medinese, servono per ridisegnare una società non più limitata dal vincolo di sangue.
Nasceva così una comunità detta umma o ummat Muhammad, Comunità di Maometto, che il Corano stesso considera superiore alle altre comunità umane. L'umma indica ancora oggi l'ideale di unità di tutti i musulmani. Soltanto se l'islam fosse rimasto confinato in Medina, col passare delle generazioni avremmo avuto una comunità come era stata auspicata da Muhammad.
Il processo di formazione di questa umma avvenne per gradi:
Una fase iniziale caratterizzata da un assetto pattizio (consensuale) che richiama il sistema delle alleanze fra tribù e che resterà fondamentale nella costruzione dottrinale del diritto pubblico islamico. Muhammad, per rafforzare i vincoli tra musulmani, ausiliari e emigrati in Medina dopo l'egira (emigrazione) li affratellerà ricorrendo a concezioni politico-giuridiche pagane. Poco dopo l'egira, avvenuta tra il 20 e il 24 settembre del 622, a Medina Muhammad comincia a dar vita a un'organizzazione politico-sociale di cui la tradizione ha conservato notizie nel documento "Safiha" (o Carta di Medina). L'unica comunità di cui si parla nel documento ha carattere eterogeneo dal punto di vista religioso ed è a base territoriale perché formata da vari elementi della popolazione di Medina, il cui territorio è dichiarato sacro, e cioè da:
- Musulmani emigrati, medinesi convertiti
- Ebrei che, pur formando un popolo con i credenti, conservano la loro religione e devono provvedere alle loro spese con l'obbligo di concorrere con i musulmani nelle spese in caso di guerra
- Medinesi ancora pagani ai quali è vietato applicare nei confronti dei meccani pagani le norme consuetudinarie relative alla protezione dei beni e delle persone
Unico capo di questa comunità, sia politico che militare, è Muhammad che è nabì e rasul, cioè profeta e inviato di Dio, dal quale promana lo scritto (al-ktab). Lo scopo di Muhammad è di assicurare la pacifica convivenza tra gli abitanti di Medina.
La comunità riflessa dalla carta di Medina è a metà tra la umma nel senso islamico e l'accordo confederale fra tribù preislamiche (hilf).
Solo dopo il 627, con l'espulsione da Medina di alcune tribù ebraiche, l'umma acquista il suo definitivo carattere omogeneo di organizzazione di credenti che credono in una determinata scrittura (il Corano) sulla base della quale devono essere giudicati. Ai credenti membri di pieno diritto della comunità si contrappongono gli infedeli, distinti a fini giuridici in:
- Scritturari
- Gente degli idoli
Questa politica dei musulmani nella umma è connessa con l'istituzione del suo capo, cioè del califfo o imam, successore di Muhammad nell'esclusiva funzione politica, essendo quella profetica non ereditabile. Questa unità, che da un punto di vista spirituale è ancora sentita da tutti i musulmani, dal punto di vista politico, dopo il periodo delle origini, si è realizzata solo durante il califfato degli Omàyyadi e degli Abbasidi, in cui la sovranità ha avuto nell'islam carattere sostanzialmente unitario per infrangersi poi con lo sfaldamento del califfato. Riunificazione tentata ma fallita poi tra la fine del XVIII e l primi decenni del XX secolo facendo leva sulla possibilità di restaurazione del califfato.
Alcuni modernisti hanno quindi sostenuto che il carattere della missione di Muhammad fosse solo religioso, ritenendo che il Corano fosse solo un codice di religione e di morale per il servizio di Dio e il bene dell'umanità. Per questi modernisti le leggi civili devono essere lasciate all'arbitrio degli uomini, i quali hanno libera la via per lo stabilimento di nuove forme di governo e per la promulgazione di leggi adatte alle necessità contingenti. Tali posizioni sono state considerate eretiche.
Tra i giuristi musulmani c'è sempre stato accordo d'opinione sulla necessità per la umma di avere un unico capo (il califfo), vicario e successore di Muhammad. Secondo la dottrina la nomina del califfo è un atto obbligatorio che grava sulla comunità nel suo insieme e non sul singolo credente.
Secondo al-Màwardì sono due i modi di acquisto del califfato:
- Elezione o scelta da parte di coloro che hanno "capacità di sciogliere e di legare", cioè i rappresentanti della comunità che sono irreprensibili e capaci di riconoscere in un individuo l'esistenza dei requisiti necessari per essere califfo, stipulando con il candidato più idoneo il contratto di imamato e presentandogli l'omaggio
- Designazione del successore da parte del predecessore, atto che però è stato circondato di cautele per evitare un riconoscimento del principio di successione per maggiorascato
La dottrina pubblicistica posteriore ad al-Mawardì ha riconosciuto un terzo modo di acquisto del califfato
- Occupazione del potere in forza del principio che all'anarchia è preferibile la tirannia
Per la nomina del califfo sono richiesti alcuni requisiti, oltre alla capacità giuridica (essere musulmano e libero) e di agire (pubere, integro di corpo e di mente, di condotta irreprensibile, di sesso maschile) tra i quali:
- appartenenza alla stirpe dei Quraysh (tribù alla quale appartenne Muhammad)
- possesso per un certo periodo della qualità di mugtahid, ossia il possesso della dottrina sufficiente per la diretta interpretazione delle fonti della rivelazione del diritto
Nei confronti del califfo, il contratto di imamato produce come effetti:
- l'obbligo di osservare e far osservare la legge religiosa secondo la tradizione, evitando ogni innovazione riprovevole
- l'obbligo di proteggere la vita, l'onore e i beni dei musulmani
- provvedere all'amministrazione della giustizia, alla difesa militare dell'islam e a condurre la guerra santa (gihàd) contro gli infedeli
- riscuotere le entrate e provvedere alle spese pubbliche in conformità con la legge religiosa
- nominare persone adatte alle varie funzioni
La sua politica deve essere conforme alla shari'a, altrimenti sarebbe iniqua e comporterebbe la sua rimozione.