L'età Giolittiana (1901-1914): politiche e riforme di Giovanni Giolitti
Slide sull'Età Giolittiana (1901-1914). Il Pdf descrive lo sviluppo industriale italiano, le riforme elettorali e la politica coloniale in Libia, analizzando i rapporti di Giolitti con le forze politiche e sociali dell'epoca. Il Pdf, utile per la scuola superiore, è una presentazione di Storia che illustra gli argomenti principali trattati nel periodo.
See more9 Pages
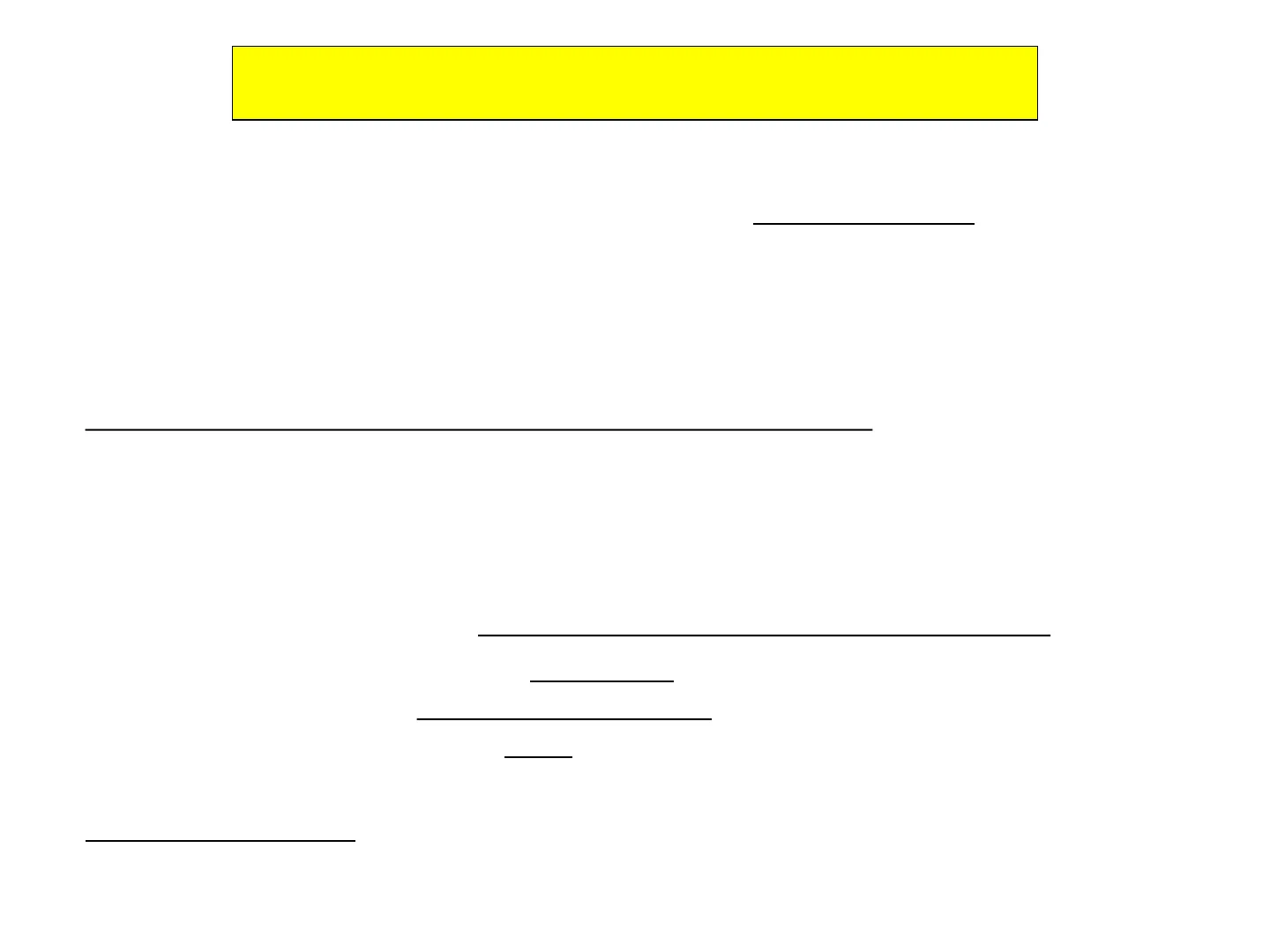
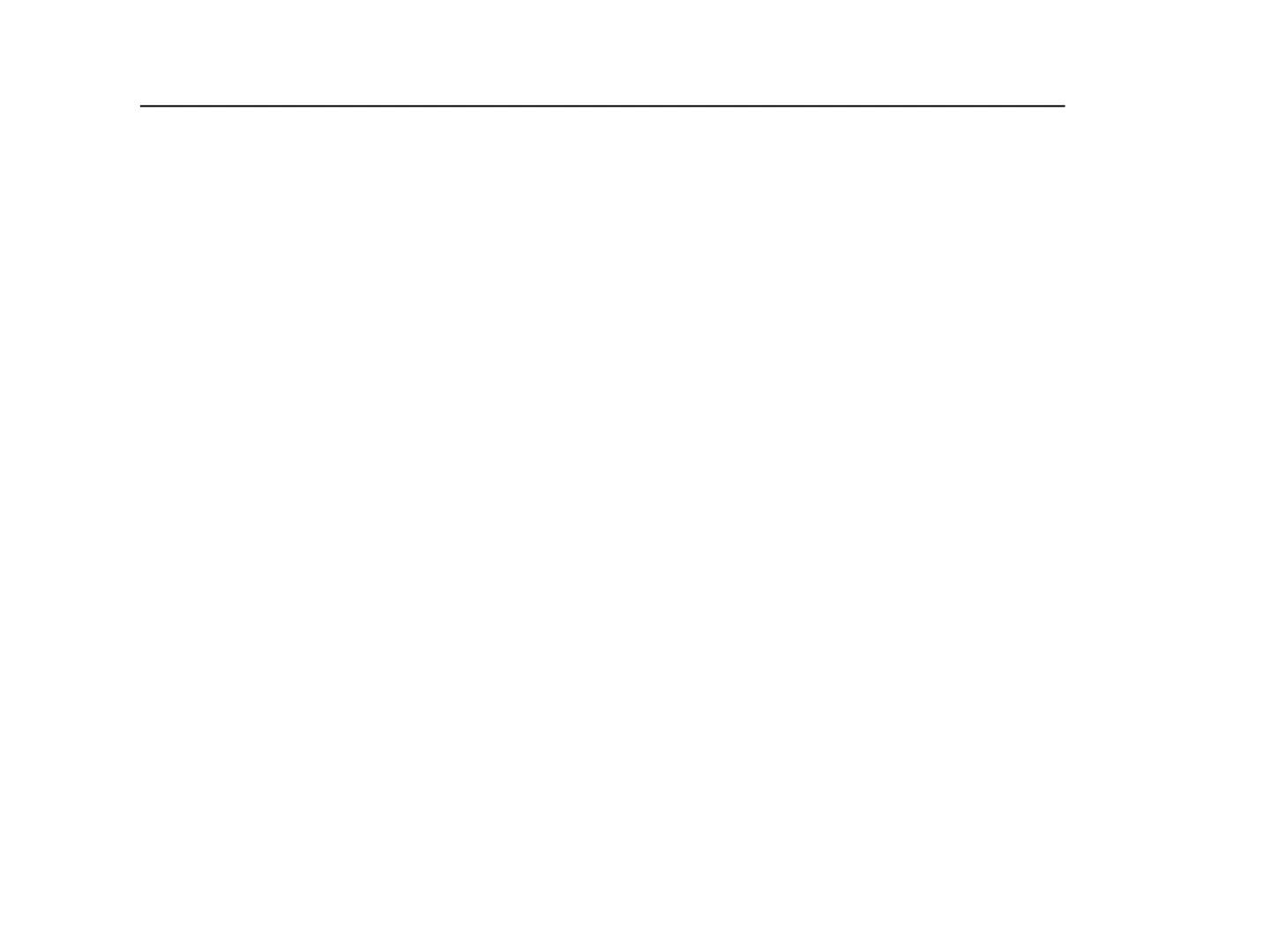
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
L'Età Giolittiana: Contesto e Ascesa di Giolitti
Nel 1901 il re Vittorio Emanuele III nominò presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli, lo affiancava come Ministro degli interni Giovanni Giolitti (nato nel 1842 a Mondovì, vicino a Cuneo). Giolitti era un politico moderato ed esperto conoscitore della macchina burocratica, e Zanardelli lasciò a lui prendere le decisioni più importanti così che nel 1903 divenne Primo ministro. Il periodo dal 1901 al 1914 prende il nome di Età giolittiana (non resse direttamente il governo per tutti questi anni, lui abbandonava in momenti di crisi lasciando il suo ruolo a uomini di fiducia o avversari politici, continuando di fatto a prestare la sua opera).
Sviluppo Industriale in Italia
Durante l'età giolittiana ci fu il decollo della rivoluzione industriale in Italia. Ci furono progressi nell'industria siderurgica (grandi stabilimenti di Terni e l'Ilva di Piombino), nell'industria elettrica e meccanica (sorsero aziende come la FIAT, l'Alfa Romeo e la Lancia) e nel settore tessile, soprattutto nell'industria del cotone. Le industrie si svilupparono soprattutto a Torino, Milano e Genova, il cosiddetto Triangolo industriale.
Condizioni dello Sviluppo Industriale
1Lo sviluppo industriale fu caratterizzato da alcuni condizioni particolari L'industria italiana fu aiutata a nascere dall'intervento statale. Particolare rilievo ebbero la commesse statali nell'ambito dei trasporti ferroviari che incentivarono la crescita, in particolare del settore meccanico e di quello siderurgico. La politica protezionistica imponendo alte tasse sui prodotti esteri, favorì le industrie del Nord e danneggiò il Mezzogiorno che vide chiuse le porte ai mercati esteri di prodotti tipici come vino, olio e agrumi. Un contributo notevole fu esercitato dalle grandi banche che finanziarono le industrie nei settori più dinamici, nacquero le grandi Banche miste (Banca Commerciale e Credito Italiano) fondate con l'aiuto di capitali esteri, soprattutto tedeschi che raccoglievano i risparmi inattivi dei privati e li rimettevano in attività proprio nella produzione industriale.
Il Doppio Volto della Politica di Giolitti
2Il doppio volto di Giolitti Il modo di fare politica di Giolitti venne definito dal «doppio volto»:
- Un volto aperto e democratico nell'affrontare i problemi del Nord
- Un volto conservatore e corrotto nello sfruttare i problemi del Sud
Per il Nord assunse un atteggiamento lungimirante, consentì gli scioperi e fece assumere al governo una posizione di neutralità nei conflitti sindacali. Giolitti era contrario alla lotta di classe, per questo tenne il governo su di una posizione neutrale, ed era convinto che non esisteva in Italia un pericolo rivoluzionario, a meno che il governo non avesse spinto i lavoratori alla ribellione armata, per questo concesse forme di protesta come lo sciopero (rispondendo così ai conservatori che lo accusavano di essere troppo tollerante nei confronti dei movimenti operai).
Riforme per le Condizioni di Lavoro
Giolitti varò anche alcune riforme per migliorare le condizioni di lavoro:
- Orario di lavoro fino ad un massimo di 10 ore al giorno
- Riorganizzata la cassa nazionale per l'invalidità e la vecchiaia dei lavoratori
- Vennero presi provvedimenti per tutelare la maternità delle lavoratrici ed il lavoro dei fanciulli (l'età minima per accedere al lavoro fu portata a 12 anni)
3La lotta sindacale portò all'aumento dei salari dei lavoratori che poterono acquistare non solo prodotti alimentari ma anche prodotti industriali come macchine da cucire, biciclette, cominciò a diffondersi al Nord il benessere tipico della società di massa.
Altre Riforme di Giolitti
Giolitti fece altre riforme:
- La statalizzazione delle ferrovie (1905)
- La nazionalizzazione delle assicurazioni sulla vita creando l'INA nel 1912 (Istituto Nazionale Assicurazioni), molto osteggiato dalle assicurazioni private
In generale l'azione di governo di Giolitti mancò di riforme di ampio respiro, non venne attuata una riforma tributaria e non venne affrontata la questione meridionale, tanto che durante i suoi governi il divario tra Nord e Sud crebbe. Giolitti verso il Sud fece interventi sporadici, come la costruzione dell'acquedotto pugliese e delle «leggi speciali» per porre rimedio a situazioni particolari, come i vari terremoti dell'epoca (1905, 1907 e 1908). Gran parte del denaro che arrivò al Sud alimento clientele e corruzione.
Repressione e Controllo del Sud
4Giolitti, di fronte agli scioperi del Sud fece intervenire duramente le forze dell'ordine, attuando una pesante repressione con numerose vittime. Il Sud era per Giolitti, politicamente un semplice serbatoio di voti da controllare con vari mezzi:
- attraverso i prefetti che per suo ordine impedivano i comizi
- le forze dell'ordine che arrestavano i sindacalisti
- ricorrendo alla corruzione, minacce e brogli per fare eleggere parlamentari a lui fedeli
Per questo Giolitti fu aspramente contestato dall'opposizione e venne definito «ministro della malavita» dallo storico Gaetano Salvemini. I salari al Sud scesero a causa della poca offerta di lavoro e sovrabbondanza di manodopera, questo portò il meridione in uno stato di povertà e disoccupazione, tanto che molti emigrarono all'estero e tra il 1900 ed il 1914 emigrarono più di 8 milioni di italiani, verso il Nord Europa, Stati Uniti, Argentina e Brasile. L'emigrazione, tuttavia portò un po' di ricchezza, in quanto chi lavorava all'estero mandava parte della propria paga in Italia, le cosiddette «rimesse» e chi invece era restato, ebbe possibilità di lavorare e gradualmente vide salire i propri salari.
Politica Coloniale e Suffragio Universale
5Tra successi e sconfitte Giolitti riprese la politica coloniale per tre motivi principali:
- Dimostrare ai nazionalisti che il suo governo era in grado di aumentare il prestigio internazionale dell'Italia
- Voleva assecondare i maggiori gruppi industriali e finanziari (il cattolico Banco di Roma che aveva cospicui interessi economici in Libia)
- Voleva accontentare l'opinione pubblica che riteneva necessario conquistare nuove terre per dare lavoro ai braccianti del Sud e a tutti gli emigrati
Giolitti rispetto ai governi precedenti cambiò obiettivo, la Libia e non più l'Etiopia, sfruttando il momento favorevole internazionale (l'Italia aveva accettato il dominio francese in Tunisia e Marocco ed in cambio aveva ottenuto il «diritto di conquista» in Libia). Nel 1911 l'Italia dichiarò guerra alla Turchia che dominava la Libia, furono subito occupate la principali città, ma la popolazione libica organizzò una forte resistenza. Furono inviati in Libia altri militari a formare un contingente di 100.000 uomini.
Guerra Italo-Turca e Conquista della Libia
6Non riuscendo ad indebolire la resistenza libica, l'Italia attaccò la Turchia inviando la marina nell'Egeo e occupando alcune isole delle Sporadi andando a formare il dominio italiano nel Dodecaneso (dodici isole) con capoluogo Rodi. I turchi spaventati firmarono il Trattato di Lisbona nel 1912 con il quale cedevano all'Italia il dominio sulla Libia. La Libia non era però una terra fertile e rigogliosa e non aveva ricchezze minerarie (il petrolio fu scoperto solo più tardi), e fu definita uno «scatolone di sabbia», chi ne trasse vantaggio furono le banche, gli armatori e l'industria militare. Per anni la sovranità italiana rimase limitata alla fascia costiera e solo nel 1927, il regime fascista l'avrebbe estesa ai territori interni.
Introduzione del Suffragio Universale Maschile
Giolitti nel maggio del 1912, fece approvare una nuova legge elettorale che introduceva il Suffragio universale maschile, diritto di voto a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto il trentesimo anno di età, invece per accedere al voto a 21 anni era necessario avere adempiuto agli obblighi militari, sapere leggere e scrivere. Gli elettori passarono da 3,3 a 8,6 milioni, dal 9,5% della popolazione al 24%! In questo modo Giolitti intendeva avvicinare alle istituzioni i socialisti (che dominavano il mondo operaio) ed i cattolici (che dominavano il mondo contadino).
Cattolici e Patto Gentiloni
7I cattolici si recarono alle urne per la prima volta nel 1904 (il non expedit, il divieto sancito da Pio IX per tutti i cattolici di votare ed essere votati fu ammorbidito da Papa Pio X). Non era ancora possibile costituire un partito cattolico, ma si erano formati circoli di assistenza caritatevole ed animazione culturale attraverso l'Opera dei Congressi. Erano sorti sindacati cattolici e le cooperative bianche (il bianco era il colore dei cattolici ed il rosso dei socialisti), ed era stata fondata l'Azione Cattolica, che inquadrava il laicato cattolico sotto la guida del Papa. Nel 1913, Giolitti stipulò con l'Unione elettorale cattolica, presieduta dal Conte Filippo Gentiloni, un accordo: il Patto Gentiloni, dove i cattolici promettevano di votare quei candidati liberi che avessero sottoscritto l'impegno di difendere la Chiesa. Grazie a questo patto, nelle elezioni del 1913 Giolitti ottenne la maggioranza facendo eleggere 304 deputati liberali, mentre la sinistra ottenne 169 deputati.
Fine dell'Età Giolittiana
8La guerra in Libia aveva indebolito il governo Giolitti e molti criticavano l'esecutivo, allora Giolitti preferì dare le dimissioni (certo che come successo negli anni precedenti sarebbe presto stato richiamato al governo) ed il re indicò come successore Antonio Salandra. Salandra non seguì l'esempio di Giolitti nelle manifestazioni popolari, e nel 1914 in Romagna e nelle Marche scoppiarono disordini e Salandra mandò l'esercito a reprimerli. La situazione internazionale precipitava verso la prima guerra mondiale, Giolitti si opporrà all'intervento dell'Italia nel conflitto, ma inutilmente. L'età giolittiana era veramente finita. 9