Storia della scuola italiana: dimensione pedagogica e principi costituzionali
Documento da Università su Storia della scuola, la dimensione pedagogica della Costituzione italiana. Il Pdf esplora la storia della scuola italiana, analizzando la riforma Gentile e i concetti di educazione e cultura, con riferimenti agli articoli della Costituzione, utile per lo studio universitario di Storia.
Mostra di più49 pagine

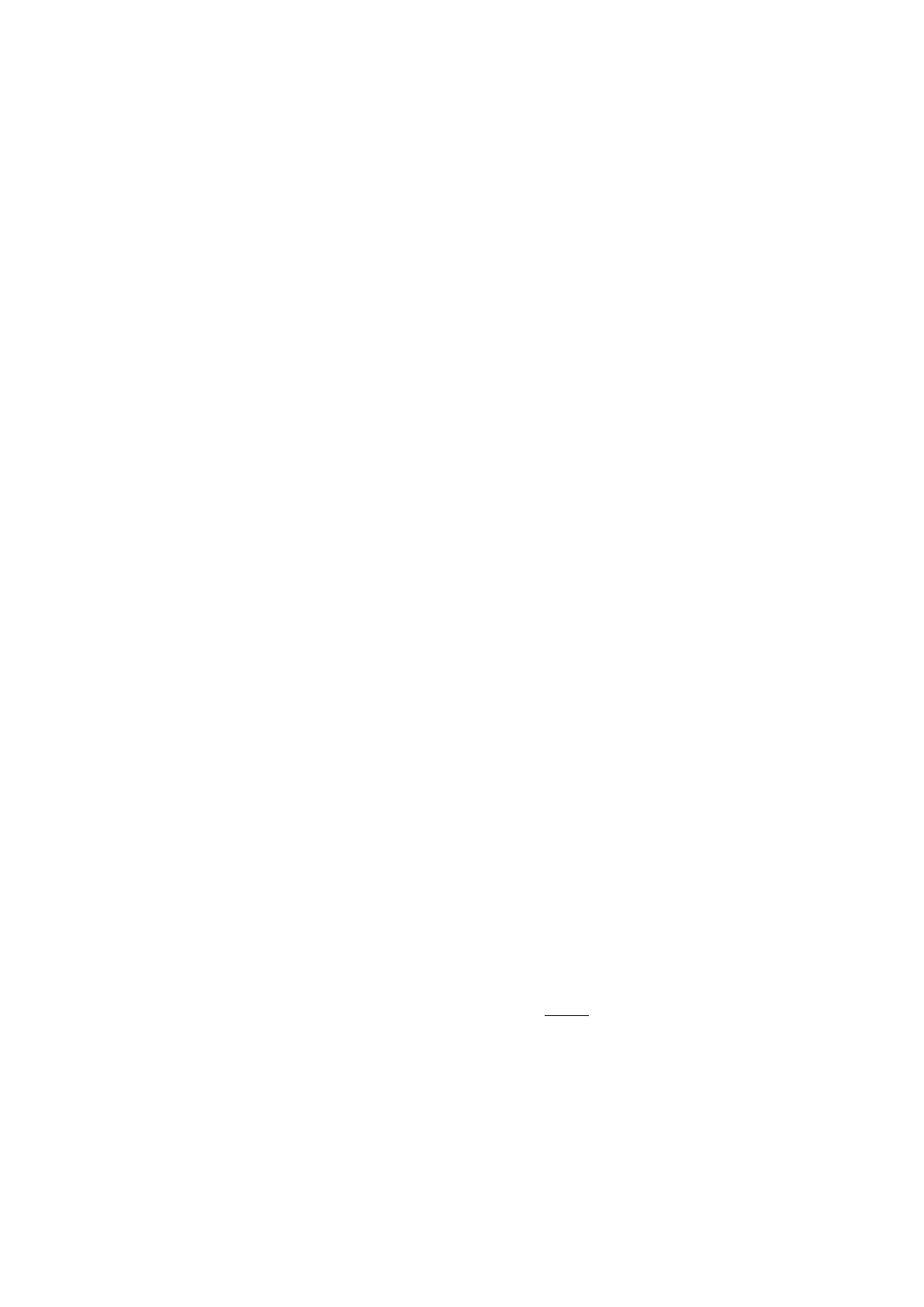
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
La dimensione pedagogica della costituzione italiana
La scuola nella costituzione.
Articolo 3 della Costituzione Italiana
Art. 3 -> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
I principi fondamentali della Costituzione
Articolo 1 della Costituzione Italiana
Art. 1 -> L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2 della Costituzione Italiana
Art. 2 -> La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 4 della Costituzione Italiana
Art. 4 -> La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 5 della Costituzione Italiana
Art. 5 -> La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Articolo 9 della Costituzione Italiana
Art. 9 -> La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Concetti legati gli uni con gli altri
- Scuola
- Cultura
- Educazione
- Processi di culturalizzazione
Articolo 33 della Costituzione Italiana
Art. 33 -> L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Articolo 34 della Costituzione Italiana
Art. 34 -> La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Il ruolo istituzionale della scuola attraverso il paradigma della Pedagogia Generativa
Il paradigma della Pedagogia Generativa mira a promuovere un apprendimento significativo e duraturo, un orientamento profondo e un pensiero generativo, che abbia valore per la vita e che renda i soggetti, rispettivamente, Persona e Comunità Pensanti, abilitando all'esercizio consapevole e libero della responsabilità della cittadinanza attiva.
Le Comunità Pensanti
Le Comunità Pensanti sono intese come contesti di apprendimento collaborativo, basati sul dialogo, lo scambio dinamico e continuo, la condivisione di saperi e la co-costruzione di significati, contesti capaci di affrontare le sfide del nostro tempo con saggezza, empatia e responsabilità collettiva.
Dal presente al passato: storia generale e storia della scuola
Una prima riflessione sulla storia della scuola
Una prima riflessione: in che misura il presente costringe non solo lo storico, ma anche il presente costringe non solo lo storico, ma anche il politico e comunque chi sia interessato al settore, a ripensare il rapporto scuola-società come si è delineato nei primi decenni dell'Italia democratica.
La riflessione può essere scomposta in una serie di interrogativi cui non è facile dare una risposta lineare.
Prima dell'unità dell'Italia (1861)
Cosa succede in Italia nell'800?
I moti italiani del 1820-1821 e quelli del 1831 ebbero in prevalenza un carattere municipalista, nel senso che i loro promotori concepivano la libertà e l'indipendenza essenzialmente in riferimento alla singola realtà statale, cui appartenevano, più che nella prospettiva della costruzione di un comune stato nazionale italiano. Questo municipalismo non era in fondo che lo specchio delle tante, profonde differenze esistenti tra le varie parti della penisola.
Erano proprio queste differenze che facevano ritenere a molti irrealistica e non auspicabile una soluzione unitaria del problema italiano. Per tanti appartenenti all'élite patriottica, la nazione italiana era una ma in senso esclusivamente culturale (una d'arme, di lingua, d'altare, /di memorie, di sangue e di cor come scrisse Manzoni in Marzo 1821); a ciò corrispondeva l'aspirazione a una qualche forma di associazione, di unione tra le diverse popolazioni della penisola, escludendo la creazione di un unico Stato che abbracciasse tutta l'Italia.
Del resto, la prima attestazione in un vocabolario del termine unità con il significato proprio di "unità d'Italia" si riscontra solo nel 1851, in un dizionario politico popolare stampato a Torino.
Giuseppe Mazzini e l'unità d'Italia
Decisamente a favore dell'unità fu invece Giuseppe Mazzini. Fin dalla fondazione della Giovine Italia nel 1831, Mazzini insistette sulla necessità di dar vita a uno Stato comprendente l'intera penisola italiana, poiché considerava questa soluzione come l'unica adeguata alle aspirazioni nazionali, come la sola che corrispondesse al grande disegno divino di un'Europa delle nazioni e alla missione riservata all'Italia: "l'Unità d'Italia è cosa di Dio, preparata dall'opera provvidenziale dei secoli".
La concezione mazziniana della nazione implicava la condanna senza appello di ogni ipotesi di tipo federalistico, che secondo lui avrebbe dato vita a uno Stato debole e minato dalle divisioni interne: "La Giovine Italia - scriveva Mazzini - è Unitaria perché senza unità non v'è veramente Nazione - perché senza Unità non v'è forza, e l'Italia, circondata da nazioni unitarie, potenti, e gelose, ha bisogno anzitutto d'essere forte".
Sempre secondo Mazzini, il federalismo l'avrebbe posta sotto l'influenza della nazioni vicine e, sul piano interno, avrebbe ridato vita alle "rivalità locali oggi mai spente".
Cavour e l'unificazione italiana
Anche Cavour, che pure avrebbe dato un contributo decisivo alla nascita dello Stato unitario, nel 1856 definiva l'unificazione italiana come un corbelleria. Ancora alla vigilia della prima guerra d'indipendenza, Cavour e il Piemonte si muovevano in una prospettiva esplicitamente non unitaria.
Nel 1858 gli accordi stipulati con Napoleone III a Plombières prevedevano, nella forma di confederazione presieduta dal papa, un'Italia ancora divisa in quattro Stati:
- un regno dell'Alta Italia (comprendente, oltre al Regno di Sardegna, il Lombardo-Veneto e l'Emilia-Romagna);
- un regno dell'Italia centrale (formato dalla Toscana e da una parte delle province pontificie);
- uno Stato della Chiesa notevolmente ridotto nelle sue dimensioni territoriali;
- un regno meridionale coincidente con quello delle Due Sicilie (senza la dinastia borbonica).
Se alla fine si affermò la soluzione unitaria, ciò avvenne per il decorso imprevisto degli avvenimenti verificatisi tra il 1859 e il 1860 (le insurrezioni nell'Italia centrale, la spedizione dei Mille) che resero impossibile l'ipotesi di un'Italia divisa in più Stati. Ma nel biennio decisivo per l'indipendenza italiana la prospettiva unitaria di affermò anche perché era stata sostenuta con forza, per decenni, da Mazzini.
Il fatto stesso che il movimento democratico fosse diventato nel corso del tempo un movimento anzitutto unitario era un risultato indiretto della sua insistente predicazione.
L'Italia dopo la seconda guerra di indipendenza
L'Italia alla ratifica delle cessioni della Savoia e di Nizza alla Francia, dopo la seconda guerra di indipendenza, 1860.
Dal presente al passato: storia generale e storia della scuola
Diversità politica ed economica
Alla diversità politica, corrisponde una diversità economica.
Il sistema scolastico italiano ha subito trasformazioni gigantesche e in ogni caso tali da investire la quasi totalità del Paese, non solo per quanto riguarda l'obbligo, ma anche, in larga parte, i livelli superiori.
Occorre pertanto riconsiderare il rapporto tra storia dell'istruzione e storia della Repubblica italiana - dove quest'ultima è da intendersi in entrambe le sue dimensioni, quella politico-istituzionale, cioè dello Stato, e quella della società civile -, ripercorrendo i mutamenti, i valori e gli impulsi ideologici, che hanno attraversato reciprocamente i due termini.
Dalla legge Casati all'età giolittiana
Legge Casati - 13 Novembre 1859
Legge Casati - 13 Novembre 1859. Un decreto legge che ha dato poi retta l'impianto scolastico italiano per oltre settanta anni.
La legge Casati si inserisce in un contesto culturale prevalentemente analfabeta e in un paese sostanzialmente rurale. La legge nasce come testo da applicare a due delle aree fra le più alfabetizzate dell'Italia: Piemonte e la Lombardia. Tuttavia, questa legge sarebbe stata estesa a tutto il territorio, compreso quello che conosceva la guerra del brigantaggio e l'opposizione ecclesiastica.
Il ministro Gabrio Casati
Gabrio Casati era un membro di quel grande patriziato lombardo che a va accetta il processo di unificazione con il Piemonte, ed era stato a lungo esule a Torino, dopo aver diretto per anni la scuola Arcimbolda a Milano. Nel tratto dell'esilio aveva potuto misurarsi con il modello sabaudo che aveva profonde radici nelle precoci riforme '700esche. Pur restando una scuola dei sudditi e non dei cittadini, il modello di Vittorio Amedeo II aveva già assimilato tradizioni culturali ed europee.
I precedenti della Legge Casati
Con la fine del secolo XVIII e nel decennio successivo gran parte dell'Italia dovette misurarsi con il modello napoleonico, che portava agli spazi italiani un'esperienza intimamente contraddittoria, ma avanzata: sempre una scuola dei sudditi, ma sul piano culturale più innovativa e aperta di quella '700esca.
Naturalmente alla presenza di modelli d'insegnamento francese reagirono meglio Piemonte e Lombardi, da sempre storicamente legati alla Francia, ma un certo effetto positivo si registro anche in Emilia e in Toscana, dove non erano mancati regimi illuminati, mentre il Sud restava ostinatamente indietro, e così la Sicilia, a differenza della Sardegna, dove non solo erano stati applicati i modelli piemontesi, ma la corte trasferita aveva continuato a utilizzare università e scuole secondarie.
L'applicazione e l'estensione della legge a tutto il territorio nasce dalla consapevolezza della classe dirigente italiana che garantire una maggiore alfabetizzazione sarebbe stato favorevole alla nazione e al suo processo unitario profondo, oltre che alla trasformazione produttiva del Paese.
L'applicazione incontrò le ostilità dei parroci che da sempre si erano occupati dell'insegnamento della religione, le resistenze della cultura contadina e con esse, dovette fare i conti con i drammatici vincoli di spesa.
LEGGE CASATI 1859
Nell'800 l'Italia è un paese sostanzialmente rurale caratterizzato da un altissimo tasso di analafabetismo
Tuttavia, il conseguimento dell'Unità determina l'applicazione della legge per tutto il paese. Ciò portò con sé difficoltà e vantaggi
La legge Casati nasce da e per regioni avanzate, fra le più alfabetizzate d'Italia: Piemonte e Lombardia
Legge Casati
La legge fu un provvedimento finalizzato a consolidare le istituzioni scolastiche sabaude delineate nel cosiddetto "decennio di preparazione" (1849-1859) in cui il regno sabaudo si era dedicato all'ammodernamento dell'apparato produttivo, la creazione di una pubblica amministrazione all'altezza dei nuovi compiti, lo sviluppo di un tessuto sociale allargato anche ceti tradizionalmente