Letteratura italiana: origini della lingua e letteratura fino al Trecento
Documento della Prof. Federica Verzini su Letteratura Italiana. Il Pdf esplora le origini della lingua e della letteratura italiana, coprendo il periodo dalla fine del mondo latino fino al Trecento, con un focus su Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, per la scuola superiore.
Mostra di più15 pagine
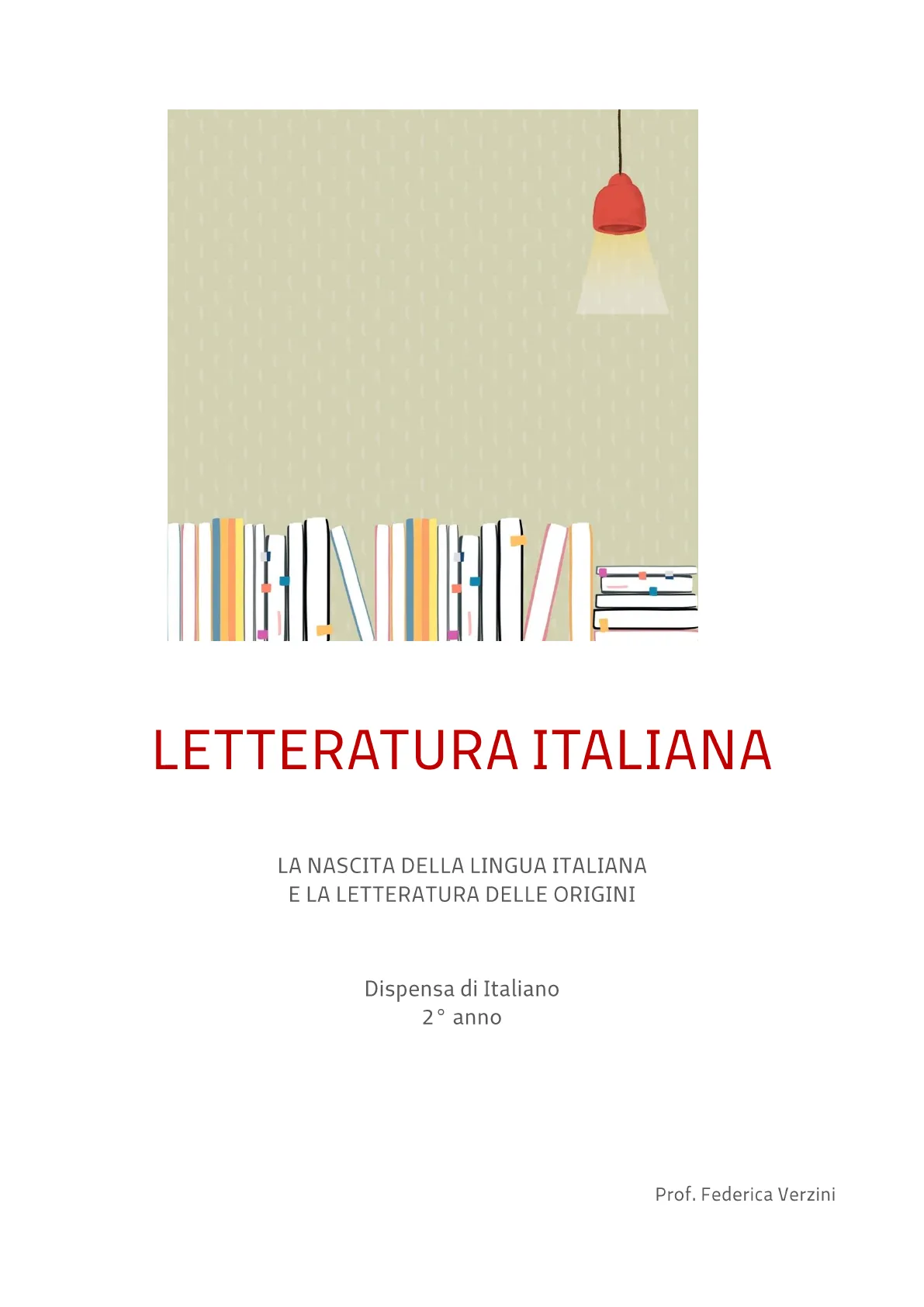
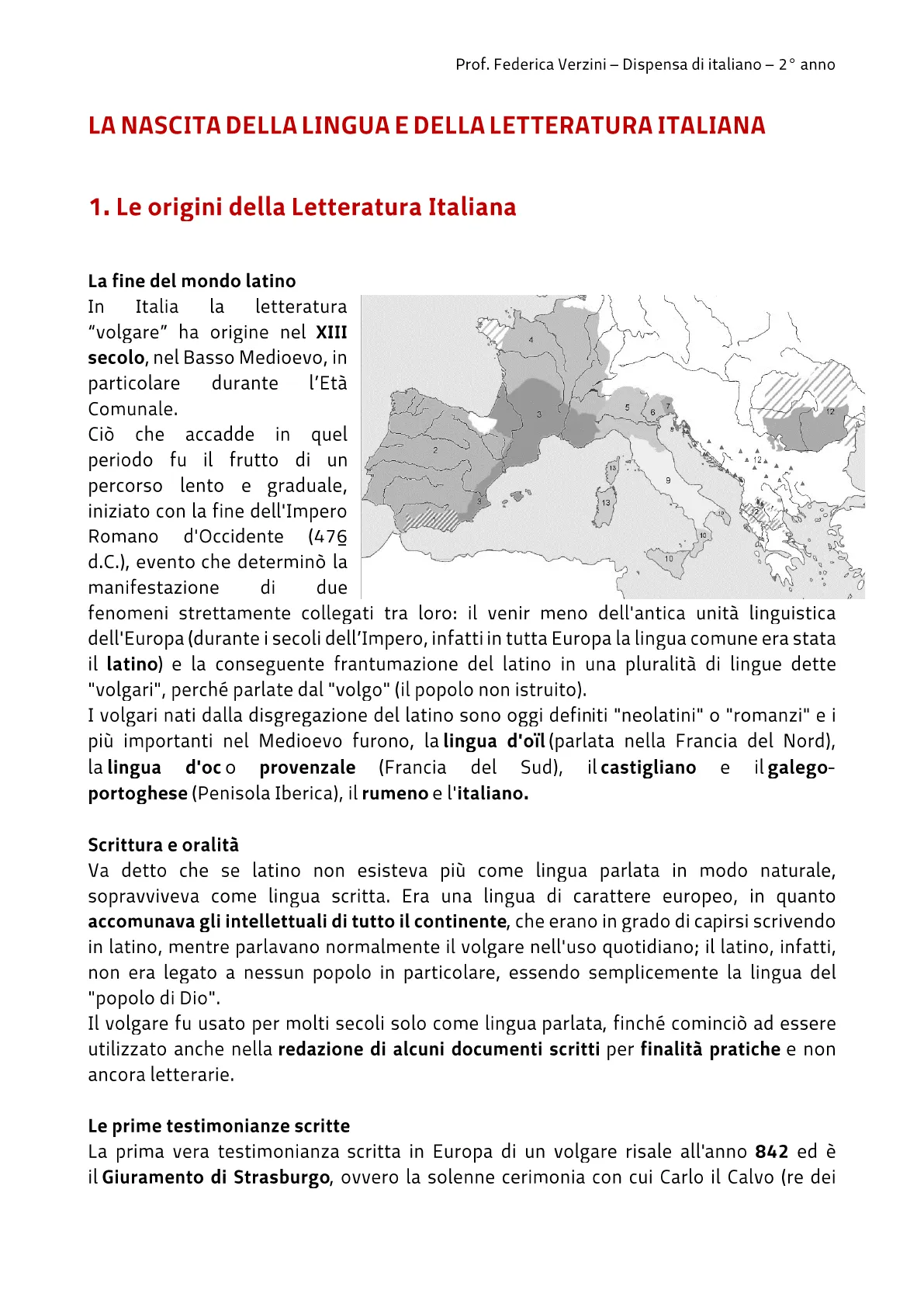
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
LETTERATURA ITALIANA
LA NASCITA DELLA LINGUA ITALIANA E LA LETTERATURA DELLE ORIGINI
Dispensa di Italiano 2º anno Prof. Federica VerziniProf. Federica Verzini - Dispensa di italiano - 2º anno
LA NASCITA DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA ITALIANA
1. Le origini della Letteratura Italiana
La fine del mondo latino
In Italia la letteratura "volgare" ha origine nel XIII secolo, nel Basso Medioevo, in particolare durante l'Età Comunale. 4 5 12 3 6 Ciò che accadde in quel periodo fu il frutto di un 13 A 12 A percorso lento e graduale, 9 iniziato con la fine dell'Impero 13 Romano d'Occidente (476 d.C.), evento che determinò la 10 manifestazione di due fenomeni strettamente collegati tra loro: il venir meno dell'antica unità linguistica dell'Europa (durante i secoli dell'Impero, infatti in tutta Europa la lingua comune era stata il latino) e la conseguente frantumazione del latino in una pluralità di lingue dette "volgari", perché parlate dal "volgo" (il popolo non istruito). I volgari nati dalla disgregazione del latino sono oggi definiti "neolatini" o "romanzi" e i più importanti nel Medioevo furono, la lingua d'oïl (parlata nella Francia del Nord), la lingua d'oco provenzale (Francia del Sud), il castigliano e il galego- portoghese (Penisola Iberica), il rumeno e l'italiano.
Scrittura e oralità
Va detto che se latino non esisteva più come lingua parlata in modo naturale, sopravviveva come lingua scritta. Era una lingua di carattere europeo, in quanto accomunava gli intellettuali di tutto il continente, che erano in grado di capirsi scrivendo in latino, mentre parlavano normalmente il volgare nell'uso quotidiano; il latino, infatti, non era legato a nessun popolo in particolare, essendo semplicemente la lingua del "popolo di Dio". Il volgare fu usato per molti secoli solo come lingua parlata, finché cominciò ad essere utilizzato anche nella redazione di alcuni documenti scritti per finalità pratiche e non ancora letterarie.
Le prime testimonianze scritte
La prima vera testimonianza scritta in Europa di un volgare risale all'anno 842 ed è il Giuramento di Strasburgo, ovvero la solenne cerimonia con cui Carlo il Calvo (re dei 2Prof. Federica Verzini - Dispensa di italiano - 2º anno Franchi) e Ludovico il Germanico (re di Germania) si giurarono reciprocamente fedeltà nella lotta comune contro il fratello Lotario: i tra fratelli erano in guerra tra loro. Dopo vari scontri, Carlo e Ludovico decidono di unire i propri intenti. Quindi giurarono, ciascuno nella lingua dell'altro, e i rispettivi eserciti ripeterono la formula nei loro propri volgari, ovvero francese e il tedesco. L'evento venne registrato da uno storico dell'epoca che trascrisse le parole in antico francese (all'interno della sua opera che, nelle restanti parti, era in latino), costituendo così il più antico documento scritto di quella lingua e il più antico documento scritto in un volgare neolatino.
960: nasce la lingua italiana
Risale invece al 960 il primo esempio scritto di un volgare italiano, il cosiddetto placito (cioè sentenza) campano pronunciato da un giudice della città di Capua: un laico aveva rivendicato il possesso di un terreno appartenente al monastero benedettino di Montecassino e il giudice ascolto una testimonianza che appoggiava la difesa dell'abbazia. La sentenza riportò le parole in volgare del testimone e tale documento fu il primo a testimoniare l'uso scritto di un volgare che ormai col latino aveva poche somiglianze. Per queste ragioni il 960 è considerato l'anno di nascita della lingua italiana. L'italiano era in realtà un insieme di molte lingue, diverse da città a città; da queste sono derivati i dialetti moderni. La situazione italiana era molto frammentata politicamente (specie al Nord, dove nel XII-XIII secolo si era sviluppata la civiltà comunale) e anche culturalmente, non essendovi una lingua di "corte" che potesse unificare gli scrittori della penisola. In Italia mancava infatti una vera corte, simile a quella francese o a quelle dei signori feudali di Provenza, se si eccettua il caso di Federico II in Sicilia. Diversa fu anche l'estrazione sociale dei primi scrittori in lingua volgare, i quali furono spesso uomini politici impegnati a vario titolo nelle istituzioni comunali (talvolta notai o uomini di legge) oppure al servizio di un sovrano e operanti in una corte. I primi testi letterari si espressero in volgare umbro (la poesia religiosa di Francesco d'Assisi e Iacopone da Todi), in siciliano (la poesia di corte dei poeti della Scuola Siciliana), in toscano (la poesia amorosa degli Stilnovisti), in veneziano (l'esempio più importante è il Milione di Marco Polo, che potremmo definire "letteratura di viaggio") e in lombardo (la poesia didattica). Tra questi, il volgare toscano sarebbe poi diventato la lingua letteraria per eccellenza della nostra tradizione, attraverso il modello illustre dei principali scrittori del Trecento (Dante, Petrarca, Boccaccio). Sul modello del volgare toscano del Trecento vennero codificate, due secoli dopo, le prime grammatiche della lingua italiana.
La nascita della letteratura italiana
Le primissime manifestazioni letterarie in un volgare italiano furono di argomento religioso. In particolare, nell'Umbria del XIII secolo si diffonde l'usanza di comporre 3Prof. Federica Verzini - Dispensa di italiano - 2º anno preghiere in versi, chiamate laudi. La laude (parola che in latino significa lode) aveva come obbiettivo lodare la grandezza di Dio. Il principale autore di laudi fu Iacopone da Todi (1233 - 1306) che compose novanta laudi, diffuse in tutta l'Umbria e raccolte successivamente in un "laudario". Iacopone non fu tuttavia il primo a comporre una preghiera in versi. Il suo modello è Francesco di Assisi, figura cardine in ambito storico-religioso e letterario.
San Francesco di Assisi
Francesco di Assisi (1181 - 1226) è ricordato dal punto di vista religioso per la fondazione dell'ordine Francescano che costituì un punto di svolta per la storia della Chiesa. Discendente di una famiglia nobile, suo padre, ricco mercante di stoffe, cresce il giovane Francesco tra ricchezze e valori cavallereschi. Dopo la conversione, Francesco, nel 1209 fonda l'ordine religioso Francescano, conducendo il resto della sua vita in assoluta povertà. Dal punto di vista letterario, Francesco è ricordato come primo autore italiano in lingua volgare. Nel corso di vari anni, si dedicò infatti alla composizione del Cantico delle creature, inaugurando il nuovo genere letterario della lauda, di cui abbiamo parlato. Il Cantico delle creatureè un inno di lode a Dio per la bellezza e l'utilità del creato. È scritto in volgare umbro del Duecento anche se alcuni elementi sono ancora tipici della lingua latina. È composto da 33 versi, divisi in due parti:
- Nella prima parte Dio viene lodato per le sue creature naturali. Esse appartengono a due tipologie, ossia le creature del cielo (sole, luna, stelle) e gli elementi naturali (aria, acqua, fuoco e terra).
- Nella seconda parte Dio viene lodato attraverso gli uomini, in particolare quelli che sanno perdonare e sopportare le sofferenze. Questi sono coloro che muoiono in grazia di Dio e che non conosceranno la morte dell'anima. Rimprovera invece coloro che restano in preda al peccato.
4Prof. Federica Verzini - Dispensa di italiano - 2º anno
2. La cultura cortese e la Scuola Siciliana
La cultura cortese
Nel periodo di maggiore espansione del sistema feudale, tra l'XI e il XIII secolo, la nobiltà europea elaborò una nuova forma di cultura. Poiché ciò avvenne nell'ambito delle corti, si è soliti parlare di cultura cortese. In questa cultura confluivano i valori della guerra e dell'onore, ovvero i valori della cavalleria, il rango più elevato della gerarchia militare, accessibile quasi esclusivamente ai nobili, a causa dei costi elevatissimi che comportava (cavallo, armatura, lungo tirocinio). A partire dall'XI secolo, la cavalleria svolse un ruolo importante nelle crociate e nelle guerre contro gli "infedeli", come raccontato nella letteratura dell'epoca. L'intera società feudale finì per identificarsi con i valori della cavalleria e per accoglierne i riti, le cerimonie, i comportamenti. Il titolo di cavaliere divenne sinonimo di gentiluomo, di nobile. Il cavaliere aspirava a distinguersi dagli altri uomini non solo per la nobiltà della sua famiglia e il coraggio in battaglia, ma anche per la cortesia, ovvero per l'insieme delle virtù dell'uomo di corte: la nobiltà di sentimenti, l'eleganza, la gentilezza, la generosità. Si affermò anche una particolare concezione dell'amore, tipica dell'essere cavaliere, il cosiddetto amore cortese.
Le corti di Francia e Provenza
Al mondo delle corti, in particolare a quelle di Francia e di Provenza, è legata la nascita di una letteratura in lingua volgare, che celebra i valori della classe feudale e gli ideali cortesi della cavalleria. I romanzi cavallereschi e le canzoni di gesta, la più celebre delle quali è la Canzone di Orlando, furono scritti in lingua d'oïl, l'antico francese parlato nella Francia del nord. Nella zona meridionale della Francia, in cui si parlava la lingua d'oc, ci fu una grande produzione poetica. Intorno al XIII secolo anche le corti feudali dell'Italia settentrionale diedero vita a una raffinata cultura cortese, influenzate dalle letterature romanze francesi e provenzali.
La cultura cortese in Italia: Federico II e la Scuola Siciliana
Un discorso a parte merita la corte dell'imperatore Federico II a Palermo. Il capoluogo siciliano, che già con i normanni era diventato uno dei principali centri commerciali del Mediterraneo, con Federico II (1194-1250) divenne luogo di incontro di lingue e civiltà: si parlava latino, greco, tedesco e arabo. L'imperatore, che amava la cultura ed era curioso in fatto di scienza, si circondò di studiosi e scienziati provenienti da diversi paesi, istituì a 5Prof. Federica Verzini - Dispensa di italiano - 2º anno Salerno la prima cattedra europea di anatomia e a Napoli un'università per la formazione nell'ambito del diritto. Alla sua corte avvenne qualcosa di innovativo ed originalissimo: i funzionari amministrativi (notai perlopiù) iniziarono a dilettarsi scrivendo poesie, dando vita ad una nuova forma di letteratura. La prima scuola poetica italiana nacque così in Sicilia nella prima metà del Duecento (1230-1250). Con il termine "scuola" si intende sottolineare che questi poeti presentano scelte tematiche e stilistiche comuni, anche se ciascuno conferì ai propri versi un'impronta individuale. Tra i poeti più noti, Giacomo da Lentini, Pier delle Vigne e Cielo d'Alcamo. I componimenti dei siciliani ci sono giunti grazie a trascrizioni compilate in Toscana che, se hanno il merito di avere tramandato questa produzione, ne hanno anche mutato alcune caratteristiche linguistiche, traducendo il linguaggio siciliano in forme toscane. Tema quasi esclusivo della poesia della Scuola Siciliana è l'amore, ovviamente quello cortese. Ma che cosa si intende dunque per amore cortese? Si tratta di un tipo di amore inteso come fedeltà (non in senso moderno, ma in un modo che ricorda molto il rapporto tra servo e signore, tipico della società dell'epoca) alla donna, quasi sempre un'aristocratica, cui il poeta si rivolge con tono di sottomissione. L'immagine femminile è convenzionale: la donna è una creatura eccezionale, bella, virtuosa e inaccessibile, capelli biondi, sguardo luminoso e atteggiamento dolce. I componimenti dei poeti siciliani diventarono modello di stile per i poeti successivi. Dante stesso esaltò l'abilità di questi poeti e la dignità della loro lingua. 6