Ragione regionale delle norme e universale dei principi nel diritto
Documento di Università su Ragione regionale delle norme. Ragione universale dei principî. Il Pdf analizza la ragione giuridica, distinguendo tra norme regionali e principi universali, con focus sulla filosofia del diritto. È un materiale discorsivo per lo studio autonomo di Diritto.
See more12 Pages
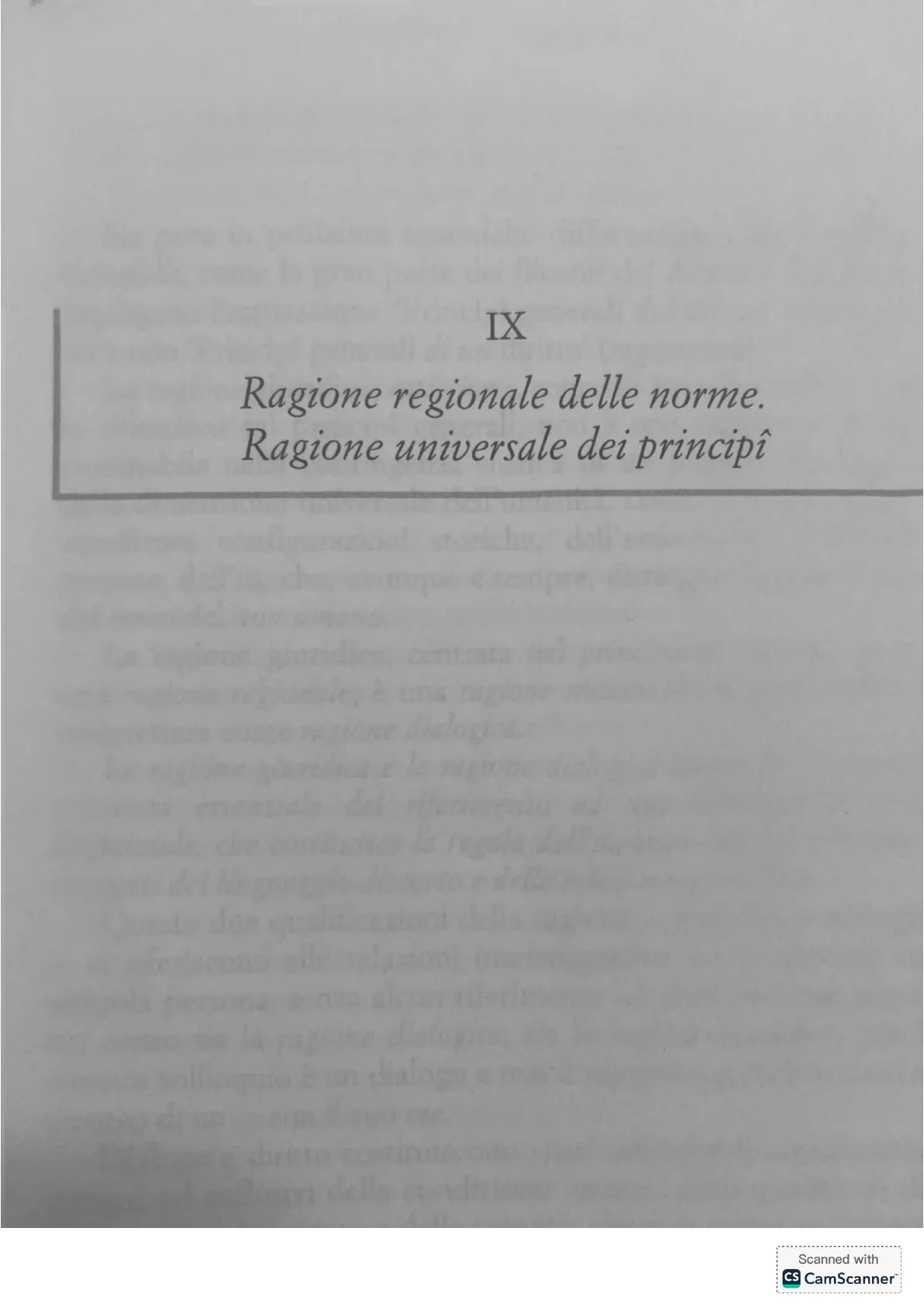
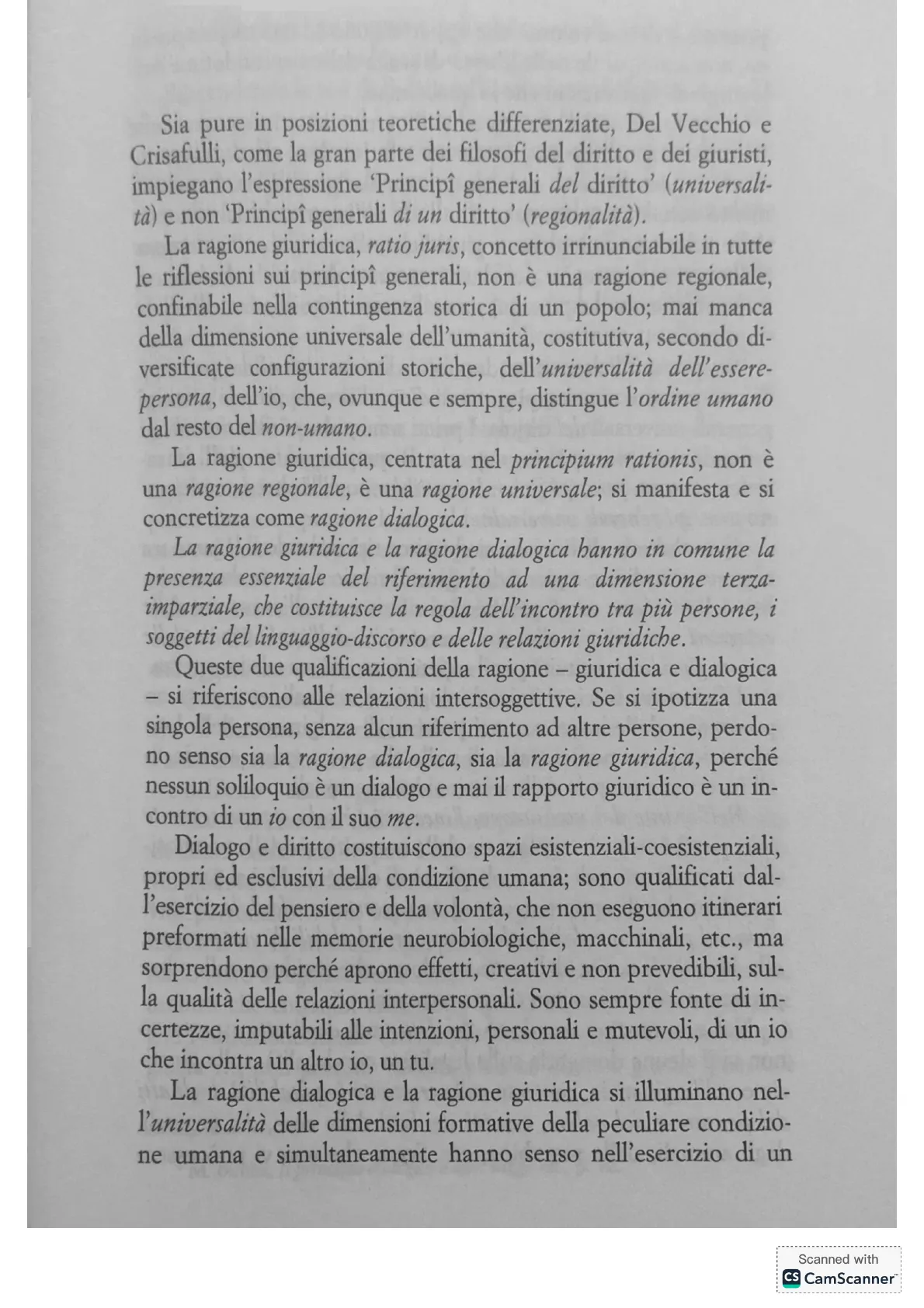
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Ragione regionale delle norme e universale dei principi
IX Ragione regionale delle norme. Ragione universale dei principî Scanned with CamScanner" CSSia pure in posizioni teoretiche differenziate, Del Vecchio e Crisafulli, come la gran parte dei filosofi del diritto e dei giuristi, impiegano l'espressione 'Principî generali del diritto' (universali- tà) e non 'Principî generali di un diritto' (regionalità).
La ragione giuridica, ratio juris, concetto irrinunciabile in tutte le riflessioni sui principî generali, non è una ragione regionale, confinabile nella contingenza storica di un popolo; mai manca della dimensione universale dell'umanità, costitutiva, secondo di- versificate configurazioni storiche, dell'universalità dell'essere- persona, dell'io, che, ovunque e sempre, distingue l'ordine umano dal resto del non-umano.
La ragione giuridica, centrata nel principium rationis, non è una ragione regionale, è una ragione universale; si manifesta e si concretizza come ragione dialogica.
La ragione giuridica e la ragione dialogica hanno in comune la presenza essenziale del riferimento ad una dimensione terza- imparziale, che costituisce la regola dell'incontro tra più persone, i soggetti del linguaggio-discorso e delle relazioni giuridiche.
Queste due qualificazioni della ragione - giuridica e dialogica - si riferiscono alle relazioni intersoggettive. Se si ipotizza una singola persona, senza alcun riferimento ad altre persone, perdo- no senso sia la ragione dialogica, sia la ragione giuridica, perché nessun soliloquio è un dialogo e mai il rapporto giuridico è un in- contro di un io con il suo me.
Dialogo e diritto costituiscono spazi esistenziali-coesistenziali, propri ed esclusivi della condizione umana; sono qualificati dal- l'esercizio del pensiero e della volontà, che non eseguono itinerari preformati nelle memorie neurobiologiche, macchinali, etc., ma sorprendono perché aprono effetti, creativi e non prevedibili, sul- la qualità delle relazioni interpersonali. Sono sempre fonte di in- certezze, imputabili alle intenzioni, personali e mutevoli, di un io che incontra un altro io, un tu.
La ragione dialogica e la ragione giuridica si illuminano nel- l'universalità delle dimensioni formative della peculiare condizio- ne umana e simultaneamente hanno senso nell'esercizio di un Scanned with CS CamScanner"pensiero e di una volontà che appartengono ad una singola perso- na, non anticipabile nella libertà di scelta delle sue condotte e nel- le originali motivazioni che le qualificano.
Si accende così l'attenzione sulla creatività = incertezza delle relazioni umane, che inquieta ma conferisce luce al salto di quali- tà che separa l'umano dal non-umano, l'originalità dal funziona- mento seriale, impersonale. Si allude all'incertezza del divenire delle relazioni dialogiche e giuridiche, che esigono l'istituzione delle norme, concepite per dare certezza e durata al relazionarsi, e che rinviano a dei principî, sia nell'essere istituite, sia nell'essere applicate.
Visioni dei principi
Si apre qui l'alternativa davanti a distinte visioni dei principi. Si può pensare ai principî generali di un diritto oppure ai principî generali-universali del diritto. I primi sono principî intrasistemici, i secondi sono principî oltresistemici. Rispettivamente, quelli intra- sistemici sono principî generali particolari, quelli oltresistemici so- no principî generali universali.
Quest'ultima distinzione si chiarisce riprendendo il legame tra ragione giuridica e ragione dialogica. Il rinvio a queste due moda- lità della ragione sorge perché ci si riferisce sia all'incertezza delle relazioni umane, sia alla non meccanicità dell'applicazione delle norme giuridiche, istituite per il superamento di una tale incertezza.
Incertezza nelle relazioni interpersonali
I fenomeni fisici, chimici, biologici, macchinali, etc., possono presentare delle incertezze nei processi di svolgimento delle loro operazioni, ma non si tratta di nulla che possa essere avvicinato all'incertezza propria delle relazioni interpersonali.
Nell'ordine del non-umano, l'incertezza è solo apparentemente tale, perché tutto è regolato sia dalla necessità, sia dalla composi- zione contingente di una molteplicità di elementi. Mai si presenta qui alcunché di appartenente ad una incertezza riferibile all'eser- cizio del pensiero e della volontà non precalcolabili di una persona, alla libertà di scelta delle sue condotte, che incidono sulle altre persone e sulle istituzioni di una comunità.
Nel non-umano accadono dei fatti, mai degli atti e pertanto non vi è alcuna domanda sulla legalità o non legalità, sulla giusti- zia o sull'ingiustizia, centrate sulla creatività-imputabilità degli atti del pensare e del volere, assenti nei fatti delle cose, dei vegetali, degli animali, delle macchine, etc. Segue che non vi può essere Scanned with CamScanner" CSalcuna differenza tra norme e principî generali, che si presenta nell'unità-distinzione tra legalità e giustizia.
Relazione dialogica e principi generali
Riprendendo le tesi di Buber sulla relazione dialogica, si coglie che le singole norme ed i principî generali fanno riferimento alla presenza, nella persona, di dimensioni inevitabili ed irriducibili: l'io incontra l'altro nei due ambiti del tu e dell'esso. Le fattispecie costitutive del contenuto delle norme riguardano una definizione oggettivante delle condotte umane; incontrano la persona come un esso, descritto in forme oggettive. Nel processo di applicazione delle norme al singolo caso umano, interviene l'arte dell'interpre- tazione, che impegna il magistrato nell'incontrare quella singola persona, nella sua volontà e nel suo pensiero, nell'essere quel tu unico, 'chi' di intenzioni, e non un esso generico, 'portatore' di inclinazioni fisico-chimiche, neurobiologiche, etc.
In Buber si legge questo interrogativo: la cosiddetta «grandez- za plasmatrice dell'uomo di stato e dell'imprenditore di primo piano non sono proprio legate al fatto di non guardare gli uomini con cui hanno a che fare come portatori del tu che non si lascia sperimentare, ma come centri di produzioni e di aspirazioni che vale la pena tenere in conto e utilizzare nelle loro specifiche capa- cità?»1 Gli uomini sono da 'usare', sia pure legalmente, come en- tità oggettivate nelle modalità di un 'esso'?
Questi interrogativi hanno un inizio di risposta nel considerare che il fenomeno sociale del diritto concerne esclusivamente l'umanità, nei due versanti non separabili del tu - soggetto di atti - e dell'esso - entità oggettivata nei fatti -.
«La vita comune dell'uomo non può fare a meno del mondo dell'esso come non lo può l'uomo singolo ... [gli uomini] nella vita collettiva non fanno niente di diverso da ciò che [fanno] nella vita personale ... pur sapendosi incapaci di realizzare schietta- mente il tu, lo attestano ogni giorno nell'esso ... Non conta che sia lo stato a regolare l'economia o l'economia a regolare lo stato, intanto che entrambi rimangono quelli che sono. È importante che l'istituzione statale diventi più libera e quella economica più giusta ...; non possono diventare da sé liberi e giusti. Questo è Scanned with CamScanner" CSdecisivo: se lo spirito capace di dire tu e di rispondere rimane vi- tale e autentico» 2.
Le analisi di Buber sulle figure dell'altro, presentate nelle di- mensioni del tu oppure dell'esso, consentono di approfondire quel che connette e scinde i due versanti della giuridicità: le nor- me istituite in un ordinamento ed i principi generali-universali del diritto, che, come si sostiene qui, costituiscono la genesi sia del- l'attività legislativa sia dell'opera della magistratura.
I principî generali del diritto sono ripresi e ridiscussi, in una chiarificazione originale, ogni volta che si attiva la relazione dia- logica, avente una sua centrale presentazione nel dibattimento processuale. Qui, nel rispetto della legalità, delle norme poste dal legislatore, ci si trova davanti alle molteplici possibili direzioni del- l'opera interpretativa, dell'arte ermeneutica del 'comprendere' (Ga- damer). Il dialogo sulle norme viene illuminato dal dialogo sui principî generali, riproponendo la struttura della ragione dialogi- ca, nucleo della ragione giuridica.
Qualificazioni del dialogo
Buber descrive tre qualificazioni del dialogo: il dialogo autenti- co, il dialogo tecnico ed il dialogo trasformato in monologo.
Il dialogo autentico è tale perché «ciascuno dei partecipanti in- tende l'altro o gli altri nella loro esistenza e particolarità e si rivol- ge loro con l'intenzione di far nascere tra loro una vivente reci- procità», illuminata dal principio di uguaglianza, che garantisce la pienezza armonica di una coerente realizzazione giuridica del principio dialogico, superando la disarmonia della sproporzione.
La qualificazione del dialogo tecnico comporta che i dialoganti spengano la loro ricerca del senso, raggiungendo così una «intesa oggettiva», propria della verificabilità scientifica, della sperimen- tazione traducibile in formule numerico-matematiche, modellate sugli schemi della tautologia: 'A è A'.
Il terzo tipo di dialogo è quello che Buber designa come 'mo- nologo travestito da dialogo'; qui viene svuotata l'attesa dell'origi- nalità del dire concepito dall'altro; segue che «ciascuno considera se stesso assoluto e legittimo e l'altro relativo e discutibile»3, ne- Scanned with CamScanner" CSgando il luogo essenziale dell'imparziale terzietà del principio ge- nerale-universale di uguaglianza.
La ragione del principio dialogico mostra la sua connessione con la ragione giuridica, chiarendo che la modalità principale del dialogo, descritta da Buber, è quella che, affermandosi come for- mativa della reciprocità dei dialoganti, si concretizza, nelle relazio- ni interpersonali, secondo la direzione del principio di uguaglianza incondizionata ed universale. Questa prima modalità del dialogo è tale perché non si arresta o non cade nel dialogo tecnico oppure nel dialogo trasmutato in un monologo.
Il dialogo tecnico, riferito al fenomeno del diritto, si esaurisce in una conoscenza logico-formale delle norme, in una loro esecu- zione di stampo macchinale, tautologico-matematico, e, concre- tizzandosi così, non accede ad una piena accoglienza dei principî generali del diritto oppure li riduce a principî generali di un dirit- to positivo. Su questa via, il dialogo si trasmuta nel monologo ese- cutivo di un ordinamento, insensibile al prendere atto che qual- siasi ordinamento non serve all'ordinamento ma all'umanità, nella sua condizione universale, eccedente i confini di tutti gli ordina- menti e raffigurabile nella concezione di Kant sulla 'comunità co- smopolitica'.
I principî generali del diritto operano presentandosi come 'il- limitato contenuto del limite', ricordando qui una espressione di Buber. Questa espressione afferma l'essenzialità del limite e si- multaneamente ne indica il contenuto come illimitato: i principî generali costituiscono un limite, ma rispettano la capacità umana di concepire l'illimitato contenuto della creazione del senso, che genera sia fattispecie sempre nuove, sia le interpretazioni ed i giudizi che vi corrispondono, nel rispetto dei diritti inalienabili della persona.
Il nucleo del fenomeno giuridico è costituito dal giudizio del magistrato, che può formarsi secondo tre distinte qualificazioni- trasformazioni del dialogo: a) la pienezza del dialogare tra le parti del processo, b) la riduzione del dialogo ad un sapere tecnico con- cernente la cieca funzionalità, logico-formale, delle norme, oppu- re c) il monologo che identifica il giudizio con l'imposizione di un comando.
La ragione dialogica e la ragione giuridica si chiariscono recipro- Scanned with CamScanner"