Logica e Ontologie: rappresentazione della conoscenza nell'Intelligenza Artificiale
Documento di Università su Logica e Ontologie. Il Pdf, utile per lo studio dell'Informatica a livello universitario, esplora l'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale, focalizzandosi sulla logica e le ontologie per la rappresentazione della conoscenza.
See more12 Pages
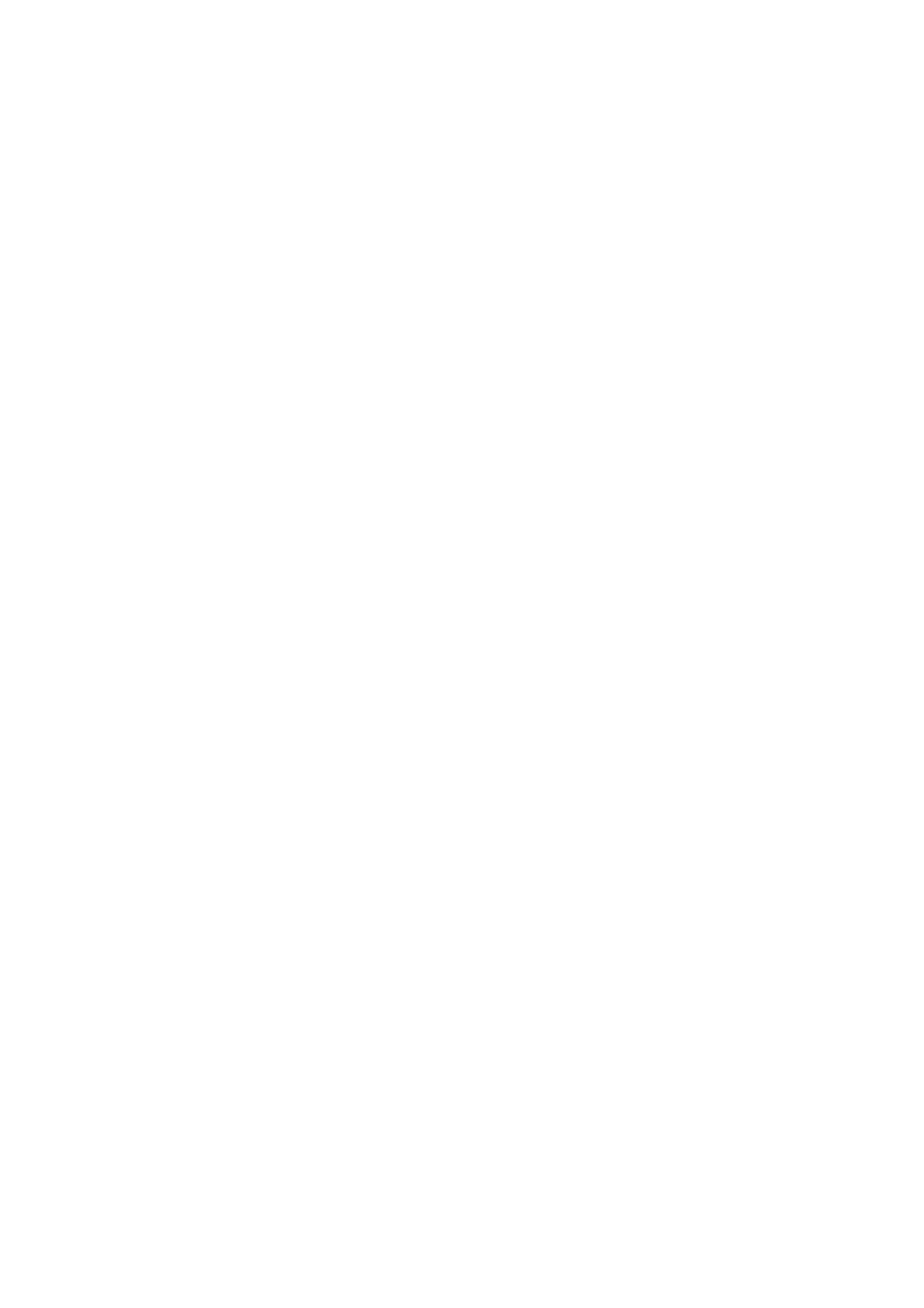

Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
L'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale
A partire dal primo Inverno dell'IA, il modo stesso in cui i ricercatori pensavano all'intelligenza artificiale dovette cambiare rapidamente in conseguenza ad una analisi dei problemi che fino a quel momento non si erano potuti superare. Difatti, quando il termine Intelligenza artificiale venne varato, durante la famosa conferenza di Dartmouth, la fiducia dei pionieri della disciplina, dei suoi fondatori, riguardo i progressi che si sarebbero visti negli anni immediatamente a venire era smisurata e superava di gran lunga la realtà. Lo sviluppo rapido dei calcolatori a partire dalle ricerche effettuate durante la seconda guerra mondiale e i progressi ancor più rapidi che si erano visti negli anni immediatamente precedenti alla conferenza e che avevano spinto, in qualche modo, i quattro padri dell'IA a convocare i due mesi di studio di cui si parla nel manifesto di Dartmouth, avevano illuso non solo gli addetti ai lavori ma anche governi, imprenditori e semplici appassionati, riguardo le reali possibilità di raggiungere il sogno della macchina pensante.
Al venir meno dei risultati e dell'interesse e al nascere di un sentimento di disillusione generale nei confronti della materia da parte di addetti ai lavori, ma, anche e soprattutto da parte di chi osservava dall'esterno, corrispose una reazione rapida e decisa che favorì una profonda analisi delle cause del fallimento e la rapida ripresa delle ricerche sotto il segno di nuovi paradigmi e nuove tecniche che, in molti casi, non facevano altro che riprendere idee ancora più antiche.
Fino a quel momento, infatti, l'Intelligenza Artificiale si era limitata ad esplorare domini astratti e semplificati come i giochi, non tenendo in conto che la simulazione di un comportamento intelligente, del ragionamento, non era indipendente dalla rappresentazione che il cervello artificiale avesse del mondo in cui avrebbe dovuto operare. Il legame tra il ragionamento e la rappresentazione era più stretto di quanto non si fosse immaginato, come sottolineo H. Simon nel suo The Sciences of theArtificial1 quando disse che "risolvere un problema significa semplicemente rappresentarlo di una maniera tale che la soluzione appaia trasparente."
Il ragionamento deve necessariamente basarsi su di una buona rappresentazione della conoscenza a cui fa riferimento, e i modi di rappresentarla sono legati ad un linguaggio simbolico e alle regole che permettano di manipolare le strutture sintattiche di questo linguaggio.
Il settore dell'IA conosciuto come Rappresentazione della conoscenza ha proposto diversi tipi di linguaggi adatti all'immagazzinamento di tali informazioni e, partendo dalla logica, passando poi per le reti semantiche e i frame, il ragionamento di tipo probabilistico e le logiche sfumate, cercheremo di descriverne le caratteristiche nelle prossime pagine.
La logica
Fin dagli albori dell'IA la logica è stata considerata uno strumento privilegiato per la rappresentazione della conoscenza: nata migliaia di anni prima, in quanto linguaggio simbolico atto alla descrizione formale dei meccanismi del ragionamento umano, la logica è entrata di diritto tra le tecniche basilari dell'intelligenza artificiale.
Una delle caratteristiche principali della logica sta nel fatto che si occupa esclusivamente di ragionamento deduttivo, cioè di un tipo di inferenza che conserva sempre la verità delle premesse. Altri tipi di ragionamento assolutamente legittimi nella natura del pensiero umano come il ragionamento induttivo (nel quale la conclusione è una generalizzazione delle informazioni contenute nelle premesse) o il ragionamento abduttivo (nel quale la conclusione cerca di spiegare i fatti esposti delle premesse) o il ragionamento per default (in cui si arriva ad una conclusione sulla base 1 H. Simon, The Science of Artificial, MIT Press, 1996.di informazioni non del tutto esatte riguardanti una classe di oggetti nella loro accezione più comunemente accettata) non sono rappresentabili attraverso il linguaggio della logica standard.
Inferenza logica e proposizionale
Una delle forme più semplici di inferenza logica è espressa attraverso l'uso della logica proposizionale: in questo tipo di ragionamento, una proposizione atomica (del tipo "il cielo è grigio") è rappresentata da una lettera proposizionale, e questi atomi possono essere combinati tra loro tramite l'uso di alcuni connettivi proposizionali formando espressioni che vengono chiamate formule proposizionali. Per quanto riguarda i connettivi, possiamo incontrare:
- La negazione (-): data una formula A, se A è vera allora -A sarà falsa. La negazione è un connettivo ad un solo argomento in quanto si applica ad una formula per volta.
- La congiunzione (A): è un connettivo a due argomenti che collega tra loro due formule ricordando la "e" del linguaggio naturale. Logicamente si considera che perché A A B sia vera, sia A che B devono essere vere; in ogni altro caso è falsa.
- La disgiunzione (v): riconducibile alla "o" del linguaggio naturale inteso in senso inclusivo, è un connettivo a due argomenti per cui una formula A v B è vera nel caso che almeno una tra A e B sia vera.
- Il condizionale (->): in linguaggio naturale è riconducibile al "se ... allora" e A->B assume il significato di "non si dà il caso che sia vera A e falsa B" che indica che A->B è vera in tutti i casi a parte quando A è vera e B è falsa.
Per rendere la logica adatta ai sistemi di calcolo elettronici, generalmente si utilizza un tipo di regola di inferenza detta regola di risoluzione che è applicabile a formule che, tanto nelle premesse come nella conclusione, adottano una particolare forma detta "a clausole".
Nella logica dei predicati del primo ordine è possibile rappresentare la struttura interna delle proposizioni atomiche: abbiamo, dunque, costanti individuali (espresseda lettere minuscole dell'alfabeto), che rappresentano i singoli oggetti del dominio, e i simboli predicativi che sono i predicati che si applicano a tali oggetti (espressi da lettere maiuscole). I predicati possono essere ad un argomento (si parla in questo caso di proprietà) o a più argomenti (relazioni) e le formule atomiche sono collegate tra loro dagli stessi connettivi proposizionali visti in precedenza.
Inoltre, rispetto alla logica proposizionale, è importante sottolineare la presenza di variabili individuali (in genere si esprimono utilizzando le ultime lettere dell'alfabeto in minuscolo), cioè individui generici del dominio, e dei quantificatori: il quantificatore universale "per ogni" che in un'espressione del tipo XA (Cane(x)->Mammifero(x)) indica "per ogni generico individuo x, se x è un cane, allora x è un mammifero" o, in altri termini "tutti i cani sono mammiferi"; ed il quantificatore esistenziale, "esiste almeno un x tale che ... " che interpreta una formula come Ex (Cane(x) ^ Nero(x)) come "esiste almeno un individuo x, tale che x è un cane e x è nero", cioè "qualche cane è nero". I due quantificatori sono, tra l'altro, interdefinibili, per cui è possibile affermare che Vx(Uomo(x)->Mortale (x)) equivale a -By-(Uomo(x)->Mortale(x)) e Ey(Cane(y) ^ -Nero(y)) equivale a -Vy-(Cane(y) A -Nero(y)).
Altri tipi di logiche
Tradizionalmente, quando parliamo di logica (proposizionale o dei predicati) ci riferiamo ad un tipo di ragionamento monotono, il quale prevede che con l'aumentare delle premesse sia possibile derivare nuove conclusioni, ma mai scartare conclusioni che già sono state derivate.
Questo tipo di ragionamento appare adeguato in alcuni casi, mentre in molti altri, spesso in applicazioni realistiche, con informazioni incomplete e situazioni che mutano, non è adeguato.
Nella maggior parte dei casi reali è impossibile disporre di un'informazione completa, e diventa necessario, per questo, fare alcune ipotesi di buon senso, valide finché non si riscontri un'evidenza contraddittoria. Questo tipo di ragionamento, di tipo non-monotono, è chiamato ragionamento per default (cioè ragionamento in difetto di informazioni specifiche). Anche il ragionamento induttivo e quello abduttivo sono tipi di ragionamento non-monotono e si adattano, come per il ragionamento per default, a situazioni reali dove le informazioni non sono esaustive e l'ambiente è variabile.
A partire dalla fine degli anni '60 si è cercato di sviluppare modelli logici strutturati che, pur condividendo con la logica una parte del loro linguaggio, contenevano informazioni sulla struttura concettuale dei concetti rappresentati. Rientrano in questa classe alcuni tipi di reti semantiche: i primi lavori sulle reti semantiche furono improntati ad un approccio di tipo psicologico e linguistico in quanto formalismi in grado di rappresentare in maniera migliore il modo in cui la mente umana immagazzina informazioni di tipo semantico, per rappresentare il significato lessicale di termini del linguaggio naturale ed effettuare inferenze a partire da questa rappresentazione. Il primo a presentare un sistema di questo tipo fu Quillian (1967-68) con una rete dove esistevano due tipi di nodi: type node e token node: i nodi tipo rappresentavano il significato lessicale di ogni voce e ad ogni type node corrispondeva un plane, cioè una struttura che rappresenta la descrizione del significato corrispondente. Dato che per ogni voce lessicale possiamo avere differenti significati, per ogni voce era possibile trovare type distinti.
Come in un dizionario, inoltre, ogni significato può essere espresso utilizzando altre voci: i token non sono altro che rimandi ad altri type nodes della rete che possano spiegare il significato della voce in analisi.
Gli archi che esprimono le relazioni tra i token di un piano possono rappresentare relazione di tipo sottoclasse, di disgiunzione, di congiunzione, indicare come un token può modificare avverbialmente o come aggettivo un secondo token (queste relazionisi chiamano modification pointer), indicare relazioni arbitrarie fra due token utilizzando un terzo token che esprime il tipo di relazione che tra essi sussiste.
Reti semantiche moderne
Il tipo di rete descritto da Quillian è un antenato abbastanza prossimo delle reti semantiche moderne:
animale polmone organo respiratorio sostegno del corpo scheletro interno mammifero latte alimento dei cuccioli umano animale domestico padrone cane spaniel cane domestico elsa bassotto padrone fido Immagine 1 come nel modello di Quillian, una rete semantica è un grafo orientato in cui sono presenti dei nodi che rappresentano concetti e degli archi che rappresentano le relazioni tra i concetti. Quelle che in Quillian chiamavamo relazioni di sottoclasse sono chiamate nelle reti semantiche relazioni IsA (dall'inglese "is a") o ako ("a kind of").
Un buon esempio di rete semantica (tratto da Burattini e Cordeschi, 2001), è presentato sopra (immagine 1): in questa rete abbiamo dei nodi che rappresentano concetti generici, come ad esempio il nodo mammifero o cane, e nodi che rappresentano concetti individuali (o istanze) come fido o elsa. Abbiamo archi di tipo isa, rappresentati dalle frecce in neretto, detti anche archi di sussunzione; archi che rappresentano attributi di un concetto generico, rappresentati da frecce nere sottili e che rappresentano attributi di un concetto (come ad esempio l'avere un certo sostegno del corpo), caratterizzati da un altro concetto (come, nello stesso caso, uno scheletro interno); archi di istanziazione, detti anche archi ako, che collegano concetti generici con esemplari individuali, istanze, di tale concetto (fido, per esempio, è un'istanza di cane domestico) e, in fine archi che rappresentano attributi di concetti individuali, che sono l'istanziazione degli attributi di tipo generico.
Grazie agli archi di sussunzione è possibile esprimere relazioni di ereditarietà, cioè fare in modo che un concetto collegato da un arco isa ad un altro concetto (cane